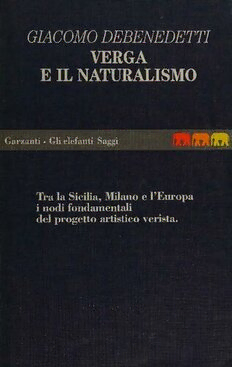Table Of ContentGIACOMO DEBENEDETTl
VERGA
E IL NATURALISMO
Garzanti • Gli elefanti Saggi
Tra la Sicilia, Milano e l’Europa
i nodi fondamentali
del progetto artistico verista.
»
I
gli elefanti
Dello stesso autore:
// romana del Novecento
Poesia italiana del Novecento
Pascoli: la rivoluzione inconsapevole
Quaderni di Montaigne
Giacomo Debenedetti
Verga e il naturalismo
Prefazione di Nino Borsellino
Garanti
In questa collana
Prima edizione: settembre 1993
ISBN 88-11-67427-1
©Garzanti Editore s.p.a., 1991
Printed in Italy
Prefazione
Nel ventre della balena
La pubblicazione postuma nel 1976 dei quaderni delle lezio¬
ni che Giacomo Debenedetti dedicò a Giovanni Verga, in due
corsi accademici svolti a Messina tra il 1951 e il ’53, fu una sor¬
presa, se non ricordo male, per il pubblico della critica lettera¬
ria. Esiguo quanto si vuole nel mercato librario, esso era però
in continua crescita per l’opera del grande saggista dopo l’inau¬
gurazione nel ’71 della serie degli inediti col più fortunato tra
tutti. Il romanzo del Novecento, da tempo anche collaudatissimo
testo d’adozione universitaria. Altri nomi, non il Verga, veniva¬
no di solito evocati per i suoi interessi di «contemporaneista»:
quello di Pirandello, tra gli insulari, e tra i continentali soprat¬
tutto quelli di Saba, Svevo e Tozzi, per limitarci alle competen¬
ze novecentiste del professore. Gli uditori di allora, i suoi scola¬
ri di qua e di là dello Stretto, avranno conservato il ricordo di
quelle lezioni certo indimenticabili e qualcuno avrà risentito
sulla pagina scritta il recitativo suadente, lo stile vocale di quel
cinquantenne subalpino, da molto però, come il suo Alfieri,
spiemontizzatosi. Ma gli altri? «Lui vivo, soltanto i suoi studenti
possono aver saputo che esisteva un Debenedetti così», ha do¬
vuto ammettere un suo penetrantissimo lettore abituato a gio¬
care d’anticipo rispetto alla norma dei professionisti della lette¬
ratura, e quasi in fuorigioco.’ Ma come così? Alla fine del ’54
non s’erano letti i Presagi del Verga, un saggio che condensa la
materia fluida che scorre senza argini nei quaderni siciliani?^
In realtà quell’articolo ne condensa solo una minima parte,
per giunta controllando che la discorsività di una diagnosi psi¬
cologica ben circoscritta filtrasse il grumo della questione ver-
1 Cfr. Marzio Pieri, Fischiata XXXIII. Un sonetto di Giambattista Marino,
Parma 1992. Si vedano nella conversazione con Luciana Saetti le pagine
(126-29) dedicate al «corpo a corpo» di Debenedetti con il testo.
2 Pubblicato in «Nuovi Argomenti», 11, nov.-dic. 1954, pp. 87-103; poi in
Saggi critici, ni serie, Milano 1959, pp. 215-31.
Ili
ghisna centrale, la conversione dal tardo romanticismo al veri¬
smo, senza straripare di là da una localizzazione biografica del
tema. Nei Presagi Debenedetti sviluppa la domanda che si pone
all’inizio del primo corso: perché Verga da anziano nel 98
sconfessasse pubblicamente tra tutti i suoi romanzi giovanili di
successo solo Una peccatrice, non Storia di una capinera, Èva,
Eros, Tigre reale, altrettanto «macchiati» dal narcisismo del pro¬
tagonista e dello stesso autore, anche quando si fa doppiare,
per non compromettersi con quelle torbide vicende, da narra¬
tori confidenti.* Evidentemente non si trattava di un ripudio
globale, di tutta la produzione pre-verista e deir«innaturale»
esasperazione passionale che vi è dovunque esibita. Secondo
Debenedetti la sconfessione rivelava un residuo disagio esisten¬
ziale e insieme letterario nei confronti del primo titolo, ancora
catanese, della cinquina romanzesca completata in un decen¬
nio fervido di attività compositiva tra Firenze e Milano. «In Una
peccatrice», dichiara, «stava scritta, fatale, pesante, cifrata ma in¬
derogabile come in un oroscopo, la storia di Giovanni Verga ar¬
tista». Ma poi aggiunge: «Naturalmente il Verga non sapeva, o
sapeva male che cosa gli raffigurasse la storia di Una peccatrice.
Probabilmente ne provava solo un oscuro malessere, un senso
come di vergogna sotto specie di rimorso letterario: quanto ba¬
stava per avvertirlo, senza un esatto perché, che era meglio non
parlarne più». Infatti quell’oroscopo non s’era realizzato. Esso
era contenuto nella storia del giovane scrittore che seduce col
successo letterario una vamp dei salotti aristocratici prima per
lui irraggiungibile, ma poi l’abbandona, quando è lei ad essere
condizionata da quel rapporto, al punto da consumarsi con la
droga. Il protagonista si chiuderà nella sua mediocrità borghe¬
se di artista fallito; Verga invece avrà successo; ma quando Una
peccatrice fu ristampata senza il suo consenso, quasi a trent’anni
di distanza dalla prima edizione, egli leggerà nel fallimento del
giovane scrittore catanese il fallimento del suo programma
3 La sconfessione di Una peccatrice è contenuta in una lettera di Verga al¬
l’editore Treves pubblicata neir«Illustrazione Italiana» del 24 aprile 1898
per rispondere a varie critiche per la ristampa del romanzo giovanile. L’a¬
veva ristampato cinque anni prima, nel 1893, l’editore Giannetta di Cata¬
nia senza autorizzazione dell’autore, il quale già nel luglio di quell’anno lo
sconfessava, deplorando l’iniziativa editoriale, in una lettera al Negro, pri¬
mo editore a Torino del romanzo. Si tenga conto che la fonte biografica di
Debenedetti è la Vita di Giovanni Verga di Nino Cappellani, Firenze 1940.
IV