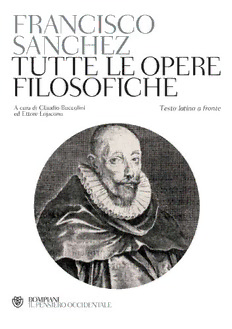Table Of ContentQuest’opera è stata realizzata in collaborazione con il Centre for
Science, Philosophy and Language Research della Fondazione
“Arnone – Bellavite Pellegrini”.
FRANCISCO SANCHEZ
TUTTE LE OPERE FILOSOFICHE
Testo latino a fronte
A cura di Claudio Buccolini e Ettore Lojacono
con la collaborazione di Claudia Montuschi
per il Carme sulla cometa
BOMPIANI
IL PENSIEROOCCIDENTALE
ISBN 978-88-58-76191-5
© 2011 R.C.S. Libri S.p.A., Milano
I edizione digitale Bompiani
Il Pensiero Occidentale gennaio 2014
ETTORE LOJACONO
LA COSCIENZA DEL NULLA
E LA VOLONTÀ DI COSTRUIRE
UN ‘NUOVO’ SAPERE
A Fiorenza, a Franca, a Gian Maria
il mio ultimo lavoro
O quantum est hominum, qui etiam,
quae nesciunt, sciunt.1
1. PER UN GIUDIZIO LIBERO, MA NON SENZA RAGIONE
Sanchez è stato detto uomo di scienza e di collegio2: certo, è
vissuto per la scienza, è stato condizionato dall’insegnamen-
to ricevuto3 e ha nutrito massima ambizione ad esercitarlo
secondo nuove prospettive, specie nel campo della medici-
1Si legge sul frontespizio dell’ed. del QNSuscita a Francoforte nel 1618:
«O quanti sono gli uomini che sanno anche le cose che non sanno».
2 CH. BATHOLMESS, Huet évéque d’Avranches ou le scepticisme théolo-
gique, Paris, Frank, 1850, p. 168.
3Sanchez ha studiato dal 1562 al 1569 al Collège de Guyenne, organizza-
to nel 1534 dal portoghese Andrea Goveanus (Gouvea). In questo collegio
aveva studiato dal 1540 al 1546 Michel de Montaigne, che ne parla nel cap.
XXVI del I lib. dei suoi Essais, pp. 174-176 (cit. da Oeuvres complètes, textes
établis par A. THIBAUDETet M. RAT, Paris, Gallimard, 1962), offrendoci noti-
zie preziose. Il Goveanus, che lasciò Bordeaux per Coimbra nel ’47, fu natu-
ralmente anche l’autore del programma d’insegnamento del Collège, ma non
ne lasciò traccia scritta: esso fu poi redatto dallo spagnolo Ionnanis Gellidius
e da Elie Vinet ed è stato pubblicato alla fine del secolo scorso da L. MAS SE -
BIEAU(Schola Aquitanica, Auctore A. Goveano, Elias Vinet edidit, Burdigalae,
apud S Millangium, 1583, ma cfr. anche Schola Aquitanica, Programme d’étu-
des du collège de Guyenne au XVI siècle. Réimprimé avec une préface, une
traduction et des notes par LOUIS MASSEBIEAU, «Musée Pédagogique et
Bibliothèque de l’Enseignement primaire», fasc. N. 7, Paris, chez Delagrave
et Hachette, 1886). Nel collegio corse una notevole tensione tra il Gellidius
che, seguendo Lefèvre d’Etaples, non sembrava particolarmente entusiasta
della filosofia scolastica e Antonius Goveanus (fratello di Andrea), fervente
aristotelico, oppositore di Pietro Ramo, tanto che nel 1543 fu chiamato a
Parigi da Francesco I proprio per contrastare l’insegnamento ramista (cfr. W.
J. ONG, Ramus, Method and the Decay of Dialogue, Cambridge (Mass.),
Harvard University Press, 1958, pp. 216-220 e 222). È assai probabile che
l’eco di una tale polemica non fosse spenta negli anni in cui Sanchez visse a
Bordeaux. Scorrendo il programma si nota la grande parte che nell’insegna-
mento avevano Cicerone ed altri classici latini; Aristotele era letto in greco e
VIII ETTORELOJACONO
na, ma la sua azione ha tratto ispirazione da ambiti ancora
più vasti. Nonostante teoricamente abbia mostrato disdegno
verso la retorica e la poetica4, possiamo considerarlo umani-
sta nel senso lato del termine: lo mostrano le sue opere, e
non solo il Carmen de Cometa, la sua scrittura, che spesso
richiama miti, metafore, paragoni5, il valore che assegna so -
vente alle favole di Esopo e di Fedro, le amicizie che ha col-
tivato, come quella fedelissima con Diego de Castro, lettera-
to e poeta, nonché, infine, la stima in cui ha tenuto Ludovico
Vives6.
Medico, ha effettivamente esercitato la professione, è
stato a contatto con gente comune, ha fatto diretta esperien-
za dell’umana sofferenza, quindi, più di ogni suo contempo-
raneo, ad eccezion forse di Pietro Ramo, ha avvertito l’esi-
genza di orientare l’umanesimo verso un ‘altro’ sapere, che
tuttavia non riusciva a determinare positivamente: questo
suo primo trattato ne è precisa e sofferta testimonianza.
I primi scritti, il Carmen de Cometa e il QNS, si pongono
come introduzioni a un programma ch’egli intende portare a
compimento: molto di quanto ha lasciato intravvedere nel
Carmen de Cometa è ampiamente trattato nei suoi commenti
ai testi aristotelici (De divinatione per somnum e In Librum
[...] Physiognomicon commentarius), mentre quel che aveva
gli studenti vi tenevano particolarmente, tanto che quando si tentò di legger-
lo in latino si scatenarono sommosse. Tra gli insegnanti che diedero un’im-
pronta a questa scuola ricordiamo Elie Vinet, Marcus Antonius Muretus, Ni -
colas Grouchy. Sulla storia del Collège de Guyenne cfr. ERNESTGAULLIEUR,
Histoire du Collège de Guyenne, Paris, Sandoz et Fischbacher, 1874.
4Cfr. QNS, p. 23.
5Tra le innumerevoli metafore che ricorrono nelle sue opere, ricordiamo,
a mo’ di esempio, il nulla come suo vessillo (p. 19), le parole presentate come
soldati schierati a battaglia (p. 23), il raffronto tra Aristotele degli El. Sof.e i
negromanti (p. 29), l’allievo del maestro autoritario considerato come «un
soldato che segue il condottiere dovunque lo tragga» (p. 191). Notiamo che
curiosamente gran parte delle metafore sancheziane si richiamano alla vita
militare.
6Si ricordi come ne prende le difese contro Scaligero che lo aveva attac-
cato: cfr. QNS, p. 127 e n. 238.
LACOSCIENZADELNULLA IX
promesso nel QNSè stato poi svolto nell’Examen rerum7, che
purtroppo non ci è pervenuto, nonché in alcuni passi partico-
larmente significativi del De longitudine et brevitate vitae, la sola
sua opera che riprenda e citi direttamente il primo trattato.
Più che uno scritto meramente teorico, il QNS ci appare
però una confessione o, meglio, un saggio in forma di con-
fessione, di autobiografia, che rivela la personalità dell’auto-
re, non documentata da alcun altro testo, se non dalla lette-
ra a Clavio8 e, assai sporadicamente, da non rari tratti delle
altre opere, anche di quelle mediche. Questo passo: «Perché
scrivo? Che ne so? Stolto sarai con gli stolti. Sono uomo: che
fare?»9ci pare momento illuminante della tendenza autobio-
grafica del QNS, ove Sanchez appare imbrigliato in una con-
traddizione che lo trascende, in una crisi ineluttabile, perché
trae origine dal rifiuto dell’intera cultura nella quale si è for-
mato e che lo ha radicalmente ingannato, non ponendolo in
condizione di operare con sicurezza in alcun ambito scienti-
fico e tanto meno in quello cui più teneva, cioè la medicina:
nulla posso cogliere perfettamente [...]. La nostra condizio-
ne è da commiserare, siamo ciechi in piena luce.10
Non dimentico della sua storia personale, privata, tiene a
farla conoscere al lettore, assegnandole evidentemente valo-
re emblematico:
7 Cfr. bibliografia, dove abbiamo riportato le numerose opere che San -
chez si era ripromesso di scrivere, ma che non possediamo, o perché perdu-
te o perché rimaste allo stato progettuale.
8 Documento fondamentale, in cui Sanchez accenna alle scelte teoriche
successive alle posizioni della sua prima giovinezza, tra cui riveste particolare
importanza il suo distacco dalla matematica: infatti in questa lettera, dopo
aver raccontato che, deluso dalla fisica e dalla metafisica, aveva pensato che
quella, in quanto ambito intermedio fra le cose naturali e le sovrannaturali,
avrebbe potuto permettergli di cogliere qualche segno di verità, confessa di
non aver trovato certezza neppure nel suo ambito; assai spesso infatti – così
vi afferma – i sensi non sono ad essa sufficienti e molti suoi principi appaio-
no in disaccordo con quelli che si pongono a fondamento della scienza natu-
rale. Cfr. CE, infra, pp. 508-539.
9QNS, p. 65.
10Ivi, pp. 9 e 135.
X ETTORELOJACONO
Come però ho volto lo sguardo alle cose, rigettata total-
mente la mia precedente credenza e non scienza, ho inizia-
to ad esaminarle come se mai fosse stato detto alcunché da
chicchessia.11
Lo sguardo teso alle cose gli ha aperto la mente al dub-
bio, cioè alla ricerca che non si quieta in sé: dal dubbio, dalla
non accettazione del sapere costituito, s’inizia quindi la sua
autentica vita di studioso, condotta con pervicacia nel sacri-
ficio e nel dolore, di cui ci fa partecipi con toni particolar-
mente enfatici:
Questa la fine dei nostri studi, questa la ricompensa di
un lavoro inutile e senza frutto: veglie ininterrotte, fatiche,
preoccupazioni, sofferenze, solitudine, privazione di ogni
piacere, una vita simile alla morte. [...] Di qui le malattie,
spesso il delirio, sempre la morte.12
Mai tuttavia ha ceduto alla cultura in cui non credeva:
A me sarebbe più o meno accaduta la stessa cosa se, aiu-
tato dai ‘canti’ di Ulisse, non avessi evitato le figure circee
dei sillogismi, ammalianti signore del ponte.13
Era convinto che la ricerca sarebbe potuta essere più frut-
tuosa se condotta da più menti14 ma, avversato dai dotti, è
stato costretto a condurla individualmente, nella difficile
dimensione del ‘privato’, annotando nel contempo le ragio-
ni della impossibilità di pervenire ad esiti certi: in ciò ha
identificato il suo essere uomo, cioè scienziato appassionato
e spettatore (filosofo) del suo insuccesso.
Nella filosofia ha cercato certezze per l’esercizio della sua
professione e, pur certo di non sapere, da una parte non ha
mai rinunciato alla vocazione avvertita sin dalla prima età15
11Ivi, p. 215.
12Ivi, p. 119.
13Ivi, p. 195.
14Ivi, p. 15: «Un branco di cani infatti caccia la preda più facilmente che
uno solo».
15Ivi, p. 9: «Dalla mia prima età, votato alla contemplazione della natura,
scrutavo ogni cosa minutamente».