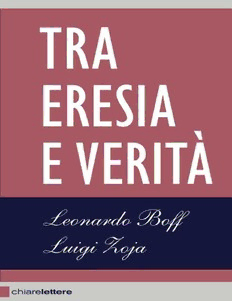Table Of ContentPresentazione
L’avventura umana e spirituale di uno dei padri fondatori della teologia della
liberazione. L’infanzia in Brasile, figlio di una famiglia di migranti veneti. Il
genocidio degli indios visto in prima persona. La violenza delle dittature
militari e le complicità della Chiesa. In questa conversazione con lo
psicoanalista Luigi Zoja, Leonardo Boff traccia il ritratto di una stagione
feroce, rivela scenari inediti dietro la censura vaticana e la sua condanna al
“silenzio ossequioso”, parla di papa Francesco, della Carta della Terra e dei
tesori nascosti nelle culture indigene. Uno straordinario viaggio attraverso le
luci e le ombre del Novecento, fino a oggi.
Leonardo Boff è uno dei principali teologi latinoamericani. Insieme a
Gustavo Gutiérrez e Hélder Câmara è stato uno dei padri fondatori della
teologia della liberazione.
Luigi Zoja, saggista e psicoanalista, si è laureato in Economia e ha svolto
ricerche anche in ambito storico e sociologico. Tra i suoi libri ricordiamo: IL
GESTO DI ETTORE (2000) e PARANOIA (2011), pubblicati da Bollati
Boringhieri, UTOPIE MINIMALISTE (Chiarelettere 2013).
Pamphlet, documenti, storie
REVERSE
www.chiarelettere.it
facebook.com/chiarelettere
@chiarelettere
www.illibraio.it
© Chiarelettere editore srl
Soci: Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A.
Lorenzo Fazio (direttore editoriale)
Sandro Parenzo
Guido Roberto Vitale (con Paolonia Immobiliare S.p.A.)
Sede: via Guerrazzi, 9 - Milano
ISBN 978-88-6190-593-1
Progetto grafico di copertina: David Pearson
www.davidpearsondesign.com
Prima edizione digitale: aprile 2014
Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.
È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.
TRA ERESIA E VERITÀ
Per cominciare
Luigi Zoja Vorrei iniziare questo libro ricordando come ci siamo conosciuti.
Nel 2010 arrivai in Brasile, a Rio de Janeiro, per aprire una giornata di studi
di psicoanalisti junghiani e lessi sul programma che gli incontri del giorno
precedente erano stati inaugurati dall’intervento di un certo «L. Boff».
Chiesi se era un caso di omonimia: mi confermarono che si trattava di
Leonardo Boff, il teologo, uno dei padri fondatori della teologia della
liberazione.
Mi sembrò di tornare a vivere il mio passato, i miei trent’anni, quando i
giovani avevano continuamente sulla bocca il suo nome. I colleghi brasiliani
mi spiegarono che durante gli ultimi decenni, mentre in Italia era stato
allontanato dal dibattito pubblico a causa della censura vaticana, in Brasile
Boff era rimasto fra i pensatori più ascoltati: anzi, aveva ampliato ancora i
suoi interessi e il suo raggio di azione e di influenza. Negli anni Settanta e
Ottanta i progressisti latinoamericani erano essenzialmente impegnati sulla
questione sociale: il Sudamerica – in particolare il Brasile – era l’esempio
negativo del mondo. Lì le differenze tra ricchi e poveri erano estreme e
inaccettabili. Oggi il Brasile è uno dei pochi paesi in cui le differenze di
reddito sono diminuite, eppure a livello globale si è compiuta una drastica
crescita delle disuguaglianze sociali, un processo che ho cercato di
analizzare dal punto di vista psicologico nel mio libro Utopie minimaliste.1
Sempre in occasione del congresso junghiano di Rio, i colleghi brasiliani
mi raccontarono che negli ultimi decenni, oltre alla questione sociale, cuore
della teologia della liberazione, Boff si era impegnato sempre di più sui temi
ambientali, diventati centrali per i progressisti, in particolare in un paese
come il Brasile, dove le attività più devastanti e i profitti più elevati non
derivano dalle produzioni industriali ma dall’appropriazione delle foreste, la
porzione di natura incontaminata più vasta del pianeta.
Dopo aver aggiunto all’interesse per le ingiustizie dell’economia quello
per l’ecologia, Boff ha portato avanti i suoi studi e l’impegno in campo
antropologico. I nativi del Sudamerica, gli indios dell’interno, sono infatti i
disperati fra i disperati, le vittime nel senso più completo. Sono oggetto di
un radicale sfruttamento economico e di una eliminazione fisica che
costituisce un genocidio strisciante. Inoltre, a differenza di operai e
braccianti integrati quanto meno ai margini della società, gli indios stanno
perdendo anche la loro cultura, i loro modi di vita, travolti da forme di
depressione e di alcolismo. Boff è diventato un grande conoscitore delle loro
mitologie e religioni. Un campo per comprendere il quale è stato decisivo il
concetto di «inconscio collettivo» che abbiamo ereditato da Jung.
Contemporaneamente Boff è diventato anche un grande esperto di questo
fondatore della psicoanalisi. Perciò, quando è stata messa in programma
l’edizione portoghese-brasiliana delle opere complete di Jung, è stato
chiesto a lui di fare da curatore. E quando io, al congresso di Rio, ho
appreso tutto questo, insieme ad alcuni colleghi brasiliani ho chiesto
all’International Association for Analytical Psychology (l’associazione che
raggruppa gli analisti junghiani nel mondo) di nominarlo membro onorario.
Così è avvenuto nell’agosto del 2013, al congresso internazionale di
Copenhagen. In quello stesso mese si è svolta la conversazione ora proposta
in questo libro. All’incontro di Copenhagen, l’accoglienza degli analisti è
stata molto calorosa. Nel suo approccio originale alla psicoanalisi, Boff ha
avuto il merito di far coincidere l’idea junghiana di archetipo con quella
indigena della Pacha Mama, la grande Dea Madre o Madre Terra che,
preservata nei costumi dei paesi a più forte maggioranza india del
Sudamerica come Bolivia ed Ecuador, incorporata nelle loro leggi e
addirittura nelle loro costituzioni, ha ispirato programmi politici rispettosi
dell’ambiente e delle tradizioni native (altro argomento che ho trattato in
Utopie minimaliste). Caro Leonardo, si può dire che la dimensione
psicologica sia diventata sempre più importante nel corso della tua vita?
Leonardo Boff Vorrei iniziare ricordando un riconoscimento di cui sono
molto fiero. Risale al 1991, quando l’Università di Torino mi conferì la
laurea honoris causa in Scienze politiche. Fu Norberto Bobbio a
consegnarmela, e durante il discorso che tenni in quella occasione ricordo
che dissi questa frase: «Io vengo dal Neolitico, ho ripercorso tutti gli stadi
dell’umanità fino ad arrivare ai tempi moderni». Bobbio sorrideva. Queste
parole rappresentano davvero l’atmosfera che ha contraddistinto la mia vita,
fin dall’infanzia. Sono cresciuto in un mondo in cui primitivo e moderno si
sono incontrati e contaminati. Ancora oggimolti indios dell’Amazzonia
vivono come 20.000 anni fa. Non sanno neanche che esiste uno Stato
brasiliano. Il fatto interessante è che noi e loro siamo contemporanei. Noi
rappresentiamo la parte più avanzata tecnologicamente, loro quella
primitiva, più vicina alla natura, alla Madre Terra.
I nativi hanno molte cose da insegnarci: il rispetto, l’interdipendenza con
l’ambiente, il senso di libertà. Quando ci si trova fra loro ci si rende conto
che l’Eden non è affatto perduto. Sono solidali, rispettano i bambini e gli
anziani, hanno un profondo senso religioso della natura e della vita, un
sentimento del tutto estraneo alla cultura occidentale. In diverse culture
«primitive» ci si preoccupa addirittura di chiedere scusa alla Terra prima di
usare l’aratro. Sono convinto che simili riti siano espressione diretta di
atteggiamenti psicologici archetipici, di bisogni interiori che esistono da
sempre e che consentono di mantenere in equilibrio i rapporti sociali e quelli
tra l’uomo e l’ambiente circostante. Per questo credo che dobbiamo
guardare con molto rispetto e con molta attenzione alle culture andine.
Nasce da qui il mio interesse per la dimensione psicologica dell’essere
umano. Jung aveva intuito che il nostro modo di sfruttare la Terra avrebbe
causato una crisi globale e che il cambiamento poteva scaturire soltanto da
una relazione nuova e profonda con ciò che circonda il nostro Io. Il rispetto
per la Terra come sistema vitale unitario è un archetipo da riattivare e
appartiene alla dimensione del sacro. Questo Jung l’aveva capito benissimo.
Tra i popoli andini è ancora vivo il culto della Pacha Mama, la dea della
terra e della fertilità che fornisce il necessario per vivere. La nostra cultura
ha separato l’uomo dalla natura e l’ha spinto a dominarla, distruggendo quel
senso di totalità che contraddistingue ogni visione spirituale della vita. Le
religioni venerano le Scritture, l’ostia consacrata, lo spazio del tempio, ma
non riescono ad aprirsi al mistero del mondo e all’energia che alimenta
l’intero Universo. Questa lacuna spirituale è uno dei più gravi problemi
della modernità. La teologia sostiene che tutti gli aspetti del Creato sono
simboli e segni del Creatore, sacramenti naturali. Ma sono parole morte
perché noi non viviamo questa dimensione. Abbiamo avvicinato le
popolazioni indigene per sterminarle, perché non avevano il senso della
proprietà privata. Questa è una storia che io ho vissuto in prima persona,
come ho vissuto in prima persona gli anni terribili delle dittature in America
latina, la violenza praticata dal regime sui fratelli domenicani (frate Betto,
frate Tito, frate Ivo), la condanna della teologia della liberazione da parte
della Chiesa di Roma.
Tutto questo mi riporta alla storia della mia famiglia, veneti emigrati in
Brasile alla ricerca di terra da coltivare, e alla mia formazione, agli anni
trascorsi in Germania, a Monaco di Baviera, dove ho avuto come maestri
figure come Karl Rahner e Wolfhart Pannenberg e dove tanto ho imparato
da scienziati aperti al dialogo e con un’incredibile cultura umanistica, che
tenevano seminari anche nella facoltà di Teologia: tra loro ricordo in
particolare il grande fisico Werner Heisenberg. E ancora l’incontro con
Joseph Ratzinger, l’uomo che appoggiò e difese con tutto se stesso la
pubblicazione della mia tesi di laurea e che poi, da prefetto della
Congregazione per la dottrina della fede, attaccò i miei scritti e formulò la
condanna a un anno di «silenzio ossequioso». Un’avventura che ha
attraversato tutta la seconda metà del Novecento. Partiamo dall’inizio.
1 Luigi Zoja, Utopie minimaliste, Chiarelettere, Milano 2013.