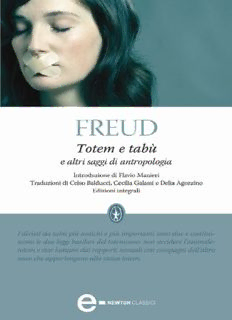Table Of Content39
Traduzione di Celso Balducci, Cecilia Galassi e Delia Agozzino
Prima edizione ebook: febbraio 2011
© 1990, 2006 Newton Compton editori s.rl.
Roma, Casella postale 6214
ISBN 978-88-541-2464-6
www.newtoncompton.com
Edizione elettronica realizzata da Gag srl
Sigmund Freud
Totem e tabù
e altri saggi di antropologia
Intoduzione di Flavio Manieri
Edizioni integrali
Newton Compton editori
Psicoanalisi e antropologia nella genesi
dello studio freudiano sulla cultura
1. A proposito di applicazioni non mediche della psicoanalisi
All'inizio dell'anno (1911) Freud annunziò che la sua originalità di pensiero si
stava estinguendo senza ombra di dubbio, osservazione interessante perché
precedette solo di pochi mesi uno dei suoi lavori più originali, quello sulla
psicologia della religione. Verso agosto, pur trovandosi in vacanza, ammise
d'essere «completamente Totem e tabù».
JONES,Vita ed opere di Freud, II, p. 113
Anni quelli ferventissimi di studi storico-religiosi, confortati dallo sviluppo
di nuove scienze e da quei recuperi antropologici che si avviano a divenire
[1]
addirittura una moda ed a condizionare il costume della decadente Europa,
L'esotico, certo!
Ma non è, forse, proprio il gusto dell'esotico un frutto di ambivalenze?
L'antropologia come la psicoanalisi forniscono all'uomo uno specchio
inconsueto, sospeso tra il peccato attuale ed il peccato originale, dunque
segreto, fatto di storia, d'una storia dalla quale l'uomo si raggrinza nel
presente, nella quale si trova di fatto esteso e per contenuti lancinanti trattenuti
di là dal sé, in un sé più vasto, profondo, primitivo, che esclusivamente quasi
più non gli appartiene: non appartiene a lui-persona più di quanto non
appartenga a nessun altro uomo.
L'uomo produttivistico riconosce se stesso nella descrizione applicata del
proprio comportamento e nei suoi equivalenti di scambio.
La «Responsabilità» è a tutto tondo presente: azione e forma d'azione. («C'è
qualche riposta intenzione nel fatto che mi chiediate chi io sia. Chi sono si vede.
Non altro!»).
Unificarle significa trarre da due metri perfettamente rapportati la tecnica
d'un unico linguaggio «anteriore» (Siamo forse riusciti a dimenticarlo? Ο
quell'azione che io guardo di te non è altro che la forma della tua impotenza a
dimenticarlo,... se accorgerti è mai stato, lungo te, soffrire?): il riferimento d'un
unico contenuto drammatico, e tanto almeno quanto è per ognuno ancora il
riconoscervisi. (Vuoi forse negarlo? L'uomo si preserva con la fuga e con il
sospetto, infinite resistenze, dal terrore di sedersi presso sé. Il sé è dolore).
L'esotico...
E la psicoanalisi, frutto esotico di un'età che l'esotico gustò singolarmente,
denuncia (non fa altro) - che la si accetti ο non - perfino nelle passioni che va
suscitando, disperatamente, le molte valenze d'ogni riferimento che la riguardi.
Anche l'arte si fa allora arcana e da una pura reazione di sensi trova la
propria storia dentro radici anteriori alla storia quale eravamo abituati a
tramandarci - una storia anteriore, cioè anteriore al costituirsi del linguaggio,
quale medium della coscienza, quale forma del dolore, della mancanza.
La dimensione data dalla estremità del corpo stesso umano, della nostra
dimensione fisica, del teatro del nostro corpo: è l'espressione.
La psicoanalisi si propone appunto come un riesame semantico (semantico-
sintomatico e semantico-simbolico; poi, semantico-mitico) e semantico nel
senso mediale, tra la storia della esigenza biologica e la evoluzione dei segnali
adatti ogni volta ad «esprìmerla». Riarticolazione strutturale della ricchezza e
della funzione d'un segnale, nel senso delle globalità del fenomeno espressivo.
Ammesso un doppio fronte evolutivo delle situazioni biologiche, un fronte
individuale ed uno che riguardi Finterà specie (ontogenesi e filogenesi), Freud
si preoccuperà - in un senso, vedremo, non perfettamente crìtico - di chiarire
come i due livelli possano vicendevolmente riassumersi sul piano teorico. La
ontogenesi ricapitola, così, la filogenesi per una sequenza di rispondenze
convincenti al punto da permetterci un riflusso metodologico dalle formule
diagnostico-terapeutiche della psicoanalisi alla frammentaria e contraddittoria
scienza etnologica del tempo. Non solo l'osservazione e la raccolta accurata dei
dati, la loro catalogazione sistematica! L'aspirazione al renaniamo
«supplemento d'anima», sul letto di morte del positivismo, agisce in Freud, e
verso il senso delle cose, il loro senso dimenticato, però testardamente
«scientifico» (una categoria di valore, sine qua non); il senso causale delle cose.
Già dall'aprile del 1911 Freud avrebbe voluto con Rank e Sachs dedicare a
questi problemi una rivista. La testata proposta da Stekel era stata Eros-Psyche,
ma aveva poi prevalso Imago, secondo l'idea di Sachs.
Ne seguì una reazione confusa. Nessun editore volle assumersi la
responsabilità; si muovevano da ogni parte timori che la sua uscita potesse
offendere la censura. Finalmente Heller; un amico di Freud, si accollò di
persona le spese, ed il primo numero, con i suoi centonovantaquattro abbonati,
potè uscire per il gennaio del 1912. Prima ancora, tuttavia, di questo
avvenimento ufficiale, gli stuti storico-religiosi di Freud avevano già avuto
modo di inserirsi nel più impegnato discorso sulle nevrosi. Era successo
durante i lavori del congresso di Weimar (21-22 Settembre), dove, nella postilla
al caso Schreber, egli ebbe occasione di parlare delle tendenze miti-cizzanti
dell'uomo, del totemismo e della fonte non solo infantile ma anche primitiva -
realmente preistorica - del materiale inconscio.
Nel 1912 la psicoanalisi affronta il primo urto per la propria
«sistemazione» culturale. E questo non si riferisce soltanto alla polemica sulla
scientificità, ma anche alla radicalizzazione - nei confronti dell'esterno - delle
posizioni di alcuni fra i suoi aderenti. Di fronte all'urto, sembrò che molti
volessero difendere le proprie personali responsabilità - ma anche chiarirle nel
senso della dissociazione.
E l'anno della definitiva separazione di Adler, dei grossi problemi alla
Gemeinschaft psicoanalitica viennese, della defezione di Stekel, del sempre
crescente allontanamento di Jung.
Proprio in vista dell'area culturale d'impatto della teorìa, e in previsione -
appunto - della evoluzione di quell'area, l'attenzione del fondatore e presidente
della Società Internazionale si era concentrata sulle inferenze non mediche
della psicoanalisi. Freud aveva assunto il punto di vista del singolo nei
confronti di fenomeni ontogenetici, attivi nella psiche di ogni individuo, di tutti
gli individui, al punto da costituirsi come istanze e dinamiche collettive. Jung
aveva invece assunto il punto di vista più puramente collettivo (non nel senso
sociologico di Durkheim, evidentemente: «demo-psicologico» - diceva Freud).
Secondo questo punto di vista, è attraverso il recupero di simboli archetipici
che la psiche individuale tende a risolvere e a ritrovare il senso della propria
individuazione. Ed appunto, dentro matrici cosmiche, che la pongano
emotivamente a contatto con i processi primari dell'intera specie.
Freud e Jung reagiscono in realtà a due mondi differenti, nel senso della
denuncia l'uno, l'altro nel senso della interpretazione, e dunque non nello stesso
verso, ma reagiscono comunque ad una comune prova di adattamento culturale.
Il 1912 è l'anno dell'impatto della psicoanalisi con la sua realtà culturale.
Freud avrebbe voluto unificare le nuove problematiche nel suo verbo e che i
suoi continuassero, intanto, a lavorare, per il rafforzamento della base, sulla
teorìa delle nevrosi; ma il problema di punta riguardava tutti e la
sopravvivenza di ciascuno. Questa operazione non gli riuscì. Nello stesso
tempo, la violenta campagna giornalistica condotta in Svizzera (la Svizzera
calvinista) contro il lessico provocatorio della psicoanalisi e contro i suoi
postulati aveva non solo grandemente chiarito la differente situazione di lavoro
degli psicoanalisti svizzeri rispetto a quella dei viennesi, ma metteva i primi
(cfr. il contemporaneo epistolario con Riklin) di fronte a dilemmi pratici
notevoli.
Non è solo in questo senso, tuttavia, come vorrebbero alcuni, che la rottura
di Jung deve essere interpretata. Né era comunque questa l'opinione di Freud
allora, quando la comune tensione spingeva più d'uno psicoanalista verso studi
mitologici. Perfino il fedelissimo Jones, a dissuadere il quale era dovuto
intervenire il maestro, con una lettera apposita del gennaio 1911.
Ma già nel 1910, a Ferenczi, Freud scrìveva: «... sono più convinto che mai
che egli (Jung) sia l'uomo del futuro. Le sue ricerche l'han portato assai
addentro nel regno della mitologia, che egli vuol dischiudere con la chiave
della teorìa della libido. Per quanto tutto ciò sia bello gli ho consigliato però di
tornare alle nevrosi, perché quello è il terreno sul quale dobbiamo prima
rafforzarci, contro tutto e contro tutti». E pensare che ancora nel Ί3 sempre
Jones entrava in rapporti contrattuali con Havelock Ellis per ottenere da lui un
volume di 500/600 pagine sulle applicazioni non mediche della psicoanalisi!
(Jones dice di non ricordare perché questo progetto non giungesse mai in
porto).
Se la divaricazione delle soluzioni proposte diviene sempre più certa, Freud
desidera che la salvezza sia intorno ad una comune e rafforzata teoria della
nevrosi, piuttosto che intorno ad una diaspora di tesi di orìgine psicoanalitica
fra loro in contraddizione. Freud vuol procedere, malgrado tutto, ad una
ratifica di alcuni concetti basilari.
Jung lo rassicura con lettere formali, ma continua per la sua strada.
Durante una visita, presso Jung, Freud aveva avuto modo di leggere la
prima parte di Libido: simboli e trasformazioni, e la moglie di Jung, in una
lettera, non aveva saputo descrìvere il suo atteggiamento se non come
«riservato». Jones (più tardi) descrìve a Freud, per lettera, il contenuto della
seconda parte, che era riuscito a leggere sulle bozze, e questi gli rispose di non
essere affatto d'accordo. Più le posizioni si chiarificavano, è evidente, e più gli
incidenti andavano aumentando.
Le critiche di Jung divengono sempre più aperte e le occasioni si
moltiplicano: a Berna, per esempio, a proposito della sua disquisizione sui
cimiteri preistorici dei dintorni della città e al suo preteso «desiderio di morte»
oppostogli da Freud, ο infine a Monaco, in riferimento alla tesi di Abraham,
secondo la quale il contenuto primo della rivoluzione monoteista del faraone
Amenotep consisteva nel suo odio contro il padre.
... E l'acuta sensibilità di Freud è pronta a rispondere. Quando Jones gli
comunica il lapsus di Jung che aveva spedito l'invito per una importante
riunione di colleghi a casa di suo padre nel Galles (pur sapendo ch'egli si
trovava a Firenze, dove poteva essere facilmente reperibile), Freud gli rispose
senza mezzi termini: «Un gentiluomo non dovrebbe fare cose del genere
nemmeno inconsciamente».
L'episodio culminante sembra essere proprio lo svenimento autopunitivo di
Freud per il piccolo successo ottenuto su Jung a proposito della spiegazione del
[2]
«gesto di Kreuzlingen».
Comunque Freud, di fronte alle critiche di artificiosità che già nelle
conferenze americane di quello stesso anno Jung aveva mosso al suo
«complesso dell'Incesto» ο «complesso Edipico», definendolo ormai sorpassato
(con la scusa - motivata nella relazione, al ritorno - di rendere la psicoanalisi
meglio accetta), sentì bene di dover rispondere, com'era suo uso, piuttosto che
con la polemica, con un'opera. Quest'opera, tra Religion und Mythus di Wundt
e Wandlungen und Symbole der Libido di Jung, è Totem und Tabu, in cui
addirittura sul «complesso Edipico» si predica fondato tutto il sistema sociale.
Quell'anno non era stato, tutto sommato, un buon anno per la sua salute
eppure, proprio per la pubblicazione dì Totem e tabù, Freud considerò il 1912,
e la cosa ci appare tanto più significativa, come uno dei suoi più produttivi. Egli
aveva deciso di dedicarlo all'esposizione della propria tecnica, perché pensava
che dalla sua cattiva conoscenza Adler e gli altri erano stati indotti alle loro
defezioni, ed ai tentativi di una psicologia della religione, secondo le ricerche
mistico-mitologiche di Jung.
Sui tempi di lavorazione di quest'opera siamo ben documentati.
Il 13 Maggio 1912, Freud presenta la seconda parte di Totem e tabù alla
Società Viennese di Psicoanalisi. Il 15 Maggio, annota ad Abraham che sta
scrivento quell'opera per quattro ο cinque persone. Dal 10 al 27 Dicembre,
dopo il congresso di Monaco, Freud passa alcuni «deliziosi» giorni a Roma, in
compagnia della cognata Minna, alla ricerca di posti nuovi che gli erano
sfuggiti le volte precedenti. Qui conclude Totem e tabù, segnandone la
prefazione.
Description:Newton, 2011 - 270 p., ASIN: B0062ZNH0MIntroduzione di Flavio ManieriTraduzioni di Celso Balducci, Cecilia Galassi e Delia AgozzinoEdizioni integraliQuesto volume raccoglie i saggi con i quali la psicoanalisi uscì per la prima volta dal campo strettamente medico per tentare un’interpretazione rad