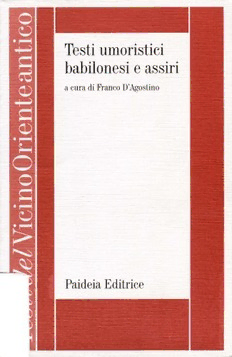Table Of ContentTesti umoristici
babilonesi e assiri
a cura di Franco D'Ago tino
Paideia Editrice
Gli scritti raccolti in questo volume consentono di vedere
in che co a consistessero l'umorismo e il comico
per la cultura assira e babilonese. rei testi tradotti
e commentati, il medico e il paziente, il padrone e il servo,
il potente e il misero, e tutta una serie di personaggi
mesopotamici di quattromila anni fa, si trovano a dialogare
e scontrarsi, a imbrogliarsi e a divertire in una serie
di situazioni che contribuiscono a formarsi un'idea di quale
fosse la realtà della vila quotidiana della Babilonia
preclassica. La raccolta degli scritti è preceduta da un'estesa
e articolata introduzione nella quale sono illustrate le figure,
teatrali e comiche, a metà tra il sacro e il profano,
nelle quali s'incarnava la tradizione umori tica babilonese.
Franco D'Agostino è ricercatore di Assiriologia presso
l'Istituto di Studi Orientali dell'Università di Roma
«La Sapienza.».
ISBN 88.394.0590.9 Lire 32.0(
Testi del Vicino Oriente antico
2
Letterature mesopotamiche
a cura di Giovanni Pettinato
4
Testi umoristici babilonesi e assiri
Paideia
Testi umoristici
babilonesi
e ass1r1
a cura di
Franco D'Agostino
Paideia
in memoria di
Luigi Cagni
Tutti i diritti sono riservati
© Paideia Editrice, Brescia 2000 ISBN 88.394.0590.9
Premessa
Lo scopo principale che si prefigge questo saggio è quello di offrire
un punto di partenza per potere identificare che cosa fosse l'umori
smo, o il comico, per la cultura mesopotamica e quale posto esso oc
cupasse nel mondo ideologico e psicologico dell'uomo appartenente
a quella cultura. In questo senso, il volume rappresenta un tenta
tivo, raramente tentato sino ad oggi nei nostri studi, di considerare
in modo unitario questo aspetto poco noto dalla documentazione
in nostro possesso eppure così significativo per comprendere il mo
do di essere di una civiltà, vuole rappresentare insomma una pri
ma sintesi, che andrà forse corretta e rivista, ma tale da offrire una
base futura di discussione su questo argomento.
Ritengo che così pensato questo saggio possa offrire sia agli spe
cialisti assiriologi che ai cultori delle letterature e lingue vicino
orientali in genere uno spunto, un 'ipotesi interpretativa per la ri
flessione futura. Se c'è un campo filologico che è in continua evolu
zione, questo è quello d'altronde delle letterature cuneiformi: il pro
sieguo degli studi da un lato e dall'altro nuove scoperte quasi quo
tidiane, sia sotto la sabbia delle regioni del Me dio Oriente che nel
le collezioni dei musei di tutto il mondo, ci obbligano a ripensare le
nostre cognizioni acquisite e a stravolgere la nostra ricostruzione
della loro storia e cultura. Il lettore interessato agli aspetti «cultu
rologici» vi troverà poi, ritengo e spero, spunti di riflessione per ana
lizzare - è l'obbligo d'ogni persona colta - la sua (nostra) propria
cultura.
Il testo non è scritto per il solo specialista, come è nella consue
tudine della serie, anche se è stato necessario abbondare nelle note
al testo - queste sì, spesso, a carattere specialistico - per giustificare
una traduzione o un'interpretazione: per il lettore non orientalista
esse sono la garanzia che lo scrivente sarebbe in grado di difendere
le posizioni che gli presenta anche di fronte ad un pubblico meno
7
ignaro. La fruizione e la comprensione delle argomentazioni non
vengono compromesse dalla mancata lettura di queste note specia
listiche e mai, in ogni caso, in nota si è sviluppato un discorso gene
rale sull'argomento del volume.
Mi è gradito poter qui ringraziare il prof Giovanni Pettinato,
che mi ha messo a disposizione la sua biblioteca e sorretto con con
sigli e discussioni scientifiche, e gli studenti del corso da me tenuto
presso l'Università di Roma «La Sapienza» nell'anno accademico
1996-1997 sull'umorismo a Babilonia per il loro interesse all'argo
mento che ha molto arricchito in profondità ermeneutica questo li
bro. Un ringraziamento particolare va inoltre al prof Paolo Sacchi,
che ha voluto accogliere un testo tanto bisognoso di f andamenti fi
lologici.
Il volume è dedicato alla memoria del prof Luigi Cagni, bar
nabita ed assiriologo: molto l'autore di queste pagine deve alla sua
capacità di creare possibilità ai giovani studiosi di trovare vie per
esprimere la loro cultura e professionalità (l'esistenza stessa di que
sto saggio si deve all'incoraggiamento proprio di Luigi Cagni). Il
mondo dell'orientalistica ha perduto, con la sua scomparsa, uno tra
i pochissimi in grado di guardare con entusiasmo e passione, supe
rando meschini interessi ed ataviche contrapposizioni, al futuro di
un meraviglioso campo di studi.
Franco D'Agostino
L'umorismo a Babilonia
r. La « Biblioteca di Assurbanipal»
Alla scoperta del più grande archivio letterario del mondo anti
co orientale, a quella cioè della celeberrima «Biblioteca di Ninive»
voluta dal sovrano Sardanapalo (Assurbanipal) nel vrr sec. a.C., è
legato un fatto che, a seconda dei punti di vista, può far ridere al
cuni ed indignare altri.
Nel 1852 Hormuzd Rassam, un emissario al servizio dell'In
ghilterra ma di origine arabo-cristiana, che lavorava a quel tempo
per conto del British Museum a Mossul nell'Iraq settentrionale,
afferma di avere ritrovato sul teli di Quyunjik, la Ninive degli As
siri, gli ambienti del palazzo di Assurbanipal in cui era conservata
la biblioteca reale. Imbarca quindi tutte le tavolette, ammontanti a
oltre 20000 numeri d'inventario, rinchiuse in casse di legno alla
volta del museo britannico dove esse, ancora oggi, sono conserva
te, studiate e lentamente pubblicate. L'aspetto comico (o offensi
vo, a seconda di chi lo giudica) è legato però non al fatto in sé, ov
viamente, ma alle modalità in cui si svolse.'
Sembra infatti, anzi se ne ha la quasi certezza, che ciò che fu in
viato al British Museum dal solerte e privo di scrupoli rappresen
tante inglese sia il frutto di un vero e proprio furto ai danni delle
autorità francesi che avevano l'appalto per lo scavo nel settore in
1. Sugli aspetti relativi a questa scoperta e per tutte le problematiche storiche co
involte si veda F. D'Agostino 1997, 28-34, con bibliografia precedente. Nato nel
1 826, Rassam aveva studiato in Inghilterra dal I 847: nel I 8 54 era diventato inter
prete del residente inglese di Aden e soli due anni dopo vice-residente (imprigio
nato poi nel 1864 da re Teodoro in Abissinia, dove svolgeva una missione per conto
inglese, sarebbe stato liberato dalla missione Napier nel 1866); su Hormuzd Ras
sam si veda anche J. Reade, Hormuzd Rassam and bis Discoveries: Iraq 55 (1993)
39 ss. In genere sulle scoperte archeologiche di questo cinquantennio d'oro per
l'archeologia orientale si può consultare la recente e ricca sintesi di M.T. Larsen,
The Conquest of Assyria (Excavations in an Antique Land), London 1996.
9
cui le tavolette furono rinvenute. Il teli di Quyunjik, infatti, era
stato visitato la prima volta già nel 1843 dal grande iniziatore del
l'archeologia orientale, l'appassionato e sagace italo-francese Paul
Émile Botta, che aveva però ben presto smesso le ricerche per la
mancanza di ritrovamenti atti a giustificare l'impegno economico
che egli sosteneva di tasca propria.' E se lo spostamento delle sue
ricerche sul teli di Khorsabad fu coronato dal più straordinario
successo, tanto che vi fu portata alla luce una delle capitali del re
gno assiro, Diir-Sarrukin, con il favoloso palazzo di Sargon 11, tut
tavia, stanti le consuetudini dell'epoca, i Francesi avevano conti
nuato a detenere, implicitamente e come diritto di priorità, la pre
lazione per lo scavo di Quyunjik. Tutto questo però prima che in
Medio Oriente intervenisse un inglese colto e dotato di grande abi
lità diplomatica.
Henry Austen Layard J aveva conosciuto casualmente Botta nel
1 840 a Mossul ed era rimasto affascinato dalle sue scoperte e dalla
sua passione per questa nuova scienza rappresentata dall'archeo
logia del Medio Oriente. Convinto da H. Rawlinson, console in
glese a Mossul ed uno dei più grandi assiriologi di tutti i tempi, ad
imprendere attività di scavo, aveva ben presto anche lui raggiunto
risultati più che lusinghieri, riportando alla luce sul teli di Nim
rud, l'antica Kalhu, a sud di Mossul le rovine dei sontuosi palazzi
di Assurnasirpal 11, Tiglat-Pileser III ed Asarhaddon. E a questo
punto entra in gioco Hormuzd Rassam: H.A. Layard, infatti, si
serviva per le sue relazioni con il mondo arabo di questo ambiguo
personaggio, conoscitore di tutte le lingue della zona ( oltre che
del francese e dell'inglese), abile e scaltro diplomatico, capace di
lusingare e minacciare, asservito per di più senza remora alcuna al
la causa inglese.
Il fatto incriminato accadde allorché H.A. Layard lasciò il Me-
2. Su questo entusiasta ed intelligente neofita, che tanta parte ebbe nella riscoper
ta delle civiltà orientali dal punto di vista archeologico ed anche filologico, si veda
G. Pettinato, P.E. Botta, il pioniere dell'assiriologia: RANL IX, v/6 (1995) 469-
481, con bibliografia precedente.
3. Oltre alla bibliografia citata alle note precedenti, si veda in modo peculiare su
questo personaggio G. Waterfield, layard of Niniveh, London 1963 e i contribu
ti in B.J. Hickey -F.M. Fales (edd.), Austen Henry layard tra Oriente e Venezia,
Simposio internazionale, Roma 1983.
IO
dio Oriente per tornare in patria ed iniziare una carriera diploma
tica che lo portò due volte ad essere ministro. Quando infatti gli
Inglesi ed i Francesi si accordarono, al fine di evitare spiacevoli ri
valità, e si divisero il sito di Quyunjik in due parti, furono pro
prio i Francesi a scoprire, scavando il teli, gli ambienti del palazzo
che contenevano lo straordinario tesoro delle tavolette cuneifor
mi. Furono però imprevidenti (o sfortunati): benché avessero agi
to in gran segreto, uno dei loro operai era stato infatti «compra
to» da Rassam, il quale quindi venne a conoscenza subito della stra
ordinaria scoperta. Per colmo di sventura, il rinvenimento france
se avvenne di giovedì e come ognun sa il venerdì nei paesi musul
mani è festa e non si lavora. Cogliendo al volo questa ghiotta oc
casione, Rassam radunò una squadra di operai che lavorò di na
scosto la notte di giovedì e tutto il venerdì, scavando un tunnel
sotterraneo sino alle stanze incriminate e trafugando tutto quello
che vi era stato trovato.4
La duplicità della reazione a questo racconto (sorriso da parte
inglese, sdegno da parte francese) non inficia comunque in alcun
modo il valore scientifico straordinario che è rappresentato dalle
tavolette di Ninive.1
Ma non è stato comunque l'aspetto (eventualmente) comico del-
4· Il racconto che della scoperta fece Rassam è ovviamente assai differente, ma mai,
neanche da parte degli Inglesi, egli venne riconosciuto come lo scopritore delle ta
volette (che comunque sono ben protette nei polverosi scaffali londinesi), né le au
torità del museo hanno ancora messo a disposizione degli studiosi il materiale d'ar
chivio che possa chiarire la faccenda. Per la versione di Hormuzd Rassam si veda
F. D'Agostino 1997, 31-33 e i rimandi bibliografici lì citati.
l · Sull'archivio di Ninive si veda]. Reade, Archaeology and the Kuyunjik Archives,
in Cuneiform Archives and Libraries, XXX RAI, Leiden 1983, 197 ss. e in genera
le A. Livingstone, Court Poetry and Literary Miscellanea (SAA 3), Helsinki 1989,
xvm ss.; se abbiamo scelto questo archivio per esemplificare visivamente la lunga
tradizione culturale mesopotamica ciò non vuol dire che non esistano altre, al
trettanto ricche biblioteche (si veda, per un esempio tratto dalla stessa realtà assi
ra, O. Pedersén, The Libraries in the City of Assur, in K. Hecker -W. Sommer
feld [edd.], Keilschriftliche Literaturen (BBVO), Berlin 1986 [ = xxxn RAI], 143
ss. e dello stesso autore, Use of the Writing Among the Assyrians, in H. Waetzoldt -
H. Hauptmann [edd.], Assyrien im Wandel der Zeiten [xxxix RAI], Heidelberg
1996, 139 ss., soprattutto I so s., dove si troverà un prospetto sugli archivi delle
·varie tipologie tra il 1900 e il 600 a.C.). Sulle modalità della formazione della bi
blioteca si confronti in generale F. D'Agostino 1997, 26 s. e note relative (con bi
bliografia ulteriore).
II