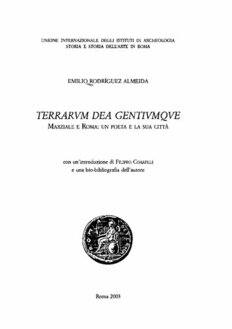Table Of ContentUNIONE INTERNAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI ARCHEOLOGIA
STORIA E STORIA DELL'ARTE IN ROMA
EMILIO RODIUGUEZ ALMEIDA
~
TERRARVM DEA GENTIVMQVE
MARzIALE E ROMA: UN POETA E LA SUA CITTÀ
con un'introduzione di FILIPPO CoARELLI
e una bio-bibliografia dell'autore
Roma 2003
© Copyright 2003
UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI ISTITIJTI DI ARCHEOLOGIA
STORIA E STORIA DELL'ARTEI N ROMA
00186 Roma -Piazza dell'Orologio, 4
redazione a cura di
ESTHER BARRONOOO OMiNGUEZ
ePAOLOVIAN
Il volume pubblica il testo della XIX «Conferenza dell'Unione» tenuta da Emilio
Rodriguez Almeidai l 3 dicembre 2001 presso il Pontificio Istituto di Archeologia
m,
Cristiana,i n via Napoleone 1. La pubblicazioneh a goduto di un contributo della
Regione Lazio.
PAG.
Introduzione di FILIPPO CoARELLI . . . . . . . . . . . . . 7
Te rrarum dea gentiumque. Marziale e Roma: un poeta e
la sua città di EMILIO RooR1GUEAZL MEIDA . 9
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . 11
Selezione di saggi e articoli utilizzati . 12
Alcuni lavori dell'autore sulla materia 13
PARTE PRIMA - Nobiltà e miseria di una città unica 15
Marziale, fonte per la topografia urbana 15
Roma e i romani di Marziale. I potenti 22
Roma, teatro della commedia umana . 35
PARTE SECONDA - Un esempio di analisi topografica sulla
base di Marziale: la Porticus Europae (-es) 45
Bio-bibliografiad i Emilio Rodriguez Almeida 65
FILIPPO CoARELL* I
INTRODUZIONE
Nessuno meglio di Emilio Rodriguez Almeida avrebbe po
tuto affrontare il tema dd rapporto tra Marziale e Roma, e
questo per varie ragioni, di competenza scientifica, ma anche più
dirette e personali, come vedremo.
Ci viene così mostrato, in primo luogo - attraverso un'analisi
puntuale e talvolta impietosa della bibliografia esistente sull' ar
gomento - quanto povera, lacunosa, ddudente sia stata finora
l'analisi dd Marziale «topografq» di Roma: e ciò benché si
tratti, come tutti sappiamo, della fonte più ricca per la cono
scenza della città nd periodo medio-imperiale. Le ragioni di
questa modestia delle trattazioni precedenti sono lucidamente
analizzate: esse sono imputabili all'uso, inveterato tra gli studiosi
di topografia antica, di collezioni di excerpta,s trappati ai conte
sti di origine: ora, solo dalla lettura integrale degli autori, come
ci viene dimostrato nd caso specifico, e con dovizia di esempi,
può emergere non solo la retta utilizzazione di singole notizie,
ma soprattutto la ricostruzione dell'ambiente fisico, sociale e
culturale che le rende comprensibili fino in fondo. Un esempio
di tale lettura integrale si trova nella seconda parte di questo
scritto, dove si prende in esame una delle crucesp iù ostiche della
topografia romana, l'identificazione della porticusE uropae,r icor
data solo da Marziale: proponendo, a conclusione, quella che
appare la soluzione più soddisfacente, che si tratti cioè dd por
tico settentrionale dell'Iseo dd Campo Marzio.
Abbandonando per un momento l'analisi puramente topo
grafica, Emilio Rodriguez Almeida si avventura in un'analisi dd-
1o' pera di Marziale, che fa emergere i rapporti con i potenti (per
primo, ovviamente, lo stesso imperatore, Domiziano), ma soprat-
* dell'Università di Perugia.
8 FILIPPO COARELLI
tutto con l'insieme del «popolo di Roma». Viene così ridimen
sionata la critica ricorrente al poeta, tacciato di bassa adulazione
del potere: in realtà, come ci viene dimostrato, si trattava di una
prassi inevitabile nella Roma di Domiziano, prassi di cui si
resero responsabili, ben più di Marziale, altri autori contempo
ranei, come Stazio.
Il vero pubblico del poeta sembra costituito piuttosto da un
settore "medio", e comunque non particolarmente altolocato
della società romana, mentre la materia trattata è quella Roma,
«teatro della commedia umana», quella «corte dei miracoli» che
si aggira nei vicoli e negli angiporti della città: una Roma non
monumentale (anche se i monumenti non possono essere del
tutto assenti), abitata da un piccolo mondo popolare, lo stesso
che costituirà, molti secoli più tardi, la materia utilizzata da un
grande poeta romano, Giuseppe Gioacchino Belli,l a cui evoca
zione non è qui inopportuna, dal momento che il poeta di Bilbi
lis costitul certamente per «Peppe er Tosto» uno dei modelli pri
vilegiati cui attingere. I.:a nalisi di questa Roma minore dà luogo a
un puntuale repertorio dei luoghi della città privilegiati da Mar
ziale: repertorio utilissimo, dove non mancano le sorprese.
La perfetta conoscenza dell'opera è messa al servizio di una
sensibilità acuta, che ci pone in presenza di un Marziale nuovo, e
ben più attendibile di quello che credevamo di conoscere. Questa
capacità di penetrazione sgorga da un'adesione intima al mondo
del poeta, mondo di cui si sottolinea, a ragione, il carattere tutt'al
tro che cinico, ma anzi coinvolto e partecipe. Così, quando Rodri
guez Almeida ci descrive, con commozione appena rattenuta, «la
Roma terrarumd ea gentiumque [ ... ], vista dal di dentro, però, ove
la sua grandezza assume proporzioni gigantesche, perfino nelle
grandi piaghe e nelle grandi ignominie. La Roma ove un piccolo
provinciale giunse, come tanti altri, in cerca di gloria», sarebbe
difficile non cogliere, con emozione, la vena implicita che tra
scorre lungo tutte queste pagine, sintomo inequivocabile di un' af
finità elettiva, che in fondo è innanzitutto autobiografica.
Dalla nativa Avila, dove il nostro autore e amico è tornato a
vivere dopo tanti anni - proficui anni - di soggiorno romano, ci
giunge così, tramite la mediazione del suo "doppio" antico, una
dichiarazione di amore - intrisa di qualche amarezza - per la sua
città di adozione: che certamente costituirà, ancora per molti
anni, l'argomento principe di molti, ricchi e attesi lavori.
TERRARVM DEA GENTIVMQVE
Marziale e Roma: un poeta e la sua città
EMILIOR ornuGUEAZL MEIDA
Introduzione
Questo libro non vuole essere né apparire un trattato dotto e
profondo sulla Roma classica, né la storia succinta della Roma
domizianea attraverso quella privata di uno dei suoi grandi perso
naggi letterari. Gli occhi di un poeta, si sa, sono occhi molto parti
colari; e quelli attraverso i quali intendiamo vederla sono proprio
quelli di un poeta, acuti e curiosi quanto si vuole, ma dotati delle
lenti colorate e deformanti dell'umorismo, della burla, dell'ossequio
reverenziale e della più genuina delle tenerezze, come si addice a un
poeta, testimone tutto sommato marginale dei grandi awenimenti
che, in sé, a lui interessano professionalmente ben poco.
A queste deformazioni di prospettiva e di intenzione si possono
fare, ovviamente, tante obiezioni, si possono frapporre tante riserve
e cautde; ed ecco perché Marziale è per tanti versi un poeta
discusso. Ma non si potrà mai dire che occhi siffatti, nd contem
plare per quasi otto lustri una città come la Roma dei Flavi, non
abbiano l'autorità, non meritino il credito per divenire parte degli
strumenti primari di cui filologi, storici o archeologi abbisognano
per capirla integralmente.
D'altro canto, la varietà e ricchezza delle fonti storiche che
riguardano il periodo della vita di Marziale a Roma sono tutto
meno che disprezzabili, e un lettore esigente amerebbe sicuramente
vederle confrontate, comparate minuziosamente con la visione, le
parole e i giudizi dd poeta. Ma ciò sarebbe l'opera di uno storico o
di un filosofo della storia, e, per il periodo che ci interessa, opere
simili non mancano, a cominciare dal tuttora magistrale saggio di
uno Gsell. Per parte nostra, basterebbe mettere a sacco la Prosopo
graphial mperii Romani perché un libricino come questo diventasse
una mostruosa opera di erudizione (e di noia); ma ciò è ben lungi
dal nostro proposito.
Ci proponiamo solamente di «vedere» attraverso questi versi
una Roma che non è quella della grande Storia, ma solo la «sua»
Roma di ogni giorno come lui era capace di vederla, deformata o
meno. Ci contenteremo della stessa deformazione professionale dd-
12 EMILIO RODR1GUEZ ALMEIDA
l'umorista per mettere a fuoco su un piano unico e quasi allo stesso
tempo tanti suoi sguardi, le sue immagini fissate quasi senza volerlo
(almeno per quello che a noi interessa maggiormente) nell'istanta
nea più fugace. Solo come sussidio e scorta di Marziale, qua e là
faremo riferimento ad alcuni dei suoi coetanei o quasi coetanei
(specialmente poeti), da Persio a Svetonio, passando per Giovenale,
Tacito o lo pseudo-Seneca dell'Apocolocyntosiso Papinio Stazio.
Avrà, questo libro, il taglio del saggio, non quello dell'opera sto
rica o filologica. Sarà filologico in sé, non in una critica testuale
minuziosa o in un apparato bibliografico che chiunque può gonfiare
a dismisura e senza particolare profitto. E non si concederà voce ad
alternative di giudizio (u na posizione che ogni autore, lo confessi o
meno, mantiene, giustamente), che, non fosse altro, ci porterebbero
lontani dal nostro scopo. Se qualcuno vorrà buttarla in malam
partem f~ccia pure, perché né l'autore, né Marziale (awezzo oramai
a godere di cattiva stampa) se la prenderanno più di tanto.
Per una lettura proficua di un testo relativamente corto e
«compresso» come questo, un lettore avvisato dovrebbe avere alla
mano un'edizione critica dell'opera di Marziale, visto che, per non
allungare troppo una lettura che vuole essere facile e scorrevole, le
citazioni del poeta saranno, in genere, scarne e succinte. Ai più
esperti nel latino si raccomanda l'edizione di W. Heraeus (Martialis,
BSB G.B. Teubner Verlagschaft, Leipzig 1976, o riedizioni succes
sive). A chi avesse bisogno di un testo bilingue si suggerisce (senza
impegno particolare e con tutte le cautele del caso, per le molte
interpretazioni discutibili) la lettura comparata di edizioni critiche
J.
come quella di lzaac («Les Belles Lettres», Collection des Uni
versités de France) e quella di W.C.A. Ker della Loeb Classica!
Library. E, caso per caso, /ides penes auctores en·t . . . (Ps. Seneca,
Apocolocyntosis,5 .2).
Avila, 15 marzo 2003
Selezione di saggi e articoli utilizzati:
W. Allen et al., Martial knight, publishera nd poet, in q 65, 1970, p. 345 ss.
E.E. Best, Martial readersi n the Roman world, in CJ 64, 1969, p. 208 ss.
F. Castagnoli, Roma nei versi di Marziale,i n Athenaeum 28, 1950, p. 67 ss.
M. Citroni, Motivi di polemica letterariai n Marziale,i n DArch 2, 2, 1968,
p. 259 ss.