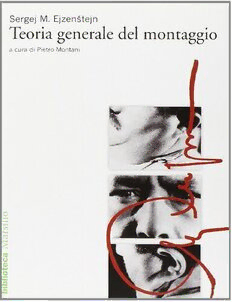Table Of ContentSergej M. Ejzenstejn
TEORIA
GENERALE
DEL MONTAGGIO
a cura di Pietro Montani
Con un saggio di Francesco Casetti
Marsilio
© 1985 BY MARSILIO EDITORI S.P.A. IN VENEZIA
Titoli originali
Izbrannye proìzvedenija v Sesti tomach (Opere scelte in sei volumi), Mosca, Iskusstvo, 1963-1970
Montai (II montaggio), voL n
Traduzioni dal russo di Cinzia De Coro e Federica Lamperini
Fotografìe di Gastone Predieri
ISBN 88-317-4828-9
Prima edizione: novembre 1985
Terza edizione: giugno 1992
INDICE
ix L’immagine del montaggio di Francesco Caselli
TEORIA GENERALE DEL MONTAGGIO
3 Prefazione
5 Abbozzi per un’introduzione
11 H montaggio nel cinema della ripresa da un unico punto
11 La composizione dell’inquadratura
19 «L’arresto di Vautrin»
27 Una barricata
42 Rappresentazione, immagine, generalizzazione, atteggiamento
56 Qué viva Mexico!
64 La deformazione della veridicità
78 Percorsi architettonici. L’Acropoli e l’Altare del Bernini
102 Percorsi pittorici II ritratto della Ermolova
120 Serov, Repin, Surikov
129 II montaggio nel cinema della ripresa da più punti
129 L’Urphànomen cinematografico: dai fotogrammi all’immagine del
movimento
150 H montaggio di più inquadrature
163 L’origine del montaggio al cinema: l’assenza del corpo vivo
169 La riviviscenza
178 I metodi dell’attore: Stanislavski) e Ignazio di Loyola, James e
Lessing
201 II montaggio nella letteratura. Le opere patetiche
210 Rappresentazione, immagine, datiti, processo
226 La nascita del montaggio: Dioniso
231 II corpo, il nome, la biografia
250 Ancora sull’Urphànomen cinematografico: da Shakespeare a Joyce
257 Puskin montatore
257 La battaglia con i pecenieghi e Pollava
267 Palle di ghisa
283 II montaggio nel cinema sonoro
283 II ritmo
289 D sonoro nel cinema muto. Sciopero, Ottobre, Potemkin
298 La voce, il gesto
304 Di nuovo Puskin: il contrappunto
316 Rappresentazione e immagine nelle tre fasi del cinema (un quadro
generale)
328 La comparabilità di immagine e suono
339 Orizzontalità e verticalità
355 Orizzontalità e verticalità: esempi precinematografici
366 «Entra una ragazza»
371 Tre modi della sincronia verticale: ritmo, melodia, colore
380 Ancora sul colore
387 La stereoscopia
394 L’immagine sintetica
400 Tolstoj. Anna Karenina. Le corse
406 Una narrazione commossa (a mo’ di conclusione)
419 Note del curatore
431 Indice dei nomi
L’IMMAGINE DEL MONTAGGIO
1. Uno scritto ejzenstejniano
Questo libro è il terzo delle Opere scelte di Ejzenstejn ad essere
pubblicato dalla Marsilio, e nel piano generale dell’edizione curata da
Pietro Montani costituisce il primo tomo del iv volume. Esso contiene il
lungo scritto noto convenzionalmente sotto il nome di Montaggio 37: un
testo iniziato nel 1935, ripreso nel giugno 1937, e mai portato a termine.
Il fatto che Ejzenstejn non abbia concluso il lavoro non deve certo
stupire: al contrario, si tratta di un dato ricorrente nell’opera sia filmica
sia saggistica di questo autore. Basta pensare a come il Potèmkin sia nato
quale semplice episodio di un ciclo più vasto, mai completato; o a come
Qué viva Mexico! sia stato progettato, riprogettato, e ri-riprogettato in
continuazione, prima e dopo le riprese; o a come Ivan sia passato da un
film a due, da due a tre. Parallelamente, nelle pagine di Ejzenstejn si fa
continuamente cenno a dei libri da scrivere, magari avviati e mai chiusi:
si pensi a Grundproblem o a Metod, impegni spesso ricordati - la
riflessione avrebbe dovuto rivelare le proprie ragioni ultime - e nondi
meno mai compiutamente onorati. Dunque il non finito costituisce un
motivo fisso nel panorama ejzenstejniano: del resto, se la scrittura è per
davvero, come qui, il luogo di uno scavo e di una autoconfessione, non
può non rischiare l’interminabilità propria - si dice - d’ogni analisi.
Tuttavia l’incompiutezza di questo scritto ha un che di particolare.
Da un Iato essa è messa in risalto dal fatto che le tesi esposte sono state
riprese in una serie di articoli editi tra il 1939 e il 1941 e poi confluiti nel
volume The Film Sense1. Riprese, ma anche compresse rispetto al quadro 1
1 New York, Harcourt, Brace and Co, 1942. T rad. it. in Forma e tecnica del film e lezioni di regia,
Torino, Einaudi, 1964 (si tratta della sez. «Tecnica del cinema»).
X Francesco Casetti
mobilitato nella prima sede: se si vuole, rese unilaterali dallo stesso
Ejzenstejn, ma contro il proprio costume. Dall’altro lato l’incompiutezza
dello scritto è stata accentuata dalla sua pubblicazione nel 1964 nel n
volume delle opere scelte russe: le omissioni vi abbondavano, dovute sia
a un insufficiente lavoro di ricostruzione del manoscritto, sia a delle
presumibili ragioni di opportunità. Quest’edizione fa giustizia di quei
buchi: grazie al lavoro di Naum Klejman, vedono la luce brani fin qui
assolutamente inediti, e che riguardano punti cruciali come l’interpreta
zione del mito di Dioniso, i riferimenti a Freud, la lettura di Joyce ecc. Ma
soprattutto vengono ripristinati due caratteri essenziali dello scritto:
l’uno è il suo svolgimento volutamente oscillante (si potrebbe dire,
ricordando una figura cara all’autore, spiraliforme), ricco di accostamen
ti spericolati e di salti improvvisi, di ritorni all’indietro e di rilanci
calcolati; l’altro è la sua funzionalità rispetto al momento in cui viene
steso, e cioè il suo voler servire insieme da dichiarazione di intenti, da
spunto polemico, da autoritratto, e persino da atto finale del dibattito in
corso. Insomma, quest’edizione può ben vantarsi di essere un’autentica
«prima»: essa ci restituisce finalmente appieno la ricchezza di un testo sia
pur in fieri, e nello stesso tempo ci dà modo di possedere una nuova
prova dello stile e delle strategie ejzenstejniane.
Anche per sottolineare la novità del volume, con il curatore si è
deciso di dargli un titolo che si discosti da quello in uso. Del resto, come
si è detto, Montaggio 37 era un nome convenzionale, nato solo di recente
quale calco del titolo assegnato da Ejzenstejn ad uno degli articoli poi
raccolti in The Film Sense (Montai. 1938), e non universalmente accetta
to. Teoria generale del montaggio ci sembra invece rispondere meglio agli
scopi e alla natura del saggio, per almeno due ragioni. Innanzitutto si
tratta di un’indagine a tutto campo, che tende a cogliere del concetto in
questione l’intera gamma delle sfumature e l’intero campo dei riferimen
to; se si vuole, ogni implicazione e ogni applicazione. In questo senso la
teoria è «generale» perché è generale il disegno che la sostiene. In
secondo luogo si tratta di un’indagine volutamente oltre misura, che
oltre ad attraversare in tutta la sua estensione il concetto, punta anche a
farlo esplodere. Essa infatti sostiene che se si vuole afferrare per davvero
la natura del montaggio, bisogna evidenziarne fino all’esaltazione le linee
di forza: ne risulterà una sorta di formula fondamentale, o di principio
costante, riconoscibile proprio a causa della permanenza di certi tratti
essenziali, e operante nel cinema così come in altri numerosissimi feno
meni - o forse attivo in esso in quanto presente anche altrove - In questo
senso la teoria è «generale» perché mira a generalizzare il concetto su cui
L’immagine del montaggio XI
lavora. Del resto, una tale manovra corrisponde bene all’ipotesi che
sottende il saggio: per avere un’intelligenza delle cose, quali esse siano,
non basta descriverne i contorni, ma bisogna coglierne il disegno inter
no, smontandole nelle loro diverse componenti e ricostruendole subito
dopo secondo imo «schema» o un «diagramma» che ce ne restituisca la
struttura complessiva e la dinamica portante. Detto meglio, per afferrare
una realtà non basta rappresentarla episodicamente, ma si deve darne
un’immagine esemplare attraverso un gioco di confronti e di stratifica
zioni, di smembramenti e di ridistribuzioni, di accumulazioni e di corre
lazioni; insomma, attraverso un intervento formale. Il montaggio è ap
punto lo strumento principe di un tale intervento: ma per coglierne le
ragioni e il funzionamento bisogna che anch’esso, come ogni altra cosa,
sia lavorato a fondo, grazie ad una continua scomposizione e ricomposi
zione delle sue presenze. Anche il montaggio, insomma, se vuol essere
compreso, deve essere «montato». Dunque mai come qui l’oggetto della
ricerca e i presupposti dell’analisi si ritrovano strettamente congiunti: il
saggio osserva un fenomeno, e gli applica le stesse regole che esso ha
aiutato a scoprire.
Ma con questo siamo già arrivati ad uno dei nodi centrali dello scritto
ejzenstejniano. Diciamo allora, per procedere con il maggior ordine
possibile, che il saggio ci pare possa essere affrontato soprattutto con tre
chiavi di interpretazione, che rimandano rispettivamente alle vicende
politico-culturali dell’autore, al dibattito teorico sul cinema, e alle forme
del sapere novecentesco.
2. Trentacinque, trentasette
Iniziamo dal piano di lettura per così dire autobiografico. Gli anni tra
il 1935 e il 1937 sono per Ejzenstejn assai delicati. Egli esce da una serie
di cocenti delusioni: dopo l’entusiasmo unanime attorno al Potèmkin, né
Ottobre ( 1927-28) né 11 vecchio e il nuovo ( 1928-29) erano stati altrettan
to ben accolti; la trasferta americana per Qué viva Mexico! (1930-31) si
era rivelata un’autentica trappola; il ritorno in Russia ( 1932) era coinciso
con delle gravi difficoltà, sia sul piano privato - la rottura del sodalizio
con Aleksandrov -, sia sul piano pubblico - l’affermarsi del realismo
socialista, nettamente divergente rispetto alla linea di ricerca ejzenstej-
niana -; i progetti via via presentati, come MMM, Mosca o Sua Maestà
nera, avevano incontrato aperte diffidenze; l’attività si era limitata all’in
segnamento presso l’istituto di cinematografìa e a qualche consulenza.