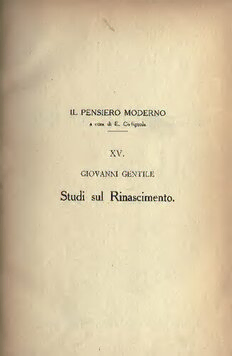Table Of ContentIL PENSIERO MODERNO
a cura di E. Co lignola
XV.
GIOVANNI GENTILE
Studi sul Rinascimento.
UJ- J
G^. ^' s
GIOVANNI GENTILE
Studi Rinascimento
sul
VALLECCHI EDITORE FIRENZE
s
PROPRIETÀ LETTERARIA
Firenze, 1923-Stabilimenti Grafici A. Vallecchi: Via Ricasoli 8, Via S. Zanobi 64,
I.
Le traduzioni medievali di Platone
e Francesco Petrarca.
i.
I dialoghi di Plafone posseduti dal Petrarca.
i.
Nella sua bella opera sul Risorgimento filosofico nel
Quattrocento *) il Fiorentino, riassumendo l' importante
polemica del Petrarca, nel De sui ipsius et multorum
ignorantia (1367-1368) 2 contro gli averroisti di Ve-
)
nezia, scrisse: «Un errore de* suoi avversari però tiene
a confutare,—ed è che Platone ha scritto assai meno di
Aristotele. ' Ho io a casa, sedici, o anche più (sexdecim
vel eo amplius) de' libri—di Platone, ed ei dicono che ne
ha scritto uno o due \ Allora, difatti, di Platone non
si conosceva altro che il Timeo con V interpretazione di
Calcidio. Perciò il Petrarca argomenta che a questa no-
tizia i suoi contraddittori rimarrebbero stupefatti : stu-
pebunt, si haec audiant. Una certa meraviglia farà anche
oggidì il sapere che non solo in greco, ma tradotti in la-
tino aveva il Petrarca alquanti dialoghi non visti per
lo avanti perchè di questa traduzione non han fatto
;
') Napoli, Tip. d. r. Univ., 1885, p. 181 e n. 9 a p. 194.
*) Cfr. G. Zippel, Giunte e correzioni al Risorgimento del
Voigt, Firenze, Sansoni, 1897, p. 2.
menzione neppure coloro, che han discorso dei libri pla-
tonici posseduti dal gran poeta. Da chi fossero stati tra-
dotti il Petrarca non dice : a me sembra, per quanto
posso indurre dal periodo intricato e monco, potersene
credere autore quel Bernardo di Seminara, che, fatto
monaco Basiliano, prese nome di Barlaam, e che al Pe-
trarca fu maestro di greco ».
Il periodo, su cui il Fiorentino fondava la sua conget-
tura, era da lui riferito in nota così : « Neque graecos
tantum, sed in latinum versos aliquot numquam alias visos
[Platonis libros] aspicient.... et quota ea pars librorum est
Platonis, quota ego his oculis multos vidi, praecipue cala-
bruni Barlaam modernum graia [graiae?] specimen sophiae
qui me ete. » 4). Quindi il Fiorentino osservava : « Il
periodo è certamente monco, perchè la sintassi non corre
;
e parmi, che tra il vidi ed il praecipue ci sia un distacco
di periodo e di pensiero ». Il periodo era corrotto senza
dubbio, non solo per il distacco notato dal Fiorentino,
ma anche per quel secondo quota che non rende un senso
accettabile. E deriva infatti da una falsa correzione del
quora (per quorum) che dà un'edizione precedente (Ba-
silea, 1554, p. 1162). Ma in che modo da un tal periodo
inintelligibile il Fiorentino poi inducesse, come cosa pro-
babile, doversi la traduzione accennata dal Petrarca at-
tribuire a frate Barlaam, è ciò che difficilmente si potrebbe
intendere da chi non conoscesse il fare del Fiorentino,
dotto e acuto e anche pazientissimo ricercatore, ma sde-
gnoso sempre di quelle minute avvertenze, che occorrono
nei punti più delicati di ogni indagine storica.
1/ induzione del Fiorentino piacque a Giannantonio
Mandalari, in quella specie di panegirico, non privo, per
altro, d' interesse, che egli compilò di Bernardo da Se-
minara 2 curiosa figura, meritevole tuttavia di essere
) :
studiata e meglio apprezzata che non sia. Il Tocco, invece,
l) Opera, ed. Basilea, 1581, p. 1854.
a Fra Éarlaamo calabrese maestro del Petrarca, Roma, Ver-
)
desi, 1888, p. 105.
— —
7
in una sua erudita recensione dell'opera del Fiorentino 1
),
aveva detto : « Da un passo delle Opere del Petrarca....
egli ricava una notizia sfuggita a quanti si occuparono
del Platonismo nei tempi moderni, che cioè il gran poeta
avea presso di sé sedici o più dialoghi di Platone in una
traduzione latina, che il Fiorentino forse troppo ardita-
mente sospetta gli sia stata fatta da quel Bernardo da
Seminara, o Barlaam, che gli aveva insegnati i rudimenti
di greco ».
Il Fiorentino veramente non aveva indotto che tutti
ciisòedcihcieonpoinùsdairaelbobgehisatvaetsoseafiflatPteotrcaorncfaotrrmaedotatlitienstloatinmoa;
;
alquanti (— aliquot). Il Tocco poi, che dà in nota la le-
zione corretta del passo riuscito inintelligibile al Fioren-
tino, servendosi delle due edizioni più antiche, e assai
migliori, di Venezia (1501 e 1503), non avrebbe dovuto
dire soltanto forse troppo ardito il sospetto del Fioren-
tino, ma addirittura erroneo. Come infatti può restare
più dubbio leggendo : « .... et quota ea pars librorum est
Platonis, quorum ego his oculis multos vidi, praecipue
apud Calabrum Barlaam, modernum grajae specimen
sophiae)), come legge il Tocco? 2).
La questione fu ripresa e trattata di proposito con
profondità dal De Nolhac 3). Il quale cominciò, giusta-
mente, dal riferire tutto il passo del De ignorantia, se-
condo il testo autografo (Vat. 3359, f. 28), ma con un' in-
terpunzione, di cui dichiarò di assumere la responsa-
bilità, poiché modificava il senso attribuito finora alle
parole del Petrarca. Mi sia permesso, per la più facile
intelligenza della discussione, di riferire, alla mia volta,
{) Nel Giorn. stor., VII, 409.
2 Op. cit., p. 410 n.
3) Pétrarque et l'humanisme d'après un essai de restitution
de sa) bibliothèque Paris, 1892, pp. 323 e sgg. Nella 2a ed. remaniée
et augmentée, del,1907, il De Nolhac ha poi modificato e corretto
questa, parte del libro, avvertendo molto cortesemente di aver
«tire profit de l'étude critique.du morceau qu'a faite Giov. Gen-
tile» (II, 135 n.). Io qui continuo a riferirmi alla prima edizione,
dove non sia avvertito il contrario.
—
8
la lezione dell'autografo qual'è data dal De Nolhac ac-
canto alla lezione della prima edizione del De ignorantia ì
),
che a me pare tutt'altro che trascurabile (riproduce essa
T importante cod. Marciano ci. lat. VI, n. 86 ?), e che
il De Nolhac non vide 2).
\Vat. 3359; De Nolhac, [Ed. veneta, 1501].
PP- 324-5]- .... Platonem, prorsum illis et
Platonemprorsum illis etin- incognitum et invisum, nil
cognitum et invisum nil scrip- scripsisse asserunt preter
sisse asserunt, preter unum unum atque alterum libel-
atque alterum libellum, quod lum quod non dicerent, si
;
non dicerent, si tam docti tam docti essent, quam me
essent quam me predicant in- predicant indoctum. Nec lit-
doctum. Nec literatus ego, teratus ego, nec grecus,
nec Grecus, sedecim vel eo sexdecim vel eo amplius Pla-
amplius Platonis libros domi tonis libros domi habeo, quo-
habeo, quorum nescio an u 1- rum nescio an u 11u m isti
1iu s isti unquam nomen unquam nomen audierint.
audierint. Stupebunt ergo, si Stupebunt ergo si hec au-
haec audiant; si non cre- diant. Si non credunt, ve-
dunt, veniant et videant. Bi- niant et videant. Bibliotheca
bliotheca nostra tuis 3) in nostra tuis in manibua re-
manibus relieta, non illite- lieta, non illitterata quidem
rata quidem illa, quamvis illa quamvis illitterati homi-
illiterati hominis, neque illis nis, neque illis ignota est
ignota est, quam totiens me quam totiens me temptantes
tentantes ingressi sunt. Semel ingressi sunt. Semel ingre-
ingrediantur et Platonem ten- diantur et Platonem tenta-
taturi an et ipse sine literis turi, an et ipse sine litteris
sit famosus ; invenient sic sit famosus. Invenient sic
4) In Opuscula Francisci Petrarche «impressa Venetiis
A(inmnpoenisnicsadrn.anitiAonndisreCehrTiostrir,esMacnciccdcej.Asduilea.)XpXerVISiJm.omnaercmi]de»,Lfu.e7rev.:
*) Gita solo l'ediz. 1581.
3) Il trattato è indirizzato, come è noto, all'amico Donato
degli Albanzani, alle cui cure il Petrarca, trasferitosi a Padova,
aveva affidato i suoi libri lasciati in Venezia. Vedi lo stesso De
Nolhac, O. c. p. 70.
esse ut dico meque licet igna- esse ut dico, meque licet
rum, non mendacem tamen, ignarum, non mendacem ta-
ut arbitror, fatebuntur. Ne- men ut arbitror fatebuntur
. :
que Grecos tantum, sed in neque grecos tantum, sed in
Latinum versos aliquot nun- latinum versos aliquot num-
quam alias visos aspicient. quam alias visos aspicient *).
Literatissimi homines de qua- Litteratissimihomines de qua-
litate quidem operum iure litate quidem operum iure illi
illi suo iudicent (de numero suo iudicent. De numero au-
autem nec iudicare aliter tem nec iudicare aliter quam
quam dico, nec litigare liti- dico, nec litigare litigiosissimi
giosissimi homines audebunt) homines audebunt. Et quota
et quota ea pars librorum ea pars librorum est Plato-
est Platonis. Quorum ego his nis, quorum ego hijs oculis
oculis multos vidi, precipue multos vidi precipue apud
Barlaam Calabrum, moder- Calabrum Barlaam modernum
num Graie specimen sophie, graye specimen Sophie, qui
qui, me Latinarum inscium me latinarum inscium, do-
docere Grecas literas adortus, cere grecas litteras adortus
forsitan profecisset, nisi mi- forsitan profecisset, nisi mihi
chi illum invidisset mors hone- illum invidisset mors, hone-
stisque principiis obstitisset, stisque principiis obstitisset,
ut solita est. ut solita est.
Le varianti più notevoli sono due nel secondo pe-
:
riodo Yullius dell'autografo è certo preferibile alYullum
dell'edizione veneta (e delle due edizioni di Basilea). E
nell'ultimo periodo Yapud dell'ediz. veneta, che sanava
la sconcordanza notata dal Fiorentino nel testo dell'edi-
zione basileense del 1581, comune alla precedente edi-
zione, pure di Basilea del 1554 2), manca invece nella
lezione data come dell'autografo, e senza la necessità di
integrare o correggere. Il De Nolhac crede infatti che tutto
questo tratto possa e debba esser inteso in modo ben
diverso che non si sia fatto finora, proponendo degli ul-
l) Non aspiciunt, come dà inl Tocco, 1. e.
*) Anche questa dice (p. 62) : amultos vidi, precipue Ca-
labrum Barlaam modernum Graia [sic] specimen sophiae ».
— —
IO
timi periodi questa traduzione : « Ils ne trouveront pas
seulement dans ma bibliothèque des ouvrages en grec, mais
encore plusieurs traduits en latin qu'ils n'ont jamais vus
ailleurs [allusion aux traductions plus loin mentionnées].
Que les gens très lettrés jugent suivant leur droit de la qua-
nte des ouvrages (car pour la quantité, les plus ergouteurs
ne pourront ni ergoter, ni en juger autrement que je ne
dis), et qu'ils constatent quelle partie de ces ouvrages est de
Platon. De ces gens très lettrés, j'en ai vu de mes yeux beau-
coup et tout d'abord Barlaam le calabrais.... » 1).
Sicché : i.° i libri non Greci tantum, sed in latinum
versi non sarebbero tutti secondo il De Nolhac dialoghi
ma
platonici ; libri di scrittori greci, in generale, fra i
quali se ne troverebbero anche di Platone (des ouvrages....
;
quelle partie de ces ouvrages est de Platon) ; 2. i molti
visti dal Petrarca, con gli occhi suoi, sarebbero gens très
lettrés, non libri e tanto meno libri di Platone.
;
Due cose, a mio giudizio, insostenibili. Non è sosteni-
bile la prima perchè il Grecosnonsipuò riferire se non agli
ultimi libri di cui il Petrarca haparlato, che sono i sedecim
vel eo amplius Platonis libros del secondo periodo. In
mezzo non c'è altro sostantivo di genere maschile e nu-
mero plurale, salvo il soggetto sottinteso di stupebunt,
audiant, veniant etc, il quale però sarà anche soggetto
dell'aspicient di cui Grecos è oggetto senza dire che gli
;
avversari del Petrarca non potevano esser tradotti in
latino
!
Ma questa tesi, soprattutto, non è sostenibile per il
modo in cui si verrebbe a tradurre la proposizione : « et
quota ea pars librorum est Platonis ». Quando il De Nolhac
traduce « et qu'ils constatent quelle partie de ces ouvrages
est de Platon » intende Yea pars librorum come se invece
fosse detto : pars eorum librorum ; laddove il testo non
può altrimenti spiegarsi che intendendo quel quota pars
come esclamativa (= quam 2) parva !) : «e che piccola
') Op. cit., p. 329, n. 3.
2) Correggo qui l' interpretazione che ne avevo dato nella
prima edizione di questo scritto, in cui intendevo il «quota pars »