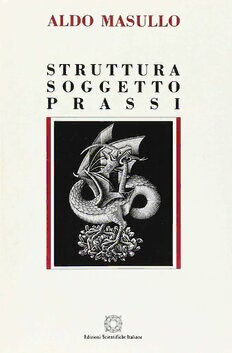Table Of ContentALDO MASULLO
STRUTTURA
SOGGETTO
P R A S S I
-
Edizioni Scientifiche Italiane
In memoria
di mio padre
che /,a sua vita e /,a sua morte
patì
con umiltà virile
Avvertenza
I materiali di ricostruzione storica e di riflessione teorica, rac
colti nel presente volume, mi appaiono oggi, nella loro organicità,
come il prospettico intreccio del lungo e complesso itinerario di
ricerca che, delineatosi nel lontano 1960, in forte controtendenza
rispetto alla cultura filosofica italiana di quel periodo, non ha mai
cessato d'impegnarmi, come ancora nel 1990 documentava il libro
Filosofie del soggetto e diritto del senso.
Sollecitato da molti amici, italiani e stranieri, a restituire alla
comune accessibilità quei materiali, mi sono ora deciso a pubblicar
ne la revisione.
L'autorevole collega prof. Bianca Maria d'Ippolito con la fedeltà
dell'antica allieva e la competenza dell'assidua studiosa si è generosa
mente impegnata nella selettiva e aggiornata sistemazione dell' ap
parato bibliografico. Le esprimo la mia viva riconoscenza.
Un cordiale ringraziamento debbo alla fattiva cortesia del dott.
Michele Gallo per l'attenta cura editoriale.
A.M.
Napoli, maggio 1994
PARTE PRIMA
LA NOZIONE DI STRUTTURA
NEI LINGUAGGI SCIENTIFICI
E L'APPROCCIO AL SOGGETTO
«Qui si tratta di una effettiva protesta
dell'empiria contro l'empirismo»
(YORCK di WARTENBURG)
I. - l LINGUAGGI E IL CAPIRE
§ 1. Compito e limiti della ricerca
Un illustre storico della filosofia ha osservato che «uno dei tratti
più rimarchevoli del pensiero contemporaneo è certamente il re
gresso dei problemi di genesi, d'origine, d'evoluzione a profitto dei
problemi di struttura»1
•
È forse preferibile, per introdurre un discorso al proposito, tra
durre questa osservazione in una forma più elementare e più guar
dinga, e limitarsi a dire che nella cultura contemporanea, sopratutto
a partire dalla fine del secolo scorso, si è venuto sempre più intensi
ficando l'impiego del termine struttura, «una parola - come scrive
va il Russell nel 1918 - che, malgrado la sua importanza, non è
stata mai definita in termini precisi da chi l'ha usata»2
•
La stessa espansione del suo impiego nelle più varie discipline,
all'interno quindi dei più diversi linguaggi scientifici, attesta che il
termine in questione non ha fino ad ora, a quaranta anni di distan
za dall'appunto del Russell, ricevuto uno status semantico ben de
finito.
Tuttavia una così crescente fortuna della parola nel contesto di
linguaggi, che peraltro tendono a farsi sempre più rigorosi, è un
forte indizio che nel suo uso si nasconda una vera e propria cate-
La nozione di struttura nei linguaggi scientifici 13
paginare la trama stessa del nostro essere, mettere a nudo l'intricata
storia dei processi vissuti che in vario modo condizionano il pro
cesso che attualmente viviamo.
Così ognuno sperimenta, nella vita quotidiana e nel linguaggio
che la esprime, le «cose tanto usuali e pur tanto oscure» di cui
parla S. Agostino, e di cui un esempio limite è il tempo, il quale
cosa sia «se nessun~ me lo domanda lo so: se voglio spiegarlo a chi
me lo domanda, non lo so più». Perciò, come osserva Berkeley,
«alla gran massa degli uomini, che va per la strada maestra del
semplice senso comune, nulla di ciò ch'è familiare sembra strano o
difficile a capire; ma, non appena ci scostiamo dai sensi e dallo
istinto per seguire la luce di un principio superiore, per ragionare,
meditare e riflettere sulla natura delle cose, mille scrupoli sorgono
nella nostra mente su quelle cose, che innanzi ci pareva di com
prendere pienamente». Nella lapidaria espressione hegeliana: «il noto
in genere, appunto in quanto è noto, non è conosciuto»4.
Questa considerazione getta luce sul senso stesso della filosofia.
Proprio perché la filosofia mette in problema la vita ch'è la più
usuale di tutte le cose, il suo oggetto è il più oscuro di tutti. Ciò
che si vive si esprime in un linguaggio vissuto, spontaneo e quo
tidiano: il linguaggio comune, proprio perché spontaneo, esprime
la ricchezza della nostra realtà e delle sue leggi; ma appunto espri
me tutto ciò; lo certifica, ma non lo spiega; lo presenta, ma non lo
chiarisce; è in una parola altrettanto oscuro.
I linguaggi scientifici sono anch'essi, come ogni linguaggio, vissu
ti, ma non sono spontanei e quotidiani, bensì deliberatamente esco
gitati per definire oggetti che non sono vissuti, appunto perché
mediati dai linguaggi e da essi condizionati.
Il vivere fonda il linguaggio quotidiano. I linguaggi scientifici
sono invece essi che fondano i loro oggetti, gli oggetti scientifici.
Pertanto gli oggetti scientifici non sono vissuti in sé, ma in quanto
risolti nei linguaggi relativi: basta riferirli al lessico ed alla sintassi
del linguaggio cui appartengono, per comprenderne il significato.
Invece non si può interpretare il linguaggio spontaneo se non
risalendo all'immediatamente vissuto che in esso si esprime, cioè
proprio a ciò che, per essere la nostra stessa vita, è radicalmente
irriducibile. Sono gli oggetti scientifici, attraverso i rispettivi lin
guaggi, che cercano il proprio senso ultimo nella totalità concreta,
la vita, da cui sono stati per altrettanti processi astrattivi enucleati,
12 Parte prima
goria, valida a caratterizzare una certa situazione culturale e defini
re in modo unitario un momento della storia scientifica3
•
Questa ipotesi, ove fosse confermata dallo sviluppo della ricer
ca, getterebbe luce su di un cospicuo esempio di connessione e
solidarietà inter-linguistica, contribuendo a mostrare in tale connes
sione e solidarietà un aspetto saliente di ogni situazione culturale e
specificamente scientifica: la categoria di struttura apparirebbe così
come la struttura d'un certo mondo culturale; la sua presenza in
contesti linguistici diversi esprimerebbe in un caso particolare la
connessione e solidarietà inter-linguistica come qualità .s trutturale
d'ogni cultura.
Di una simile indagine non si possono, in questa sede, che ab
bozzare, a mo' di esemplificazione, alcuni aspetti, omettendo anche
solo un cenno a proposito di molti altri.
La presente ricerca, esaminando la trama evolutiva di alcuni
linguaggi scientifici contemporanei, intende limitarsi a chiarire la
portata della nozione di struttura nella stretta misura in cui ciò può
permettere alla filosofia un più efficace approccio al concreto sogget
to della realtà, all'uomo operante.
§ 2. Livello dei linguaggi spontanei e livelli dei linguaggi sdentifid
La nostra odierna situazione culturale è spiccatamente caratte
rizzata dalla pluralità dei linguaggi come pluralità di livelli analitici,
variamente determinati secondo gli specifici problemi, cioè difficol
tà vitali, alla cui impostazione in termini di risolvibilità quei linguaggi
debbono servire. L'oggetto teoretico specifico d'ogni disciplina è
invero determinato dal metodo relativo, il quale a sua volta si viene
costituendo attraverso un processo di adattamento operativo del
ricercante alle difficoltà vitali eh' egli avverte di dover superare.
Ora, mentre il linguaggio quotidiano, cioè qualsiasi linguaggio
storicamente parlato, preso a livello di uso, nella sua funzione pra
gmatica, è immediatamente comprensibile, purché non lo si analiz
zi, i linguaggi scientifici invece tanto meno immediatamente si com
prendono quanto più sono formalizzati, e tuttavia, sottoposti ad
analisi adeguate, quanto più sono formalizzati e quindi non imme
diatamente comprensibili, tanto più consentono una comprensione
piena e senza residui: Analizzare il linguaggio quotidiano è scom-
La nozione di struttura nei linguaggi scientifici 15
teorema di geometria, per cui occorrono speciali conoscenze. Il
teorema si capisce, risolvendo i termini che vi giocano nel sistema
linguistico della geometria adottata, ossia nei riferimenti ad un
complesso sistema di ben determinate relazioni di significanza.
Capire il dolore altrui appare, a chi ben guardi, cosà, per quanto
sémplice, ben più difficile che capire il teorema di geometria, che
pur è complesso: basta invero possedere determinate cognizioni
opportunamente apprese per capire del teorema il significato pieno
e senza residui, per risolverlo, scioglierlo, vanificarne la proble
maticità; per capire il dolore altrui invece, per quanto non occorrano
speciali cognizioni , è necessario avere la disposizione ad assumere
quello stesso atteggiamento psichico, avere la capacità di trasferirsi
nell'altro e di superare il proprio chiuso egoismo: cioè non lo si
può capire risolvendolo in una serie di riferimenti a ben determi
nate relazioni, ma soltanto vivendolo, e lasciandolo tuttavia sempre
chiuso in una sua problematica oscurità! Qui, in conclusione, il
semplice è proprio il più difficile a capirsi, quel che S. Agostino
chiama oscuro, poiché è ciò che si vive, e in quanto tale è usuale e
non formalisticamente, e cioè operativamente, analizzabile.
§ 4. Il semplice ed il complesso
Un secondo caso dell'opposizione tra semplice e complesso è
quello della diversa portata del capire la costituzione di una mole
cola di ferro e del capire la costituzione d'un tavolo di ferro: in un
certo senso, il tavolo è più complesso rispetto alla molecola di
ferro, eppure è enormemente più facile capire la costituzione del
tavolo, del più complesso, che non quella della molecola di ferro,
del più semplice. Quanto più una cosa è semplice, tanto più è
difficile a comprendersi poiché una cosa complessa in linea di prin
cipio può ricondursi prima o poi a cose più semplici, mentre una
cosa semplicissima non può ricondursi a cose più semplici ancora.
In linea di fatto, cose semplicissime in senso assoluto non ve ne
sono: una cosa semplice è solo una cosa più difficilmente riducibile
a cose più semplici. Una cosa molto complessa ha la sua difficoltà
solo nella scelta e nel numero delle operazioni da compiere per
ridurla a cose meno complesse. Una cosa molto semplice invece ha
la sua difficoltà, ben più grave, nell'inesistenza, per lo meno allo
14 Pa,rte prima
ma la totalità concreta non può essere ricondotta ad altro: non può
essere fatta rientrare a sua volta come parte analitica di un tutto che
sia esso stesso relativo, e perciò elemento di un linguaggio, all'in
terno del quale sia· perfettamente definito nelle sue relazioni, e perciò
determinabile nel suo significato.
§ 3. Capire d'uso e capire di riferimento
Capire è possibile almeno in due modi fondamentali. L'uno è
quello per cui le cose sono usuali, anche se restano oscure. L'altro
è quello per cui le cose diventano chiare, anche se ciò le fa essere
meno usuali che mai, a tal punto che, per acquistare un senso
vitale, debbono trapassare a loro volta in cose usuali, e quindi
ancora irrimediabilmente oscure.
Il primo modo è un capire d'uso, cioè un ripetere la cosa capita.
È un imitare. Perciò un filosofo della vita come Hamann poté
scrivere che senza la legge perfetta della libertà, cioè senza lo stato
naturale dei rapporti che legano l'uomo al tutto, «l'uomo non sa
rebbe capace di nessuna imitazione, su cui è fondata tutta la sua
educazione; giacché l'uomo è, fra tutti gli animali, il più grande
pantomimo»5
•
Il secondo modo di capire, invece, è un riportare la cosa ad
altre, un esplicitarne i riferimenti ad altre, in tali riferimenti ritro
vandosene il significato: ma ciò suppone che la cosa venga cifrata,
secondo un sistema linguistico già definito, all'interno del quale
essa assuma la .t itolarità di ben determinati rapporti con altre cose
cifrate in base al medesimo sistema. La cosa allora è trasformata in
oggetto ideale. ·
L'opposizione tra capire d'uso e capire di riferimento, ch'è poi
l'opposizione tra comprensione del senso e comprensione del signi
ficato, si configura variamente nella complessa fenomenologia del
conoscere. In conseguenza si configura variamente l'opposizione
tra il semplice, corrispondente all'usuale, ed il complesso, corrispon
dente a ciò il cui significato si rinviene nei riferimenti in cui esso
può risolversi.
Un primo caso è quello dell'opposizione tra «capire un dolore
altrui» e «capire un teorema di geometria»: semplice è capire il
dolore altrui, può farlo anche un incolto; complesso è capire un
La nozione di struttura nei linguaggi scientifici 17
d'una ruota a, poniamo, tremila giri al minuto, poiché non riesco
ad imitarlo percettivamente: la percezione è infatti intricata con il
movimento soggettivo in modo tale che l'impossibilità di questo è
impossibilità della percezione, secondo le acute osservazioni del
W eizsacker10
•
È evidente che, se a ciò che viene capito imitativamente ed appare
perciò usuale e semplice si volesse applicare un'intenzione di capire
nell'altra maniera, in quella che risolve la cosa da capire, mercé la
cifratura, in un termine di riferimenti relazionali all'interno di un
contesto linguistico formalmente determinato, allora tutto ciò che
appare per eccellenza semplice diverrebbe quanto di più oscuro si
possa immaginare, chiaribile solo attraverso preliminari processi di
traduzione dal linguaggio comune nei linguaggi formali appropriati.
Tuttavia già la scelta del linguaggio formale, e del corrispondente
metodo d'analisi del linguaggio comune, implicherebbe la volontà
di cercare quel tipo di soluzione del problema, condizionato dal
tipo di linguaggio adottato; non si escluderebbe pertanto la possi
bilità di tradurre con un altro linguaggio quella stessa esperienza in
un altro problema per un altro tipo di soluzione.
Si precisa, a questo proposito, la distinzione tra la materia della
indagine e l'oggetto dell'indagine. L'oggetto è definito dallo stesso
linguaggio più o meno formalizzato della ricerca, direi che è il
senso totale di questo linguaggio ed è perciò tanto più rigoroso ed
univoco quanto più il linguaggio è formalizzato. La materia invece
è il campo di esperienze vissute ed espresse nel linguaggio comune,
entro il cui raggio operano la selezione e la cifratura di un certo
linguaggio formalizzato. Le scienze cosiddette antropologiche, ad
esempio, hanno tutte la medesima materia, l'uomo, ma l'oggetto
dell'etnologia, quello della biologia umana e quello della psicologia
esistenziale, poniamo, non sono certo un solo e medesimo oggetto.
Il che spiega come sia possibile concordare il principio formale, che
l'oggetto è definito dal linguaggio, con l'esperienza storica che ogni
linguaggio è sempre costruito a partire da certi contenuti: ogni
linguaggio formale invero, mentre condiziona logicamente il suo
oggetto, è condizionato dalla sua materia, cioè dal settore del lin
guaggio comune, ove si esprimono alcuni problemi del vivere, alla
cui soluzione quel linguaggio formale è appunto destinato.
Ogni capire di tipo scientifico resta una selezione ed un impove
rimento dell'esperienza per determinarla alla luce di un certo siste-