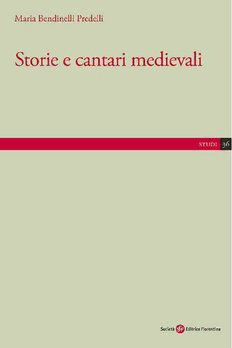Table Of Contentstudi
36
Maria Bendinelli Predelli
Storie e cantari medievali
Società Editrice Fiorentina
© 2019 Società Editrice Fiorentina
via Aretina, 298 - 50136 Firenze
tel. 055 5532924
[email protected]
www.sefeditrice.it
isbn: 978-88-6032-500-6
ebook isbn: 978-88-6032-508-2
issn: 2035-4363
Proprietà letteraria riservata
Riproduzione, in qualsiasi forma, intera o parziale, vietata
Indice
7 La Storia di Alessandro Magno
nel Palazzo Chiaromonte di Palermo
7 1. Storie medievali sul soffitto Chiaromonte
9 2. La storia di Alessandro Magno
12 3. Modelli iconografici
15 3.1 Manoscritti bizantini
17 3.2 Miniature del Roman d’Alexandre en prose
21 4. Cultura siciliana
23 5. L’ultima scena
26 6. Interpretazione complessiva
28 Manoscritti citati
31 Tirant lo Blanc e gli affreschi erotici di San Gimignano
31 1. Pitture profane
32 2. La parete nord
34 3. La parete est: la novella di Salabaetto («Decameron» VIII 10)
37 4. La parete est: «Tirant lo Blanc»
40 5. Una storia cortese
43 6. Al di là delle apparenze
47 Il Cantare di Madonna Elena
57 Recitazione e mouvance nel Cantare di Madonna Elena
67 La situazione iniziale nel Cantare di Madonna Elena
67 1. La gara di vanti
77 2. L’offesa della coppa
83 Preistoria del Cantare di Madonna Elena
o il ciclo romanzesco della scommessa
83 1. Introduzione
85 2. Antecedenti francesi
88 3. Il «miracolo» di «Guillermus Nivernensis»
90 4. Il «Cantare di Madonna Elena»
94 5. Un «Madonna Elena» fra i romanzi del Duecento?
97 6. Inflessione miracolistica
101 7. Altre consonanze
103 8. Conclusioni
107 Lettura in filigrana della novella di Zinevra
(Decameron II.9)
123 La Storia della dama bolognese che s’innamora
sentendo lodare un cavaliere dal marito
135 Fra cortesia, continenza e magnificenza:
reinterpretazioni di un motivo erotico
145 Il motivo del Fier Baiser fra letteratura e folklore
167 Opere citate
177 Indice delle illustrazioni
179 Indice dei nomi
La Storia di Alessandro Magno
nel Palazzo Chiaromonte di Palermo*
1. Storie medievali sul soffitto Chiaromonte
Le pitture dello splendido soffitto nel Palazzo Chiaromonte di Palermo (alias
«lo Steri»), realizzate fra il 1377 e il 1380, sono sempre apparse come una stra-
ordinaria enciclopedia dell’immaginario medievale nei suoi registri morale,
simbolico e romanzesco. La rapida decadenza della famiglia Chiaromonte,
pochi anni dopo la realizzazione del ciclo pittorico, e le conseguenti rifunzio-
nalizzazioni del palazzo («reggia aragonese, residenza ufficiale del Viceré, tri-
bunale del Patrimonio, tribunale dell’Inquisizione, sede degli uffici giudiziari
borbonici e dell’Italia sabauda»1 e oggi rettorato dell’Università di Palermo)
lasciarono però decadere la fama del soffitto, che incominciò a essere riscoper-
to e rivalorizzato soltanto alla fine dell’Ottocento2. Da allora, il lavoro di inter-
pretazione iconografica e simbolica delle immagini e delle sequenze pittoriche
è continuato fino a oggi, attraverso gli studi principalmente di Ettore Gabrici
ed Ezio Levi (1932), Ferdinanto Bologna (1975), Licia Buttà (2013 e 2015), An-
tonietta Iolanda Lima (2015)3.
Levi e Bologna identificarono con sicurezza, per esempio, le storie del
‘Giudizio di Salomone’, della ‘casta Susanna’, di ‘Giuditta e Oloferne’, di ‘Ele-
* Pubblicato dapprima in «Prospettiva», XLV (1986), pp. 13-21 e, parzialmente, col titolo
Un’interpretazione iconografica relativa al soffitto Chiaramonte di Palermo in Letteratura e arti figurati-
ve, Atti del XII Convegno AISLLI (Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura
Italiana), vol. I, Florence, Olschki, 1988, pp. 357-68.
1 F. Bologna 1975, p. 3.
2 G. Di Marzo 1899.
3 Francesco Carapezza ha commentato l’enigma di una delle scritte sul soffitto (F. Carapezza
2011), Andrea Canova ha analizzato attentamente i rapporti fra la storia di Elena di Narbona dipinta
sul soffitto e le sue versioni letterarie (A. Canova 2014), Maria Luisa Meneghetti ha incluso il soffitto
dello Steri nella sua rassegna di «storie al muro», soffermandosi sulle scene «tristaniane» (M.L. Me-
neghetti 2015, pp. 150-53).
8 storie e cantari medievali
1. Veduta della Sala Magna dello Steri verso la parete nord-est
na di Narbona’, episodi della storia di Tristano, lo svolgimento del lungo ciclo
troiano (dall’avventura di Giasone alla distruzione di Troia), estratti dell’Apo-
calisse… Il significato complessivo del ciclo pittorico è invece discusso, e tor-
neremo sulla questione alla fine dell’articolo. Non tutte le storie raffigurate sul
soffitto hanno però trovato la loro spiegazione: ancora molte sequenze riman-
gono indecifrate, o sono interpretate solo dubitativamente. In particolare le
facciate delle travi designate nello studio del Bologna come la XI-A-65 e XI-
B-214 furono interpretate dal Levi l’una come una qualche versione della leg-
genda del figlio del diavolo, l’altra come la rappresentazione dell’episodio clas-
sico di Fineo e le Arpie. Bologna sollevava dubbi sulle interpretazioni proposte
dal Levi, rilevando che in entrambe le facciate compare un elemento unifican-
te nella rappresentazione di un drago (e non di un’arpìa); e ipotizzava che le
due sequenze facessero parte di un’unica storia, in conformità di quanto si
verifica in tutti gli altri casi di travi istoriate sulla medesima facciata da en-
trambi i lati del soffitto4. Ciononostante il volume di Francesco Vergara Caf-
farelli (2009), che rendeva disponibili online i rilievi fotogrammetrici avvenu-
ti durante il restauro del soffitto, continuava ad avvalersi, per l’identificazione
delle immagini, dell’inventario fornito dal volume del Bologna; avviene così
che le immagini dipinte sulle trabeazioni in questione sono ancora definite
4 F. Bologna 1975, pp. 199-200.
La Storia di Alessandro Magno nel Palazzo Chiaromonte di Palermo 9
come «Presunta storia di Fineo e le arpìe» e «Presunta storia del figlio del dia-
volo», anche se si avverte che «molti particolari delle pur bellissime raffigura-
zioni risultano incongrui se confrontati con la tradizione a noi pervenuta di
questi miti e leggende»5.
2. La storia di Alessandro Magno
In realtà, la storia dipinta sulle travi XI-A-65 e XI-B-214 va identificata certa-
mente, in maniera unitaria come già intuito dal Bologna, con la parte iniziale
della storia di Alessandro Magno, quale era conosciuta nel Medioevo roman-
zo. Il romanzo di Alessandro ebbe una larghissima diffusione nel Medioevo, e
non solo in Europa; capostipite un’opera ellenistica del III secolo d.C., proba-
bilmente di origine alessandrina, attribuita a uno Pseudo-Callistene, che fu
tradotta, compendiata e diffusa in innumerevoli redazioni in tutti i paesi eu-
ropei nonché in larghe zone dell’Africa e dell’Asia6.
Ecco la storia, di cui si potrà controllare l’aderenza alle immagini rappre-
sentate sul soffitto dello Steri: Nectanebo, re dell’Egitto ed espertissimo
nell’arte magica, normalmente combatteva le flotte nemiche facendo delle na-
vicelle di cera, che poneva in una conca piena d’acqua piovana, e facendovi su
degli incanti con una virga ebenea; un giorno però, nel corso di un simile in-
canto, vide che gli dèi stessi dell’Egitto conducevano le navi nemiche. Perciò
si fece radere il capo, si travestì da indovino, e fuggì dall’Egitto, pervenendo in
Macedonia. Qui andò a visitare la regina Olimpia, una volta che re Filippo era
assente per ragioni di guerra, e nel corso del colloquio si innamorò della regina
Olimpia. Ne guadagnò la fiducia indovinando per arte magica il giorno il
mese e l’ora della nascita del re Filippo, e le predisse che il potente dio Ammo-
ne si sarebbe innamorato di lei, e che da lui avrebbe concepito un figlio che
sarebbe stato per sempre il suo difensore. La notte stessa, la regina vide effetti-
vamente in sogno il dio Ammone che, con in capo corna da ariete e una barba
da cane andava a far l’amore con lei. Il giorno dopo Nectanebo le disse che, se
avesse concesso a lui una camera nel suo palazzo, quello che Olimpia aveva
visto in sogno sarebbe avvenuto davvero.
Circa autem vigiliam primam noctis – sono le parole di una delle versioni latine della
storia – cepit Nectanebus per magicas incantationes transfigurare se in figuram draconis et
sibilando cepit ire contra cubiculum Olimpiadis ingressusque cubiculum, ascendens in
lectum eius cepit osculari eam et concumbere cum illa […]. Taliter decepta est Olimpiadis
concumbens cum homine quasi cum deo7.
5 F. Vergara Caffarelli 2009, p. 27.
6 Cfr. C. Frugoni 1978; G. Cary 1956); D. J. A. Ross 1988, particolarmente le tavole alle
pp. 26, 46, 52 e 60.
7 Der altfranzösische Prosa-Alexanderroman, p. 24.