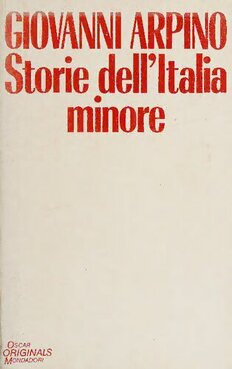Table Of ContentGIOVANNI ARPINO
orie dell’Italia
minore
ORIGINALS
Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
Kahle/Austin Foundation
https://archive.org/details/storiedellitalia0000arpi
GIOVANNI ARPINO
STORIE DELL'ITALIA
MINORE
Introduzione di Giovanni Tesio
ARNOLDO MONDADORI EDITORE
© 1990 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano
I edizione Oscar Originals giugno 1990
ISBN 88-04-33443-6
Questo volume è stato stampato
presso Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Stabilimento Nuova Stampa - Cles (TN)
Stampato in ltalia - Printed in Italy
Redazione: Maria Agrati
Introduzione
Dal 19 febbraio 1949 all’8 marzo 1966: diciassette anni di vita,
ottocentonovanta numeri. Sono le scarne cifre del «Mondo», il
settimanale fondato e diretto da Mario Pannunzio (1910-1968),
“a cui Arpino comincia a collaborare il 4 aprile 1953, quando ha
già alle spalle alcune esperienze di vita e di scrittura. Nel ‘50 è
partito per Genova, imbucandosi in una pensioncina di via
Prè, «classicamente lurida, umida, toposa, con vaste macchie
ambigue lungo le pareti, un lavandino di fronte al letto da ga-
lera, una finestruccia sghemba che dava su un vicolo, una te-
nutaria in bigodini e vestaglia, arcigna come la notte dei lupi
mannari», e ne è emerso come un gabbiano appesantito dal li-
quame con un romanzo di pìcari e di anime innocenti che Vit-
torini gli ha pubblicato nei «Gettoni», Sei stato felice, Giovanni
(1952), la laurea vera che viene dopo l’altra guadagnata l’anno
prima con una tesi su Esenin. Ora, volendo sposarsi, è in cer-
ca di soldi e di lavoro. Matrimonio e «Mondo» vengono ad un
punto; il distacco dalla cittadina di provincia in cui finora è
vissuto, salvo le pause di Genova e della vita militare a Lecce
e a Napoli, completano il momento cruciale.
Il primo articolo s'intitola Il contratto di marzo e parla di
mercato delle braccia sulle piazze di piccole città piemontesi,
Mondovì Carmagnola Bra Alba Saluzzo, perfettamente e obli-
quamente in tema con l'urgenza elusa dei patti agrari. La col-
laborazione dura sei anni ed è la prima — la maestra — di una
militanza giornalistica, che non è mai venuta meno. Nell'ulti-
mo articolo, I due carabinieri, apparso sul «Mondo» il 10 feb-
braio 1959, la cronaca viene quasi ad essere il frammento di
un possibile film felliniano: un night club visto nei passi di due
carabinieri incatenati al servizio.
Tra il primo e l’ultimo articolo corrono fatti nazionali e in-
ternazionali di enorme importanza: la legge truffa, la morte di
Stalin, le elezioni politiche del 7 giugno, la conferenza di Gi-
nevra, la morte di De Gasperi, il tramonto del centrismo, la
sconfitta della Fiom alla Fiat, il XX Congresso del PCUS e
l'Ungheria, l'accordo di Pralognan, il Mercato Comune, il
crollo delle destre, la morte di Pio XII e l'elezione di Giovanni
XXIII. Ma lo sguardo del giornalista-scrittore è più intento alle
pieghe di una realtà piccola: quella che cade ferialmente sotto
gli occhi, la porzione quotidiana degli eventi che non abitano
il teatro maggiore della storia; briciole tuttavia di un mondo
che - se ben investigato — spiegano «tutto» il mondo.
Non è diverso l'atteggiamento che contraddistingue il
narratore di storie; implica la stessa fiducia, presuppone lo
stesso scatto dello sguardo, include la stessa attitudine a rico-
minciare ogni volta umilmente, secondo le parole dell'autore,
«in lieta e attenta disposizione verso la realtà che lo circonda».
Il trasferimento da Bra a Torino lega lo scrittore da giovane al-
l'oscillazione di tutti: all'Italia in transito dalla campagna alla
città, dalla provincia all'Europa, dal mondo al Mondo. Vale
ancora per Arpino la gobettiana sollecitudine dell’«autobio-
grafia come problema» e varrà almeno, per segnare all’ingros-
so dei confini, fino a L'ombra delle colline (1964), vero e proprio
libro dei conti. Ancora recentemente Arpino sosteneva che ri-
spetto a scrittori indigeni come Augusto Monti, Pavese, Feno-
glio, il suo fosse un diverso destino: testimoniare la contem-
poraneità più bruciante, «addirittura con qualche anticipazio-
ne». Da quale altro imperativo morale sarebbero mai potuti
venire romanzi come Il fratello italiano e, ancora più flagrante-
mente, Passo d'addio? In questa prospettiva, anche Un delitto
d'onore diventa un romanzo tutt'altro che extra-vagante.
Bra non è stata, come accade per il paese di qualche altro
scrittore, l’umbilicus mundi o un amnio protettivo, ma una sor-
ta di vizio impunito, un luogo che, come nel gioco dei bambi-
ni quando chiudono gli occhi per sognare (immagine già di
Pavese e così tipica in Arpino), nidifica utopie e speranze, ri-
scaldando i progetti più sfrenati: non si resta a morirvi come
mosche nel vino. Qui si è formato il giovane rampollo di una
famiglia di «semplice gente provinciale», come registra la poe-
sia Cronaca piemontese; è cresciuto all'ombra di una madre di
radice contadina e di un padre colonnello di rigidi princìpi e
di «errori condotti con stile». Qui ha sentito gli odori del cuoio
e del tannino, dei concimi chimici e del guano che «costringo-
no la gente a fare in fretta per le strade o, se si è d'estate, a sa-
lire nelle vigne di collina, per darsi respiro e stappare la botti-
glia vecchia». Tutte parole che oggi fanno parte di un libro di
racconti, Regina di cuoi, pubblicato a cura di Cetta Bernardo e
presentato da Lorenzo Mondo, il quale discorre giustamente
dell’«anima indulgente di Arpino», del suo lavoro che nasce
«da un abbandono di amicizia con gli uomini e con le cose».
Ne viene una summa paesana raccontata in modi a tratti
gonfi.di pietà: notti, amici, caffè dove si gioca a carte e a bi-
liardo, madonne pellegrine e pendolari che vanno e vengono
dalla grande città su treni da Far West. Scompartimenti di ter-
za classe in cui è stata fatta la storia degli anni Cinquanta; l’T-
talia minore delle partenze antelucane e degli arrivi notturni,
degli impasti d’aglio e dialetto, di sonno e di vino, di caldo e
di freddo, di vite quotidianamente itineranti per sfuggire a
più amari destini: il campo o la vigna dai frutti stentati o il pa-
drone della piccola fabbrica locale, che è peggio del castigo di
io. Ce n'è un bel resoconto nell'articolo Operai di campagna,
che «Il Mondo» pubblica il 25 settembre 1956, antivigilia di un
romanzo-tappa come Gli anni del giudizio (1958).
La fine dell'adolescenza e i nuovi doveri, la giovane com-
pagna e il matrimonio portano Arpino in città. Ma anche qui
la transizione è in atto e la prima casa è appunto in bilico tra
vecchia frontiera e nuova società, in una borgata che si chia-
ma Leumann e che può entrare tanto in una poesia d'amore
coniugale quanto in un flash, in un’istantanea esemplare che
«Il Mondo» pubblica il 4 luglio 1953 con il titolo Terra corta:
«Questa di Leumann è detta Terra Corta, dal nome della ca-
scina che fino ai tempi della guerra era l’unico caseggiato vivo
nella pianura. Veneti e siciliani e tedeschi e muratori e profu-
ghi e qualche provinciale che volle venire a stare a Torino abi-
tano oggi le case nuove a un piano, colorate di azzurro e di
verde, e da ogni parte d’Italia la gente ha portato le sue abitu-
dini, i suoi vecchi letti di ferro, le sue madonne e gli stracci e i
bambini in stanze chiare come ospedali, che non hanno l’aria
adatta ad accettare una vita antica e familiare. Queste costru-
zioni che sanno di cartone e di mare, come paesaggi e fondali
finti cinematografici, non reggono un chiodo: in alcune di es-
se, d'inverno, la muffa cresce sui risvolti dei lenzuoli dalla se-
ra al mattino, pure l'aspetto è bello e pulito, e fa effetto vede-
re i panni del bucato, fuori di quei balconi e il colore dei mate-
rassi, e le donne sedute sui gradini a chiacchierare e a fare il
cucito».
La larghezza della citazione è motivata. In un'intervista
rilasciata a Claudio Marabini, Arpino dirà una volta, parlando
dei suoi racconti: «La vita è fatta di una piramide di particola-
ri». Lo stesso — e a maggior ragione — si potrebbe dire per que-
sta prosa e per tutte le altre comparse sul «Mondo». Rispetto
ai racconti, la differenza è piuttosto nella pulizia dello stile,
che contrasta con l’immagine vulgata di un Arpino scultore di
figure e di parole. Testimoniava lui stesso: «Per me scrivere
non è dipingere, affrescare, ma scalpellare. Non sono un pit-
tore, ma uno scultore. È fatica sì, ma anche felicità: a volte vi
sono passaggi, in una pagina, che mi costringono a dieci rifa-
cimenti (la sintesi è la mia mania) ma alla fine mi sento libero
come un uccello. C'est mon métier». Ecco riconosciuto il biso-
gno agonistico e drammatico di affrontare la materia.
Ma il giornalista non consente con l’autoritratto dello
scrittore, che a qualcuno, come tale, è potuto apparire «troppo
artificioso e monotono». In parte è la lezione delle cose, la
realtà che ad Arpino piace d'istinto e che gli si impone con
icastica evidenza; in parte è il canone di un'educazione lette-
raria che, se non può dirsi affatto neorealista, prende però
dalla realtà il suo principio; in parte è la vigilanza rigorosa di
Pannunzio, quell’uniformità di tono che nel giornale s’impo-
neva a prima vista e che presiedeva a ogni pagina. Né è ne-
cessario pensare a lezioni dirette, poiché si imparava anche
per corrispondenza: bastando l'esempio di nitidezza e di so-