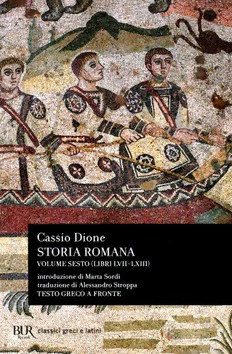Table Of Contentl: età della decadenza repubblicana
e quella dei Giulio-Claudi furono tempi non solo
di cambiamenti, ma di trasformazione.
Mario Attilio Levi
Nei libri LVII-LXIII della Storia romana son_o narrati
gli anni che seguono la morte di Augusto. E il gran
de periodo della dinastia giulio-claudia, rappre
sentata da alcuni degli imperatori più famosi e famigerati
della storia romana e mondiale: Tiberio, Caligola, Claudio
e Nerone, noti più per le loro bizzarrie e crudeltà che per
la loro capacità di governo.
Un tema particolarmente congeniale a Cassio Dione, vis
suto in un periodo di crescente dispotismo e violenza. E
infatti lo storico si sofferma a lungo su questi primi im
peratori, delineandone il carattere, i vizi e le virtù con la
consueta indipendenza di giudizio che lo rende per noi
una fonte preziosa.
Nell'introduzione Marta Sordi confronta le narrazioni di
Cassio Dione e delle sue fonti (soprattutto Tacito e Sveto
nio), evidenziando i pregi e i limiti di Cassio Dione e del
suo metodo storiografico.
CASSIO DIONE (Nicea, 155 ca.-235 d.C.), senatore e alto fun
zionario dell'amministrazione imperiale, scrisse una Storia ro
mana in ottanta libri, che solo in parte sono giunti fino a noi.
MARTA SORDI (1925-2009), una delle maggiori studiose ita
liane del mondo antico, ha insegnato Storia greca e romana
presso l'Università Cattolica di Milano.
ALESSANDRO STROPPA insegna al liceo ed è stato docente di
Lingua greca presso la Facoltà Teologica di Lugano.
Bl
Dello stesso autore in D
~~~~'--
Storia romana
Volume primo
(libri XXXVI-XXXVIII)
Volume secondo
(libri XXXIX-XLIII)
Volume terzo
(libri XLIV-XLVII)
Volume quarto
(libri XLVIII-LI)
Volume quinto
(LII-LVI)
Volume settimo
(libri LXIV-LXVII)
Volume ottavo
(libri LXVIII-LXXIII)
Cassio Dione
STORIA ROMANA
VOLUME SESTO
(LIBRI LVII-LXIII)
Introduzione di Marta Sordi
Traduzione di Alessandro Strappa
Note di Alessandro Galimberti
Testo greco a fronte
Bl
"O classici greci e latini
~You'-.
Proprietà lelteraria riservata
© 1999 RCS Libri S.p.A., Milano
ISBN 978-88-17-17269-1
Titolo originale dell'opera:
P.QMAIKH a:TOPIA
Prima edizione BUR 1999
Settima edizione BUR Classici greci e latini aprile 2016
Seguici su:
Twitter: @BUR_Rizzoli www.bur.eu Facebook: /RizzoliLibri
INTRODUZIONE
Dione scrive, come è noto, la storia di Roma dalle origini al
suo tempo, che è quello di Alessandro Severo, sotto il quale
fu console e, probabilmente, membro del consilium principis:
questa esperienza ebbe certamente un 'influenza notevole, co
me è stato di recente messo in evidenza, nell'importanza che
egli dà ai consiglieri del principe: chiave di interpretazione
per l'atteggiamento di Dione di fronte al potere sembra da ri
conoscere nel famoso discorso di Mecenate del libro 52 e pa
rola centrale per esprimere questo atteggiamento sembra da
individuare nella xapprtala (libertà di parola), i cui opposti
sono KOÀOiceta e 'ftooxda (adulazione).• Queste osservazio
ni, però, sono valide solo per quelle parti dell'opera di Dione
nelle quali egli è testimone oculare dei fatti che narra ed ha
informazioni di prima mano e per quei discorsi programmati
ci (come è appunto quello di Mecenate), che, al di là della
«sostanza delle cose dette», intendono esprimere con pruden
za il pensiero dell'autore e il consiglio al suo principe. Per il
resto, come Tacito, egli scrive di seconda mano, dipendendo
dalle fonti da lui scelte. Più che il pensiero di Dione, che si
esprime solo in qualche giudizio e in qualche commento,
sembra interessante individuare la tendenza della tradizione
da lui scelta e, soprattutto, il criterio di tale scelta. È questo
essenzialmente che io mi prefiggo di fare analizzando i libri
1M. VIELBERO, UnJerlanentoplk, MUnchen 1996, pp. 44-45.
5
di Diane sui Giulio-Claudi: il rapporto dell'autore con le sue
fonti, la sua capacità di comporne il racconto in un quadro
coerente, senza cadere in duplicati e contraddizioni. Dei sette
libri dedicati agli imperatori da Tiberio a Nerone (libri 57-63)
solo alcuni sono giunti per intero: alcune parti, specialmente
per quel che riguarda Claudio e Nerone, sono conservate in
epitomi tarde o in excerpta di natura antologica. La situazio
ne del testo pertanto induce a evitare soluzioni troppo decise.2
l. ll. REGNO DI TIBERIO
I li~ri 57 e 58 di Dione, dedicati a Tiberio, ci sono giunti -
salvo che per brevi tratti frammentari- pressoché interi: essi
sono caratterizzati da un giudizio complessivamente unitario,
che coglie nella dissimulatio la natura particolarissima (cpu
atç i6t(l)ta'tll) dell'imperatore (57, l, 1-2): «i suoi discorsi
erano sempre contrari alle sue intenzioni, negava tutto quello
che desiderava e proponeva ciò che odiava. .. aveva pietà di
quelli che puniva e si adirava con quelli che perdonava ... in
generale dichiarava che l'imperatore non doveva dimostrare
quello che effettivamente pensava». L'esemplificazione di
questo comportamento, che, secondo Diane (57, 3, l), nasce
va, insieme, dalla natura stessa di Tiberio e da una scelta de
liberata, è fornita dal rifiuto da lui opposto all'accettazione
dei titoli imperiali che il senato gli offriva e che egli di fatto
già esercitava e dal comportamento da lui assunto con Asinio
Gallo, annunciato sin dal 14 d.C. (57, 2, 7) e ripreso con gli
stessi particolari in 58, 3, 1-6 sotto il 30, e in 58, 23, 6 (sotto
il 33, l'anno della morte di Asinio).
Il motivo della dissimulatio, che sta alla base della figura di
Tiberio anche in Tacito e in Svetonio, nasce da un'accusa che
1 Sullo stato del testo di Dione, fenno alla edizione del Boisseva.in, v. ora
A.M. GowJNO, Cassiu$ Dio on /M Reign ofN ero, in "ANRW» Il, 34, 3 ( 1997),
pp. 2.5.58, 2.560 e sgg. (con il confronto, per 61, l, fra il riBSSunto di Xifilino
e quelli di Zonara e Giovanni di Antiochia).
6
già circolava fra i contemporanei e da cui Tiberio stesso si di
fende, al tempo della morte di Germanico, nella Tabula Sia
rensis; tale accusa era una defonnazione in chiave ostile tkl
l'autocontrollo al quale l'imperatore particolannente teneva
(come afferma Dione stesso in 57, l, 2 già citato) e della mo
derazione per cui (come afferma con ammirazione Velleio, Il
114, 3), egli, attaccatissimo alla disciplina militare, fingeva di
non vedere le mancanze che non intendeva punire. La dissi
mulatìo compare, appunto come accusa, in un aneddoto rife
rito in annalibus suis da un anonimo vir consularis citato da
Svetonio (Tib. 61, 6). Trattandosi di un ex console, è probabi
le che dobbiamo pensare a Servilio Noniano, console del 35,
più che ad Aufidio Basso.3 E, in effetti. l'aneddoto citato da
Sveronio, fondato sulle intime contraddizioni di Tiberio, che
in un primo momento non recepisce ed anzi condanna l'accu
sa di maiestas lanciata da un nano contro Paconio e qualche
giorno dopo scrive al senato perché egli sia punito per maie
stas, riflette esattamente la caratterizzazione che Dione dà, fin
dall'inizio in base alla sua fonte, dell'imperatore.
Un confronto puntuale fra il racconto che del regno di Ti
berio danno Tacito, Svetonio e Diane, pennette non solo di
confermare quella che è, onnai, l'opinione più diffusa, se
condo cui esiste una fonte comune, da identificare forse con
3 Servi! io Noni ano, cos. 3~. scrisse sotto Claudio, tradendis rebus Romanis
celebrls (Tac. Ann. XIV 19 sotto il 59, anno della sua mone). Quinliliano (X
l, 2) lo dice minus pressus quam histuriae auctoriras postulat. A Servilio
Noniano, come fonte per Tiberio, pensa R. SYME, The Historian Sen-1/iu.r
Nonianus, in «Hennes .. 92, 1964, p. 408; cfr. M. SORDI, lA morte di Agrip
pa Postumo, «Studi Riposati», Milano 1979, p. 493. Aufidio Basso, onnai
vecchio al tempo di Nerone, epicureo (Sen. Ep. 30, 14), fu au10re di libri bel
li Gennanlci (Quinl. X l, 103) e di una Historia, forse distinta da essi, che
P\inio continuò A. fine Aufidi Bassi (Nar. Hisr. praef. 20) in 3\ \ibri (P\in. Ep.
111 5). Essa cominciava probabilmente dopo la mone di Cesare (i frammenti
l e 2 Peter riguardano la mone di Cicerone) ed arrivava almeno al 31 d.C.
(come rivel~o i collegi consolwi ua lui artinli da Cll!lsiodoro [fr. 3 Peter)). È
la fonte (supposta) di Dione·secondo E. No~. Storiograjia imperiale pretaci
tiana, Firenze 1984, p. 82 e ora, Il libro parrico di Appiano, in «RIL• 129,
1995, p. 6 n. 20.
7
Servilio Noniano, fra i tre autori! ma rivela anche, a mio av
viso, che questa fonte comune è spesso l'unica fonte consul
tata da Tacito, da Dionee da Svetonio anche quando essi ci
tano, in forma anonima, altri autori, come iltradidere quidam
di Tac. Ann. VI 23, 4 per la presunta liberazione di Druso fi
glio di Germanico nel 31, che corrisponde esattamente ali' IDc;
nvéç cpacnv («come dicono alcuni») di Dione 58, 13, l per lo
stesso episodio, o a ut aiunt di Suet. Tib. 62, 3 per la falsa pro
fezia con cui Trasillo ingannò Tiberio morente, che ritrovia
mo puntualmente nel <<come dicono» (Q)ç cpacn) di Dione 58,
23, 4. Alla fonte comune i nostri autori attingono anche con
siderazioni che presentano come proprie: come il rifiuto di
credere alla colpa di Tiberio nell'avvelenamento di suo figlio
Druso, che Diane (57, 22, 3) definisce Myoç («Voce») non
1ttatoç («credibile») e Tacito (Ann. VI, 10, l sgg.) rumor non
ancora spento, ma per lui non credibile; o come la speranza
che Diane (58, 22, 4) attribuisce alla gente (avttp(l)ltot), e che
Tacito introduce con un reor (ib. VI 25, l), della salvezza di
Agrippina dopo la morte di Seiano.
Poiché Dione non dipende certamente né da Tacito né da
Svetonio, come rivelano i particolari che egli aggiunge al rac
conto sia dell'uno che dell'altro, bisogna concludere che la
molteplicità dei contatti e delle differenze dipende essenzial
mente dal modo diverso con cui i tre autori riassumono la
stessa fonte.' Con la diversità del riassunto è possibile anche
spiegare una delle divergenze apparentemente più rilevanti
fra Tacito e Dione sulla vicenda del falso Druso, che Diane
colloca dopo la morte del vero Druso, nel34 (58, 25, 1), eTa-
4 D. fl..\CH, Tacltus und dle Tradition der antllcen Geschlchtschreibung, Ollt·
tingen 1973, p. !18; M.A. GruA, Storiografto e regimi pollrlcl In 'lbclto,
«.Athenacum», 63, 198!1, p. IO; D. 1'IMPE, Geschichuchrelbung und Prinzl·
palsopposition, io «Entretiens Fond. Hardt», Oenhe 1986, vol. 33, p. 8!1
sg.; M. SoRDI, Il fa/So Druso e la tradkione storlogrqfica s"ll'ulrlmo JJIH
rlo, in cActa Cla&sica Univ. Se. Debrec.», 27, 1991, p. 63 sgg.
' M. SORDI, Linee per la ricostruzione degli ultimi anni di JJberlo, In «Sty
Jos,., 1992, p. 27 ssg.
8
cito (A nn. V l 0) alla fine del 31. Ho cercato di dimostrare in
un articolo precedente,6 attraverso un esame dei due passi,
che le coincidenze sono più significative delle divergenze e
che queste dipendono dalle incomprensioni da parte di Dione
della fonte base, che era scritta in latino, e dalla brevità del
riassunto. Sorge il dubbio che pertino l'insistenza di Tacito
sull'abbondanza dei processi a pleri.~que scriptoribus omissa
(ib. VI 7, 6 sotto il 32), provenga dalla fonte comune: subito
dopo, infatti, egli ricorda il processo di M. Terenzio, che an
che Dione ricorda (58, 19, 1-3) associando però ad esso il ca
so, non ricordato da Tacito, di Cesiano.
In una situazione di questo genere, in cui anche la citazio
ne di documenti appare presa di peso dalla fonte comune, co
me nel caso della J.10Kpà ÈntatoÀ.~ (la «lunga lettera»), con
cui, secondo D ione 58, l O, l, Tiberio accusò in senato Seiano
nel31 (che corrisponde allapudenda miserantlaque oratione
di Suet. Tib. 65, l e alla verbosa et grandis epistula di luv.
Sat. X 7 l; il confronto con Tacito non è possibile, perché è
andato perduto, pressoché per intero, il racconto dell'anno
31), l'accordo tra le fonti a noi giunte è rivelatore della ten
denza della fonte comune e della sua linea di deformazione,
ma non serve a confermare la storicità della sua ricostruzione
né a dare credito alla interpretazione da essa suggerita. La
tendenza che il confronto tra Dionee le altre fonti rivela è una
fortissima ostilità a Tiberio della fonte base, che fa suoi i ru
mores che circolavano già durante la vita dell'imperatore, an
che quelli che la fonte stessa riteneva incredibili, come la col
pa di Tiberio nell'avvelenamento di Druso; tale fonte dava
un'interpretazione sistematicamente negativa delle intenzio
ni di Tiberio, presentando come frutto di ridicolo sadismo la
lettura pubblica delle accuse a lui rivolte da Fulcinio Trione o
dal nipote Druso (Dio 57, 23, 2; 58, 25, 2; cfr. Tac. Ann. VI
24, l sgg.), con cui Tiberio volle invece «rendere conto» al
6 M. SoRDI, Il falso Druso, cii., p. 63 sgg.
9