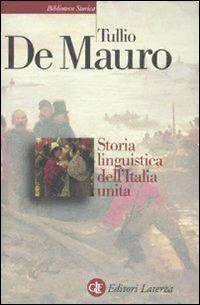Table Of Content© 1963, 1970, G ius. Laterza & ligli
N ella «B iblioteca di C ultura M oderna»
prim a edizione 1963
nuova edizione riveduta, aggiornata e am pliata 1970
N ella «U niversale Laterza»
prim a edizione 1976
N ella «B iblioteca U niversale Laterza»
prim a edizione 1983
In «M anuali Laterza»
prim a edizione 1991
T u l l i o D e M a u r o
S t o r i a l i n g u i s t i c a
d e l l ’ I t a l i a u n i t a
E d it o r i L a t e r z a
Proprietà letteraria riservata
G ius. L aterza & Figli Spa, R om a-B ari
F inito di stam pare nel gennaio 1991
nello stabilim ento d ’arti grafiche G ius. L aterza & F igli, Bari
C L 20-3742-4
ISB N 88-420-3742-7
C onvenevolm ente a tali tre sorte di
natura e governi, si parlarono tre spezie
di lingue...: la prim a, nel tem po delle
fam iglie,... la qual si truova essere stata
una lingua m uta...; la seconda si parlò
per im prese eroiche, o sia per som i
glianze, com parazioni, im m agini, m eta
fore... che fanno il m aggior corpo della
lingua eroica, che si truova essersi par
lata nel tem po che regnaron gli eroi;
la terza fu la lingua um ana per voci
convenute da* popoli, della quale sono
assoluti signori i popoli, propia delle
repubbliche popolari e degli stati m o
narchici, perché i popoli dieno i sensi
alle leggi, a' quali debbano stare con la
plebe anco i nobili...
G . B. V ico Scienza N uova 32
La nostra lingua è com e una vecchia
città: un labirinto di viuzze e di larghi,
di case vecchie e nuove, di palazzi am
pliati in epoche diverse, e, intorno, la
cintura dei nuovi quartieri periferici,
le strade rettilinee, regolari, i caseggiati
tutti uguali... R appresentarsi una lin
gua significa rappresentarsi una form a
di vita...
L. W ittg enstein Rie, fil. 18-19
C hi costruì T ebe dalle sette porte?
N ei libri ci sono solo i nom i di re. I
blocchi di roccia li hanno trascinati i
re ? ... Il giovane A lessandro conquistò
Tlndia. D a solo? Cesare battè i G alli.
M a alm eno ce l’aveva un cuoco con
sé? ... O gni pagina una vittoria. C hi
cucinò il banchetto della vittoria ? O gni
dieci anni un grand'uom o. C hi ha pagato
le spese ? T ante notizie tante dom ande.
B. Brecht D om ande dfun lavora
tore che legge
A vvertenza
L a presente trattazione concerne la storia linguistica del
l’Italia dopo il conseguim ento dell’unità politica (1861) e fin o
agli anni del secondo dopoguerra (1945-1960). Il prim o capi
tolo considera l’italiano in rapporto ai problem i culturali ed
etnico-politici della nazionalità; il secondo descrive nella loro
genesi e nel loro essere le condizioni linguistiche del paese ne
gli anni dell’unificazione (1859-1870); il terzo individua gli
effetti linguistici delle trasform azioni sociali conseguenti alla
raggiunta unità; il quarto dà conto dei m utam enti fo rm a li e
fun zio n a li avutisi negli idiom i dialettali e nella lingua com une
in un secolo di storia unitaria.
L e necessità dell’indagine hanno im posto frequenti scon
fin a m en ti oltre i lim iti del principale oggetto di trattazione:
nel tem po, verso la fa se delle origini rom anze o verso la fa se
delle origini arioeuropee, perché più d ’una volta solam ente in
queste più am pie prospettive trovano adeguata interpretazio
ne fen o m en i linguistici anche recenti; nello spazio, verso altre
tradizioni linguistiche le cui vicende si sono variam ente in
trecciate, anche tra O tto e N ovecento, con quelle della P eni
sola.
Q ualche parola di p iù richiede fo rse il fa tto che, p er in
tendere fen o m en i e tendenze della storia linguistica, si siano
spesso richiam ati eventi e vicende della storia politica, eco
nom ica, intellettuale, letteraria. Il riferim ento a dati non lin
guistici trova una duplice giustificazione nelle posizioni più
avanzate della recente filo so fia e teoria generale del linguag
V ili Avvertenza
gio, coerentem ente organizzate e consolidate segnatam ente nel
le trattazioni teoriche di A n to n in o Pagliaro. L a m oderna fi
losofia del linguaggio, infatti, da un lato ha m esso in piena
evidenza la fu n zio n e prim aria che il linguaggio ha nell*orga
nizzarsi delle conoscenze ed esperienze um ane e la parte che
il convergere dei parlanti verso un unico idiom a ha nel costi
tuirsi delle com unità storiche; m a d'altro canto è per ciò stes
so tratta ad indagare e m ettere in luce quanto il m utam ento
diacronico e il funzionam ento sincronico d'una lingua dipen
dano dall'uso che di essa e delle sue parti fa la com unità che
l'adotta. H a scritto il P agliaro: «F erdinando de Saussure, acu
to teorico del linguaggio, si è richiam ato più di una volta al
giuoco degli scacchi p er esem plificare le sue vedute sul con
gegno della lingua e del suo divenire... Pure, il raffronto fra
il giuoco e il linguaggio, a prim a vista così suggestivo ed evi
dente, ad un più attento esam e si rivela del tutto ingiustifi
cato... M entre il congegno funzionale del giuoco è perfetta
m ente indipendente dai m om enti soggettivi, poiché ip ezzi dopo
ogni m ossa rim angono quello che sono con il loro valore sta
bilito, e tali sono ancora dopo innum erevoli generazioni di
giocatori... nel linguaggio, invece, il m om ento soggettivo del
la parola vive com e traccia o risonanza nel segno com e og
gettività, nella sua im m agine acustica com e è presente nella
coscienza linguistica di una com unità; tale m om ento si com
p one necessariam ente nel segno con la necessità funzionale,
che fa di questo l'elem ento del sistem a. M entre nel giuoco il
sim bolo è fisso e inattivo, quello fo n ico vive della vita dei
parlanti e trova nella coscienza linguistica, che è coscienza
d'una storicità ben definita, la sua legittim azione e la sua ne
cessità» (A . P a g l ia r o , Il segno vivente, N apoli 1952, pp. 56,
61). x
N on sta alla presente trattazione, m a, ove piaccia, agli sto
rici della politica, della letteratura, del pensiero filosofico e ai
sociologi m ettere in chiaro che, se il linguista non può illu
dersi, com e pure un tem po si illuse, di poter concepire la «au
tonom ia» della propria disciplina com e esclusione di ogni cen
no a dati e fa tti non linguistici, così essi, gli storici, non possono
più seriam ente sottrarsi all'onere di prendere visione delle vi
cende linguistiche della società e dei periodi storici di cui pro-
Avvertenza IX
/essano di interessarsi. L a citazione di Vico in capo al volum e
vuol sottolineare anzitutto questa m utualità di rapporti tra
storia non linguistica e storia linguistica, prim a ancora di da
re un'im m agine sim bolica del com plessivo senso della storia
linguistica dell'Italia unita.
L 'esigenza di raggiungere un tipo di esposizione relativa
m ente sintetico e accessibile, eventualm ente, anche al non lin
guista e, d'altra parte, la necessità di docum entare ogni as
serzione (la storia di fa tti recenti è, non solo in linguistica,
pascolo di luoghi com uni, di speciose genericità, di assunzio
ni surrettizie) hanno indotto a tenere distinti due piani di trat
tazione: alla docum entazione provvedono le note e l'appen
dice di docum enti e questioni m arginali, m entre al testo è
affidata l'esposizione dei risultati essenziali della ricerca. N el
fornire la docum entazione, si è specialm ente abbondato in
notizie relative alla storia dem ografica, urbanistica ed econo
m ica della società italiana postunitaria: p u ò fo rse non essere
inutile un tentativo di sistem azione di questa m alcerta m ate
ria com piuto in fu n zio n e di interessi linguistici. In vista d 'u n 'u
tilità siffatta, alm eno in un caso si è abbandonato nel testo il
m odo sintetico d'esposizione. N el secondo capitolo, si è con
cesso am pio spazio all'elencazione analitica di dati relativi al
l'increm ento dem ograf ico delle città italiane per dare del fe
nom eno un quadro am pio anche se, per dir così, orientato
verso i problem i propriam ente linguistici. M a, con la sua ana-
liticità e la sua relativa am piezza, l'elencazione non vuol sol
tanto servire da prem essa alla trattazione im m ediatam ente suc
cessiva o alle ricerche che altri in fu tu ro volessero intrapren
dere; essa vuol anche in tal m odo porre nel debito rilievo il
fenom eno, ossia vuole im plicitam ente asserire l'im portanza
decisiva che l'urbanizzazione ha avuto nelle recenti vicende
linguistiche italiane accelerando il processo di abbandono dei
dialetti e di convergenza dei parlanti verso l'uso costante del
la lingua nazionale. Tale processo è stato la base dell'italia
nizzazione form ale e funzionale in atto nei dialetti ed è la
condizione più cospicua perché l'italiano sopravviva e viva,
cioè si rinnovi p u r senza uscire dal solco della tradizione.
Q uesto lavoro, com inciato a N apoli nel 1960 e term inato