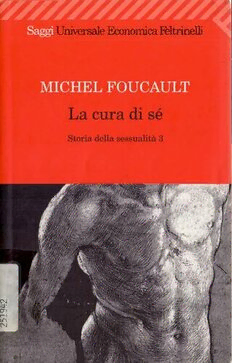Table Of ContentUniversale Economica Fèltrinelli
OJ
■d-
CJ")
f—i
LT\
CN
I. Sognare i piaceri dell’amore
Comincerò con l’analisi di un testo alquanto singolare. Si
tratta di un’opera di “pratica” e di vita quotidiana; non di un
trattato di riflessione o prescrizione morale. È il solo, fra i testi
di quell’epoca che ci restano, a presentare un esposto sufficien
temente sistematico delle diverse forme possibili di atti sessua
li, a proposito dei quali non formula in genere giudizi morali
diretti ed espliciti, ma lascia intravedere schemi di valutazione
comunemente adottati. E questi, come si può facilmente consta
tare, sono molto vicini ai princìpi generali che già all’epoca
classica organizzavano l’esperienza morale degli aphrodisia. Il
libro di Artemidoro costituisce dunque un punto di riferimen
to. Una prova di perennità. La testimonianza di un modo di
pensare corrente. Proprio per questo, consente di valutare quan
to di singolare e di parzialmente nuovo ha potuto avere, nella
stessa epoca, il lavoro della riflessione filosofica o medica sui
piaceri e sul comportamento sessuale.
1. Il metodo di Artemidoro
Il Libro dei sogni di Artemidoro è il solo testo che ci resti,
completamente integro, di una letteratura che n*Aenltlichità fu
copiosa: quella dell’onirocritica. Lo stesso Artemidoro, che scri
ve nel II secolo d.C., cita diverse opere (alcune già antiche) cor
rentemente compulsate ai suoi tempi: quelle di Nicostrato di
Efeso 1 e di Paniasi di Alicarnasso;1 quella di Apollodoro di Tel-
messo;1 * 3 di Febo di Antiochia,4 * di Dionisio di Eliopoli,3 del na
turalista Alessandro di Mindo.6 * Menziona, elogiativo, Aristan-
dro di Telmesso’ e fa inoltre riferimento ai tre libri del tratta
to di Gemino di Tiro, ai cinque volumi di Demetrio Falereo e
ai ventidue di Artemone di Mileto.8 *
Rivolgendosi al destinatario dell’opera, un certo Cassio Mas
simo — forse Massimo di Tiro, o il padre di questi ’ che l’avreb
be esortato a “non lasciar cadere la sua scienza nell’oblio” —,
Artemidoro afferma di non aver fatto “nient'altro ” che dedi
1 Artemidoro, Il libro dei sogni, I, 2 (Ed. it. a cura di Dario Del Como,
Adelphi, 1975).
1 Ibid., I, 2; I, 64; II, 35.
J Ibid., I, 79.
4 Ibid., I, 2; II, 9; I, 48; IV, 66.
’ Ibid., II, 66.
» Ibid., I, 67; II, 9; II, 66.
’ Ibid., I, 31; IV, 23; IV, 24.
• Ibid., I, 2; II, 44.
’ Cfr. A.-J. Festugière, Introduction alla traduzione francese del Libro dei
sogni, p. 9; e C.A. Behr, Aelius Aristide: and thè Sacred Tales, pp. 181 sgg.
11
SOGNARE I PIACERI DELL’AMORE
carsi “sempre, giorno e notte” all’interpretazione dei sogni.10 1 1
Affermazione enfatica e in fondo consueta a quel tipo di presen
tazione? Forse. Artemidoro, a ogni modo, fa cosa diversa dal
compilare gli esempi più famosi dei presagi onirici confermati
dalla realtà. Egli intraprende la stesura di un’opera di metodo,
e questo in due sensi: nel senso di un manuale utilizzabile nel
la pratica quotidiana, ma anche di un trattato di portata teorica
sulla validità dei processi interpretativi.
Non si deve dimenticare che l’analisi dei sogni faceva parte
delle tecniche di vita. Poiché le immagini che apparivano nel
sonno, o quanto meno alcune di esse, erano considerate segni
di realtà o messaggi di cose a venire, decifrarle era molto im
portante, e una vita ispirata a saggezza non poteva dispensarse
ne del tutto. Si trattava di un’antichissima tradizione popolare,
ma anche di un’abitudine adottata dagli ambienti colti. Se era
d’uopo rivolgersi agli innumerevoli professionisti di visioni not
turne, era altresì opportuno saperne interpretare i segni da soli.
Abbiamo numerosissime testimonianze dell’importanza che ve
niva accordata all’analisi dei sogni come pratica di vita, indispen
sabile non solo nelle circostanze più rilevanti, ma anche nel cor
so quotidiano delle cose. Il fatto è che gli dei, in sogno, danno
consigli, suggerimenti e, a volte, ordini precisi. A ogni modo,
anche quando il sogno si limita ad annunciare un evento senza
prescrivere alcunché, anche quando si prevede che le cose an
dranno inevitabilmente in un certo modo, è opportuno conosce
re in anticipo ciò che incombe per esservi convenientemente
preparati: “Spesso, la divinità,” dice Achille Tazio negli Amori
di Leucippe e Clitofonte, “si compiace di rivelare in sogno il fu
turo agli uomini — non già perché essi evitino il male (nessu
no, infatti, può essere più forte del Destino) — ma perché sop
portino più agevolmente le loro sofferenze. Infatti, ciò che so
pravviene all’improvviso, senza che l’animo vi sia preparato,
turba lo spirito, annichilito dal colpo e lo abbatte profondamen
te; mentre ciò cui si è preparati può, con la graduale assuefa
zione, lenire la sofferenza.” 11 Più tardi, Sinesio si farà interpre
te di un punto di vista del tutto tradizionale, quando ricorderà
che i nostri sogni sono un oracolo che “abita con noi”, che ci
accompagna “nei viaggi, in guerra, nei pubblici uffici, nei lavori
10 Artemidoro, Il libro dei sogni, II, conclusione.
11 Achille Tazio, Gli amori di Leucippe e Clitofonte, I, 3.
12 LA CURA DI SÉ
agricoli, nelle imprese commerciali”; il sogno va considerato co
me “un profeta sempre pronto, un infaticabile e muto consiglie
re”, e tutti dobbiamo dunque applicarci all’interpretazione dei
nostri sogni, indipendentemente dallo status che ci è dato,
“uomini e donne, giovani e vecchi, ricchi e poveri, privati cit
tadini e magistrati, abitanti della città e della campagna, artigia
ni e oratori”, senza privilegio “né di sesso né di età, né di cen
so né di professione”.12 È in questo spirito che Artemidoro scri
ve Il Varo dei sogni.
L’essenziale, per lui, è indicare dettagliatamente al lettore
un sistema da seguire, un modo di procedere: come operare,
cioè, per scomporre un sogno in diversi elementi e stabilire il
senso diagnostico del sogno stesso, e come interpretare il tut
to a partire da quegli elementi e tener conto di quel tutto nella
decifrazione di ciascuna delle sue parti. Significativo, in propo
sito, il rapporto che Artemidoro stabilisce con la tecnica divi
natoria dei sacerdoti sacrificanti: anch’essi “sanno a quale sin
gola cosa si adatti ciascun segno”; e tuttavia “traggono le pre
dizioni guardandosi dal ricorrere a uno solo di essi piuttosto
che al loro insieme”.13 Si tratta dunque di un trattato per inter
pretare. Quasi interamente incentrata, non già sul meraviglioso
profetico dei sogni, ma sulla technè che consente di farli parla
re in modo chiaro, l’opera si rivolge a diverse categorie di let
tori. Artemidoro intende proporre uno strumento ai tecnici del
l’analisi e agli specialisti; questo è appunto il miraggio che fa ba
lenare agli occhi del figlio, destinatario del IV e V libro: “se
ciò che vi è scritto rimarrà in tuo possesso”, gli dice, “ti rende
rà un interprete di sogni superiore a tutti”.14 1 M5a, in pari tempo,
Artemidoro si propone di aiutare anche coloro che, delusi da
metodi erronei precedentemente osservati, sarebbero tentati di
allontanarsi da questa pratica pur tanto preziosa: contro quegli
errori, il libro sarà “una cura salvatrice” — therapeia sótèriòdès
E pensa anche, Artemidoro, al lettore qualunque, alla “massa
dei profani” che necessitano di nozioni rudimentali.16 Egli, ad
ogni modo, ha inteso presentare l’opera come un manuale pra
tico, uno strumento da utilizzarsi nel corso dell’esistenza e nel
12 Sinesio, I sogni.
13 Artemidoro, Il libro dei sogni, I, 12 e III, conclusione.
14 Ibid., IV, proemio.
15 Ibid., dedica.
16 Ibid., Ili, conclusione.
SOGNARE I PIACERI DELL’AMORE 13
lo svolgersi delle circostanze: alle sue analisi, Artemidoro ha
voluto imporre “un ordine e una successione che corrispondono
alla vita umana”.
Questo carattere di “manuale per la vita quotidiana” si evi
denzia con particolare risalto allorché si confronti il testo di Ar
temidoro con i Discorsi sacri di Aristide — ipocondriaco ansio
so che instaurò per lunghi anni un intenso rapporto con il dio
della medicina attraverso i sogni che questi gli mandava nel cor
so delle straordinarie peripezie della sua malattia e delle innu
merevoli cure cui via via si sottoponeva.
Si può osservare che, in Artemidoro, non si dà quasi spa
zio al meraviglioso religioso; a differenza di molti altri testi del
genere, l’opera di Artemidoro non si rifà a pratiche di terapia
cultuale, anche se evoca, in base a una formula tradizionale,
l’Apollo di Daldi, “il dio della sua patria” che l’ha esortato al
l’opera e che, apparendogli in sogno, gli ha “dato l’ordine di
comporre questo scritto”.17 Del resto, egli si preoccupa di sot
tolineare la differenza fra il proprio lavoro e quello di onirocri-
tici quali Gemino di Tiro, Demetrio Falerno e Artemone di Mi-
leto che hanno trascritto prescrizioni e terapie suggerite da Se-
rapide.1’ Il sognatore-tipo cui si rivolge Artemidoro non è un
devoto angosciato che si affanna a interpretare ingiunzioni pro
venienti dall’alto; è un individuo “comune”: un uomo, per lo
più (i sogni delle donne sono infatti indicati a parte, come pos
sibili varianti in cui il sesso del soggetto viene a modificare il
senso del sogno); un uomo che ha famiglia, che dispone di beni
ed esercita molto spesso un mestiere (svolge un’attività com
merciale, gestisce una bottega); può avere dei servi e degli schia
vi (ma si prende in considerazione anche il caso in cui non ne
abbia). E le sue preoccupazioni principali concernono, oltre alla
propria salute, la vita e la morte delle persone che lo circonda
no, il successo delle sue iniziative, il suo arricchimento o impo
verimento, il matrimonio dei figli, le eventuali cariche pubbli
che da esercitare nella città. Una utenza media, insomma. Il to
sto di Artemidoro è rivelatore di un tipo di esistenza e di un
genere di preoccupazioni che sono peculiari della gente comune.
Ma l’opera mette anche in gioco una posta teorica che Ar
temidoro evoca nella dedica a Cassio: egli vuole confutare gli
17 Ibid., II, conclusione.
'< Ibid., II, 44.
14 LA CURA DI SÉ
avversari dell’oniromantica e convincere gli scettici che non cre
dono molto a tutte quelle forme di divinazione in base alle qua
li si vorrebbero decifrare i segni premonitori del futuro. Le sue
certezze, Artemidoro cerca di stabilirle non tanto attraverso
l’esposizione pura e semplice dei risultati, quanto attraverso un
meditato processo di ricerca e un dibattito metodologico.
Egli non pretende di fare a meno degli autori antichi; si è
anzi preoccupato di leggerne i testi; ma non per ricopiarli, come
comunemente vien fatto: ciò che lo interessa, nel déjà dii, è,
più che l’autorità istituzionalizzata, l’esperienza nella sua am
piezza e varietà. E questa esperienza, egli si è fatto un dovere
di cercarla non già presso qualche grande autore, ma là dove es
sa si forma. Artemidoro va molto fiero — lo dice nella dedica a
Cassio Massimo e lo ripete in seguito — dell’ampio ventaglio
della sua ricerca. Non solo ha compiuto confronti e riscontri fra
un gran numero di testi, ma ha pazientemente frequentato le
baracche che profeti mestieranti e interpreti di sogni rizzavano
nei crocicchi più affollati delle città mediterranee. “Per quanto mi
riguarda, non c’è libro di onirocritica che io non mi sia procu
rato, poiché a questo tengo moltissimo; e d’altro lato, benché
gli indovini che operano nelle piazze e nei mercati siano tenuti
in gran disprezzo, e le persone serie arriccino il naso davanti a
loro e li chiamino ciarlatani e imbroglioni e parassiti, senza te
nere in alcun conto questa accusa io ho trascorso molti anni in
sieme a costoro, per le città e le festività pubbliche della Grecia,
dell’Asia, dell’Italia e delle isole più grandi e popolose, prestan
domi ad ascoltare antichi sogni e i loro esiti: poiché non era pos
sibile esercitarsi altrimenti in questa materia.” ” Tuttavia, Arte
midoro non intende trasmettere questo materiale in modo acri
tico; vuole invece sottoporlo all’“esperienza” (peira) che è, per
lui, “testimone” e “regola” di ogni discorso.20 Dal che si deve
dedurre che egli controllerà le informazioni riportate vaglian
dole alla luce di altre fonti, confrontandole con la propria pra
tica personale e con un lavoro di critica e di argomentazione: co
sì, niente di quanto detto sarà “campato in aria” né frutto di
“semplice congettura”. E qui si riconoscono metodi di ricerca,
nozioni — come quelle di bistorta e di peira —, forme di con
trollo e di “verifica” che caratterizzavano all’epoca, sotto l’in-
** lbid., dedica.
20 lbid., II, conclusione.
SOGNARE I PIACERI DELL’AMORE 15
fluenza più o meno diretta del pensiero scettico, i vari compen
di del sapere nell’ambito della storia naturale o della medicina.21
Il testo di Artemidoro offre il notevole vantaggio di presenta
re una riflessione elaborata in base a un’ampia documentazione
tradizionale.
Non è il caso di cercare, in un documento di questo tipo, le
formulazioni di una morale austera o il profilarsi di esigenze
nuove in materia di comportamento sessuale; esso offre, sem
mai, delle indicazioni su atteggiamenti generalmente accettati
e modi correnti di giudicare le cose. La riflessione filosofica non
è affatto assente da questo testo: vi si trovano riferimenti piut
tosto espliciti a problematiche e dibattiti molto in voga all’epo
ca, ma tali accenni concernono i modi di decodificazione e il me
todo di analisi, non i giudizi di valore e i contenuti morali. Il
materiale su cui vertono le interpretazioni, lo scenario onirico
che delineano a mo’ di presagio, le situazioni e gli eventi che
preconizzano, fanno parte di un paesaggio comune e tradiziona
le. Si può dunque legittimamente vedere in questo testo di Ar
temidoro la testimonianza di una tradizione morale abbastanza
diffusa e certo profondamente radicata. Ma occorre al tempo
stesso tener presente che, anche se il libro abbonda in dettagli,
se presenta, a proposito dei sogni, un quadro di atti diversi e di
possibili rapporti sessuali più sistematico di qualunque altra
opera della stessa epoca, esso non è in alcun modo un trattato
di morale che si prefigga come scopo principale di formulare giu
dizi su quegli atti e quei rapporti. Solo indirettamente si posso
no rilevare, attraverso la decodificazione dei sogni, i giudizi mo
rali che vengono dati ad atti e scene che appaiono nei sogni stes
si. I princìpi di una morale non sono proposti per se stessi; si
può solo riconoscerli attraverso i processi dell’analisi: inter
pretando le interpretazioni. Il che presuppone che ci si fer
mi un attimo sui processi di decodificazione che Artemidoro
mette in opera, così da poter decifrare in seguito la morale che
si adombra dietro le analisi dei sogni sessuali.
21 R.J. White, nella sua introduzione all’edizione inglese di Artemidoro,
evidenzia numerose testimonianze dell’influenza empiristica e scettica su Arte
midoro A.H.M. Kessels, invece, sostiene che Artemidoro era semplicemente
un esperto che si limitava a interpretare il sogno che gli veniva quotidiana
mente sottoposto (Ancient System; of Dream Classification, “Mnemosune",
1969, p. 391).
16 LA CURA DI SÉ
1. Artemidoro distingue due forme di visioni notturne. Vi
sono le visioni oniriche — enupnia — che esprimono gli stati
affettivi elementari del momento, quelli che “accompagnano
l’anima nella sua corsa”: si è innamorati, si desidera la presen
za dell’oggetto amato e si sogna che egli è presente; si è affa
mati, si prova lo stimolo della fame e si sogna di mangiare; o an
cora “è inevitabile... che chi è pieno di cibo creda in sogno di
vomitare oppure si senta soffocare ” 22 e chi ha paura dei suoi ne
mici “veda ciò che paventa”. Questa forma di sogno ha un va
lore diagnostico molto semplice; esso s’iscrive nell’attualità (dal
presente al presente), manifesta al dormiente lo stato in cui si tro
va in quel preciso momento, traduce ciò che è, a livello del corpo,
carenza o eccesso e, a livello dell’anima, timore o speranza.
Diversi sono i sogni — oneiroi — la cui natura e funzione
Artemidoro individua facilmente nelle tre “etimologie” che egli
stesso avanza. L’oneiros, è ciò che to on eirei, “ciò che dice l’es
sere”; e dice ciò che è già iscritto nello svolgersi del tempo, e
si produrrà come evento in un avvenire più o meno ravvicina
to. Ed è anche ciò che agisce sull’anima e la sollecita — oreinei;
il sogno modifica l’anima, la foggia, la plasma; le dà una deter
minata disposizione e provoca in essa moti che corrispondono a
quanto le viene mostrato. Si riconosce inoltre nella parola onei-
ros il nome del mendicante di Itaca, Irò, che “andava ad an
nunciare messaggi quando lo mandavano”.21 Etttipnion e oneiros
si contrappongono dunque etimologicamente; il primo parla del
l’individuo, il secondo degli eventi esterni; uno deriva da deter
minati stati fisici o psichici, l’altro è preavviso di ciò che acca
drà; uno traduce il gioco del troppo e del troppo poco a livello
dei desideri e delle ripulse, l’altro fa segno all’anima e al tempo
stesso la condiziona. Da un lato, le visioni oniriche del deside
rio traducono la realtà dell’anima in quel preciso momento;
dall’altro, i sogni dell’essere esprimono l’evento a venire nel
l’ordine del mondo.
Una ulteriore scissione introduce, in ciascuna delle due ca
tegorie di “visione notturna”, un’altra forma di distinzione; vi
è ciò che si mostra chiaramente, in modo trasparente e senza ri
chiedere decifrazione e interpretazione, e ciò che si palesa in mo
do simbolico e attraverso immagini che significano una cosa di
22 Artemidoro, II libro dei sogni, I, 1.
22 Ibid., I, 1. Cfr.. Odissea, XVIII, 7.