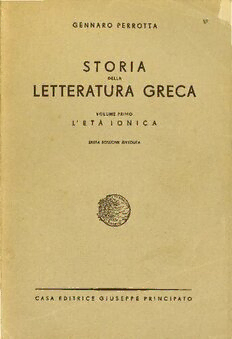Table Of ContentGENNARO PERROTTA
STORIA
DELLA
LETTERATURA GRECA
VOLUME PRIMO
L' E T A I O N I C A
SESTA EDIZIONE RIVEDUTA
CASA EDITRICE GIUSEPPE PRINCIPATO
STORIA DELLA LETTERATURA GRECA
VOLUME PRIMO
L' E T À I O N I C A
GENNARO PERROTTA
Ordir.a-rio nell'Università di Roma
STORIA
DELLA
LETTERATURA GRECA
VOLUME PRIMO /
L' E T A I O N I C A
SESTA EDIZIONE RIVEDUTA
CASA EDITRICE GIUSEPPE PRINCIPATO
MILANO , MESSINA
PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
Printed in ltaly
Officine Grafiche Principato - Milano - 1947
INTRODUZIONE
PERIODI DELLA LETTERATURA GRECA
La letteratura gr·eca comincia con i poemi d'Omero; è con-
venzione generale farla terminare con l'anno 529 d. C., quando
l'imperatore Giustiniano ordinò la chiusura della scuola filosofica
di Atene. In realtà al tempo di Giustiniano acquista caratt.eri
propri la letteratura bizantina, ma tra l'una e l'altra non si
può segnare un limite preciso; meno ancora si può indicare que-
sto limite con un anno.
La letteratura greca comprende poeti e scrittori (di tredici
secoli: otto prima di Cristo, cinque d. C.), che sono greci di
lingua e di cultura, non tutti di nascita: poichè la conquista
di Alessandro Magno diffuse la lingua e la cultura greca· fuori
della Grecia, e i centri maggiori della civiltà greça divennero
Alessandria, Antiochia, Pergamo: città non di Grecia, ma greche
per lingua e per civiltà.
La conquista di Alessandro divide la letteratura greca in
due periodi:
Period~ greco classico (da Omero a tutto il IV secolo a. C.).
Periodo ellenistico (dal III secolo a. C. all' el:à di Giustinia-
no, VI secolo d. C.). -
Il primo periodo, che comunemente si chiama greco classi-
co (perchè comprende i maggiori poeti e scrittori, che gramma-
tici e retori antichi consideravano « classici », cioè « della pri-
ma classe », gli unici da servire come modelli di stile), meglio si
chiamerebbe <<ellenico», cioè cc greco, veramente greco», in op-
posizione al periodo cc ellenistico ».
Poichè il primo periodo comprende la letteratura del mondo
greco; il secondo periodo comprende la letteratura delll1ondo el-
lenizzato. - - · --
Questa è. l'unica divisione in periodi veramente essenziale, e
non arbitraria. -
PERROTTA - I I
- 2 -
Nel primo periodo prevale la poesia; nel ~econdo'. acquista
maggiore importanza la prosa. Inoltre, la poesia classica ha un
suo carattere profondamente diverso dalla poesia ellenistica.
Tutta la poesia. classica è poesia d'occasione. La poesia di
Omero e di Archiloco era destinata a essere assai più recitata che
letta, quella di Saffo, di Alceo, di Pindaro a essere assai più can-
tata che letta. Perfino la poesia che noi moderni chiamiamo « li-
rica n, era per i poeti greci più antichi destinata à un'esecuzione:
associata al suono della lira, alla musica.
Questa condizione contribuì indubbiamente alla grandezza
della poesia greca antica. Nata dalla vita, questa poesia non cor-
reva il pericolo di avere un contenuto frivolo o vuoto, di dive-
nire letteratura nel senso peggiore.
La poesia greca più antica era « poesia d'occasione >> anche
nel senso che intese Wolfango Goethe, quando scrisse che è « poe-
sia d'occasione 1> ogni grande poesia. Poichè nè Eschilo nè Ari-
stofane si preoccupavano soltanto degli spettatori ateniesi che assi-
stevano ai loro drammi; nè Pindaro riserbava le sue odi ai suoi
atleti vittoriosi o a quelli che celebra vano la vittoria degli agoni
col canto; nè Saffo scriveva le sue poesie soltanto perchè le can-
tassero le compagne. Tutti scrivevano per i loro contemporanei,
ma anche per i posteri : componevano (( poesie d'occasione n, ma
per l'immortalità. ·
Nell'età ellenistica la poesia non è più congiunta così inti-
mamente alla vita. Il poeta è in condizioni assai più simili a
quelle d'un poeta moderno: i suoi carmi sono destinati a esser
letti, non a esser cantati o recitati. In ogni poesia diventa quasi
inevitabile la ricerca della novità e della raffinatezza elegante.
Si suol dividere il primo periodo nei due periodi seguenti:
Periodo ionico : dalle origini alla fine del V secolo (c omu-
nemente si fa finire col 480, data della battaglia di Salamina).
Periodo attico : che comprende il V e il IV secolo (c omu-
nemente si fa finire col 323, data della morte di Alessandro
Magno).
Ma è improprio parlare di un (( periodo ionico » : se la stirpe
ionica ha contribuito più delle altre al fìorire del genio letterario
greco, non è giusto dimenticare il contributo delle altre.
Più giusto sarebbe chiamare (( ellenico » questo periodo; ma
ellenico è veramente l'intero periodo dalle origini al 323. È molto
meglio chiamare (( preclassico », o (( arcaico », il periodo dalle
origini al 480.
Con una certa ragione si può parlare di un periodo attico,
poichè i secoli V e IV segnano davvero il trionfo del genio at-
tico, che nel V secolo coincide con l'egemonia politica di Atene,
nel IV secolo sopravvive ad essa.
-3-
Ma ragioni varie consiglierebbeto di rinunziare a questa di-
visione. Per esempio, Pindaro, morto dopo il 446, cadrebbe nel-
1' età attica per i limiti cronologici della sua vita; ma per l'indole
della sua arte è un poeta arcaico, preclassico, preattico.
A minori difficoltà dà luogo la divisione del periodo elleni-
stico nei due periodi seguenti:
I
Periodo alessandrino, che comprende il III e il II secolo
~
a. C. : così detto perchè Alessandria, la città nuova fondata da
Alessandro, è in questi due secoli il maggior centro della cultura
1 greca. Questo periodo si fa terminare generalmente con l'anno
I
30 a. C. (quando l'Egitto diventa provincia romana).
I
. Periodo romano: dal 30 a. C. al 529 d. C. Giustamente
prende nome da Roma, poichè Roma esercitò sulla letteratura
un influsso superiore a quello esercitato da qualunque città el-
lenistica. È il periodo che conosciamo meglio, perchè le opere
degli scrittori ci sono giunte in gran parte intatte.
Dal II sec. a. C. in poi, la poesia è in estrema decadenza:
domina la prosa.
Queste divisioni hanno naturalmente un'importanza molto
relativa. Utile è soprattutto non dimenticare la distinzione tra
periodo greco classico e periodo ellenistico:
CAPITOLO I.
O M E R O
I. - La persona del poeta.
La letteratura greca comincia con due grandi poemi, l'Iliade
e l'Odissea. Gli antichi li attribuivano a un poeta di nome Omero.
Ma di Omero non sapevano nulla. Le Vite che abbiamo di
lui (una delle quali falsamente attribuita allo storico Erodoto)
non hanno valore, perchè sono veri romanzi, scritti da chi si pro-
poneva di scrivere il romanzo del poeta, non la sua biografia.
Del resto, la biografia sarebbe stato impossibile scriverla: non
si sapeva nulla o quasi nulla. Gli antichi pretendevano di sa-
pere di Omero un'infinità di particolari, mentre ignoravano le
notizie fondamentali, quelle sull'età e la patria. Romanzesco è
anche il Certame di Omero e di Esiodo, il racconto di una gara
poetica in cui Esiodo, il poeta della pace, vince Omero, il poeta
della guerra.
Il nome Omero ("0µ.11poç} è un buon nome greco che significa
« ostaggio )). Molte città greche si contesero il vanto d'aver dato
i natali al poeta: Smirne, Chio, Colofone, Cuma, Pilo, Itaca,
Argo, Atene. Le pretese più insistenti erano quelle di Chio e di
Smirne. Ma anche Chio può essere eliminata facilmente. Non im-
porta molto che a Chio vivessero « gli Omeridi )) , una famiglia di
poeti che si vantavano di discendere da Omero. Noi sappiamo
com'è nata la leggenda della nascita a Chio. Il poeta di uno de-
gl'inni <<omerici n, dell'inno ad Apollo Delio, chiama sè stesso
<<i l cieco che abita nella rocciosa Chio )). Quasi tutti gli ·antichi
attribuirono a Omero: i così detti inni << omerici n: di qui derivano
le due leggende della nascita a Chio e della cecità. Ma nessun
critico moderno attribuisce a Omero gl'inni << omerici n: cieco e
nato a Chio è~ dunque,- il poeta dell'inno ad Apollo Delio, non
Omero.
Resta la tradizione della nascita a Smirne. La città dell'Asia
Minore, colonia eolica più tardi divenuta ionica per una nuova co-
lonizzazione, spiegherebbe bene, si è p~nsato, il dialetto dell'Iliade