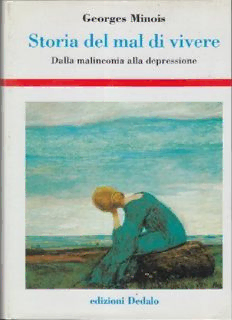Table Of ContentIl «mal di vivere» risale al XVIII secolo, ma il malessere che designa esiste
da quando l’uomo cerca di dare un senso alla sua esistenza. Già nell’Antichità i
medici descrivevano pazienti colpiti da sindromi depressive e proponevano
rimedi a base di piante per guarirli. I filosofi si interrogavano sull’ambivalenza
di queste «affezioni dell’anima», caratterizzate da stanchezza, accidia,
malinconia, noia, inquietudine, spleen, nichilismo, nausea, angoscia,
depressione. Il mal di vivere ha preso forme diverse nel corso dei secoli,
tutte sempre legate al malessere della condizione umana. Da Lucrezio a
Schopenhauer, numerose menti illuminate hanno analizzato la malinconia
e molti vi hanno visto il temperamento per eccellenza dei «grandi uomini». Da
Eschilo a Cioran passando per Shakespeare, il mal di vivere ha ispirato i più
grandi autori della cultura occidentale. Dall’impossibile rivolta di Prometeo
contro il destino, all’angoscia dell’uomo contemporaneo che affronta le trappole
della libertà, questo libro svela come il mal di vivere sia il pegno da pagare per i
progressi della civiltà.
Georges Minois, professore di storia, ha scritto numerose sintesi sulla storia
della cultura occidentale. In particolare ricordiamo: Storia dell'ateismo (Editori
Riuniti, 2000), La Chiesa e la guerra (Dedalo 2003), Storia del riso e della
derisione (Dedalo 2004).
In copertina:
Heinrich Vogeler, Sensucht, 1908,
Privatbesitz.
La nostra società rifiuta i pessimisti, i depressi, gli angosciati.
Il mal di vivere è quindi una malattia dei tempi moderni che bisogna
curare a colpi di antidepressivi?
Oppure, come ci insegnano i grandi malinconici della storia, è la sola
ragione di vita, in quanto segno del progresso del pensiero e della
coscienza? La grandezza dell’uomo, in fondo, sta anche nelle sue ferite.
Scansione, Ocr e conversione a cura di Natjus
Ladri di Biblioteche
Storia e civiltà
61
Georges Minois
Storia del mal di vivere
Dalla malinconia alla depressione
© 2003, Edition de la Martinière
Titolo originale: Histoire du mal de vivre. De la mélancolie à la dépression
Traduzione di Manuela Carbone
Volume pubblicato con il contributo del Ministero degli Affari Esteri
francese e il Ministero della Cultura francese - Centre National du Livre.
© 2005 Edizioni Dedalo srl, Bari
www.edizionidedalo.it
Tutti i diritti sono riservati.
Riproduzione vietata ai sensi di legge (art. 171 della legge 22 aprile 1941, n.
633)
Capitolo primo
In principio era la fatica di vivere
Un Egizio, all’alba della civiltà di quattromila anni fa, disgustato dallo
spettacolo del mondo, scrive le sue riflessioni sotto forma di dialogo della sua
anima. Le sue parole superano i confini del tempo:
La mia anima si affanna inutilmente a cercare di persuadere un infelice
a restare in vita e a impedirmi di raggiungere la morte prima del
dovuto. Mostrami piuttosto quanto è bello il tramonto! E forse così
terribile? La vita ha una durata limitata: persino gli alberi finiscono per
cadere. Potrebbero sparire i mali, ma non la mia infelicità. Colui che miete
uomini mi porterà via comunque, senza riguardo, magari insieme a un
criminale qualunque, dicendo: «Ti porto via, poiché il tuo destino è di
morire, anche se il tuo nome continuerà a vivere...»’ (papiro Berlino 3024).
Questo testo, conosciuto con il titolo Ode del disperato, lunga litania di uno
scriba anonimo che aspira alla propria mòrte, è la più antica espressione
individuale del mal di vivere che ci sia stata trasmessa:
La morte è oggi davanti a me come la salute per l’infermo Come uscire
fuori da una malattia.
La morte è oggi davanti a me
Come l’odore della mirra
Come sedersi sotto la vela in un giorno di vento.
La morte è oggi dinanzi a me
Come il profumo del loto
Come sedersi sull’orlo dell’ebbrezza.
La morte è oggi dinanzi a me
Come la fine della pioggia
Come un uomo che ritorna a casa dopo una campagna oltremare.
La morte è oggi dinanzi a me
Come quando il cielo si rasserena
Come il desiderio che è in un uomo di rivedere la propria casa dopo
innumerevoli anni di prigionia2.
Questo Amleto del Medio Regno non è un caso unico di quell’epoca. Papiri e
geroglifici testimoniano che i disperati si suicidavano nella valle del Nilo: alcuni
si gettavano in pasto ai coccodrilli, altri si lasciavano annegare, altri ancora si
sferravano un colpo d’ascia o di spada3.
Soffrire, invecchiare, morire, per cosa poi? Le prime manifestazioni del mal
di vivere derivano dall’esperienza delle difficoltà dell’esistenza e ne
conserviamo numerose testimonianze nell’antico Vicino Oriente. Ad Akkad,
l’antica Mesopotamia, alcune tavolette rinvenute fanno eco al tedio dello scriba
egizio, come il Dialogo pessimista fra il padrone e il suo servitori, colmo di
osservazioni disincantate e il Dialogo sulla miseria umana, che stigmatizza
l'ingiustizia universale: «La folla loda la parola di un uomo preminente, esperto
in crimini, ma avvilisce l’essere umile che non ha commesso violenza alcuna. Il
malfattore è giustificato, mentre il giusto viene cacciato. Il bandito riceve l’oro,
il debole rimane affamato. La potenza del cattivo viene fortificata ancora di più,
mentre l’invalido, il debole, viene schiacciato»5.
Amara constatazione che porta a una visione dell’esistenza ben diversa dalle
confortanti rassicurazioni fornite dalla saggezza tradizionale. Questa giustizia
immanente è una menzogna, ripetono i testi di saggezza babilonese: sono i più
furbi a prosperare, non i più virtuosi. L’uomo che riflette non può che essere
pessimista. Persino l’eroe Gilgamesh fallisce nella sua ricerca della «pianta della
vita», che gli avrebbe permesso di sfuggire al dolore, alla vecchiaia e alla morte.
Il male è ovunque e già se ne cercano le cause. I miti babilonesi attribuiscono
le sofferenze dell’umanità a divinità misteriose. La vita d’oltretomba, negli
inferi, non sarà migliore6. Davanti a simili prospettive, come stupirsi del fatto
che i Babilonesi abbiano sofferto di disturbi che ricordano la nostra depressione
ansiosa? Un sacerdote descrive così la condizione di un penitente: «Malattia,
languore, indebolimento, sofferenza si sono impadroniti di lui. Lamenti e
sospiri, oppressione, angoscia, paura, tremore si sono impossessati - straziandoli
- dei suoi desideri»7.
Presso i Persiani la stessa amarezza trapela dalla lettura di Erodoto, che
riporta queste parole di Artaban in un dialogo con Serse, il quale, mostrandogli
le sue armate, afferma: «Fra un secolo nessuno di quegli uomini sarà vivo».