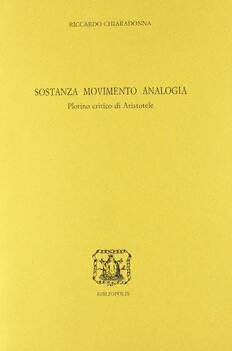Table Of ContentRICCARDO CHIARADONNA
SOSTANZAM OVIMENTOA NALOGIA
Plotino critico di Aristotele
BIBLIOPOLIS
ELENCHOS RICCARDO CHIARADONNA
Collana di testi e studi sul pensiero antico
fondata da
GABRIELE GIANNANTONI
SOSTANZAM OVIMENTOA NALOGIA
XXXVII
Plotino critico di Aristotele
ISTITUTO PER IL LESSICO INTELLETTUALE EUROPEO E STORIA DELLE loEE
SEZIONE PENSIERO ANTICO
Responsabile Vincenza Celluprica BIBLIOPOLIS
Secondo le norme dell'Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e
Storia delle Idee questo volume è stato sottoposto all'approvazione di
E. Berti e L. Brisson.
Ai miei genitori
Copyright © 2002 by
C.N.R., Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee
ISBN 88-7088-410-4
------- ------~
INDICE
RINGRAZIAMENTI p. 11
ABBREVIAZIONI » 13
INTRODUZIONE
PLOTINO E LE CATEGORIE DI ARISTOTELE » 15
Bilancio degli studi, p. 15. Plotino e l'esegesi antica
delle Categorie,p . 40.
CAPITOLO PRIMO
SOSTANZA » 55
L'unità della sostanza sensibile e la priorità della
forma (VI 1 [42], 2), p. 55. Generi e categorie, p.
80. Le critiche alla sostanza: Plotino e i commenta-
tori neoplatonici, p. 89. La forma immanente alla
materia e il 'A.6yoçp, . 117.
CAPITOLO SECONDO
MOVIMENTO » 147
La critica alla dottrina aristotelica del movimento e
dell'atto, p. 14 7. Il movimento e la sua manifesta
zione quantitativa, p. 167. Il movimento come
"forma sveglia" e "vita dei corpi", p. 188.
CAPITOLO TERZO
ANALOGIA » 227
La relazione Ùq>'é v6ç (VI 1 [42], 3), p. 227. Analogia e
sostanza intellegibile: Plotino, Porfirio e i commenta
tori, p. 249. La teoria plotiniana della gerarchia, p. 271.
10 INDICE
CONCLUSIONI » 307
INDICI
Indice dei luoghi » 313
Indice dei nomi antichi » 323
Indice dei nomi moderni » 325 RINGRAZIAMENTI
Questo studio è la versione rielaborata di una tesi di dot
torato in filosofia (XI Ciclo) discussa presso l'università di
Roma "La Sapienza" il 4 giugno 2001. Nel pubblicarla, desi
dero anzitutto ricordare il professor Gabriele Giannantoni,
che ha incor~ggiato e seguito i miei studi fino alla sua scom
parsa. Ringrazio vivamente le professoresse Anna Maria Iop
polo e Margherita Isnardi Parente, che hanno coordinato il
lavoro di tesi e hanno fornito osservazioni e suggerimenti, la
dottoressa Vincenza Celluprica, che ha accolto questo volume
nella collana "Elenchos", i professori Enrico Berti e Luc Bris
son, che hanno letto il dattiloscritto per la pubblicazione.
Molte parti di questa ricerca sono frutto di soggiorni di
studio trascorsi, tra il settembre 1995 e il giugno 1999, a
Parigi presso l'U.P.R. 76 del C.N.R.S. (Histoire des doctrines
ve
de la fin de l' Antiquité et du Haut Moyen .Àge)e la Section
dell'École Pratique des Hautes Études. Desidero ringraziare
tutti coloro che ho avuto la fortuna di incontrare presso que
ste due istituzioni e, in particolare, Tiziano Dorandi, Richard
Goulet, Marie-Odile Goulet-Cazé, Michel Narcy, Alain-Phi
lippe Segonds. Ringrazio Marwan Rashed con cui ho discusso
di molti argomenti qui trattati. Sono riconoscente, soprat
tutto, a Philippe Hoffmann, del quale ho potuto apprezzare,
durante gli anni, la competenza e la generosità.
Desidero esprimere la mia gratitudine agli amici e ai col
leghi della Facoltà di filosofia dell'università di Roma "La
Sapienza", del C.N .R. di Roma e del "seminario plotiniano"
dell'università di Padova. Sono debitore, in particolare, a
12 SOSTANZA, MOVIMENTO, ANALOGIA
Emidio Spinelli, con il quale ho discusso e chiarito numerosi
punti di questa ricerca. Sono riconoscénte a Matteo Nucci,
che ha letto una prima versione della tesi, sul cui aiuto ho
sempre potuto contare. Ringrazio Maria Cristina Dalfino per
l'aiuto nella cura redazionale del volume.
Ringrazio Concetta Luna, che ha dedicato molto tempo a
ABBREVIAZIONI
rivedere questo lavoro e ne ha corretto numerose imperfe
zioni.
Un ringraziamento del tutto speciale va, infine, agli amici
Armstrong: Plotinus. The Enneads, English transl. by A.H.
Bruno Centrane, Cristina D'Ancona Costa e Alessandro Lin
ARMSTRONG7, voll., Cambridge Mass. 1966-1988
guiti, senza il cui sostegno e incoraggiamento questo libro non
Bréhier: Plotin. Ennéades, texte érabli et traduit par É. BRÉ
sarebbe stato scritto.
HIER, 7 voli., Paris 1924-1938
Casaglia, Guidelli, Linguiti, Moriani: Enneadi di Plotino, a
cura di M. CASAGLIAC, H. GUIDELLI,A . LrNGUITI,F .
MoRIANI,p refazione di F. ADORNO2, voll., Torino 1997
Cilento: Plotino. Enneadi, versione italiana e commentario
critico, a cura di V. CILENTO,3 voli., Bari 1947-1949
(II ediz. 1973)
F.D.S.: K. HDLSER,D ie Fragmente zur Dialektik der Stoiker, 4
voll., Stuttgart-Bad Cannstatt 1987-1988
Harder, Beutler e Theiler: Plotins Schriften, ùbersetzt von R.
HARDER,L eipzig 1930-1937, Neubearbeitung mit grie
chischem Lesetext und Anmerkungen von R. BEUTLERu .
W. THEILER,6 voll., 12 tomi, Hamburg 1956-1971
H.-S.1 Platini Opera, ed. P. HENRY-H.R. ScHWYZER3, voli.,
:
Paris-Bruxelles 1951-1973 (editio maior)
H.-S.2 Platini Opera, ed. P. HENRY-H.R. SCHWYZER3, voli.,
:
Oxonii 1964-1982 (editio minor)
Igal: Plotino. Enéadas, Intr., trad. y notas de J. !GAL,3 voll.,
Madrid 1982-1998
Sleeman-Pollet: J.H. SLEEMAN( t)-G. PoLLET, Lexicon Ploti
nianum, Leiden-Leuven 1980
S. V.F.: Stoicorum Veterum Fragmenta, ed. H. VON ARNIM, 3
voli., Leipzig 1903-1905, vol. 4, Indices, ed. M. AnLER,
Leipzig 1924
INTRODUZIONE
PLOTINO E LE CATEGORIE DI ARISTOTELE1
«Andare alla ricerca di questi concetti
fondamentali fu un progetto ben degno
di quell'acuto pensatore che fu Aristo
tele; mancando di ogni principio, egli
procedette però alla raccolta di essi così
come gli si presentavano, elencandone
dieci, a cui diede il nome di categorie».
(I. Kant, K.r.V . B 107)
BILANCIO DEGLI STUDI
In questo lavoro intendo ricostruire - a partire dal pro-
1 Dove non è indicato altrimenti, le traduzioni dei testi antichi e
dei testi moderni citati sono mie. Per Plotino, ho generalmente seguito il
testo delle Enneadi stabilito nella editio minor di Henry e Schwyzer
(Platini Opera, ed. P. HENRY-H.R. ScHWYZER3, voli., Oxonii 1964-
1982 = H.-S. 2 Ho tenuto conto, naturalmente, anche della editio
).
maior (Platini Opera, ed. P. HENRY-H.-R.S CHWYZER3, voli., Paris-Bru
xelles 1951-1973 = H.-S. 1 e degli interventi dei due editori: gli Ad
)
denda in coda alle due edizioni e H.-R. ScHWYZERC, orrigenda ad Platini
textum, «Museum Helveticum», XLIV (1987) pp. 191-210; In., Textkriti
sches zu Plotin und zur 'Vita Platini', in M.-O. GmJLET-CAzÉ-G.M ADEC
D. O'BRIEN (éds.), IO</>IHI MAIHTOPEI. «Cercheurs de sagesse».
Hommage à Jean Pépin, Paris 1992, pp. 343-6. Per VI 1-3 ho tenuto
presente la traduzione di M. Isnardi Parente (cfr. infra, p. 37 nota
72). La traduzione italiana Enneadi di Plotino, a cura di M. CASAGLIA
(Vita di Plotino ed Enn. I-II), CH. GUIDELL(IE nn. 1v-v), A. LINGUIT(IE nn.
III), F. M0RIANI( Enn. VI), 2 voll., Torino 1997 contiene un'eccellente
versione dei trattati Sui generi dell'essere e mi è stata indispensabile.
16 SOSTANZAM OVIMENTOA NALOGIA PLOTINOE LE CATEGORIDEI ARISTOTELE 17
blema delle categorie e dell'interpretazione di Aristotele - sono menzionare i giudizi di Prantl3, Zeller4, lnge5• Plotino
alcuni aspetti della concezione plotiniana del mondo sensi avrebbe elaborato una teoria oscura, nella quale avrebbe mal
bile e della sua relazione con l'intellegibile. Questo studio è destramente ripreso, confondendole, le teorie dei suoi prede
dedicato soprattutto all'interpretazione dei trattati VI 1-3, cessori, Platone e Aristotele, senza pervenire a nessuna acqui
Sui generi del!' essere (flgpì ,&v yf:v&v -rou ov-roç), che Porfirio sizione di rilievo. Le parole dedicate a Plotino nella celebre
indica con i numeri 42, 43 e 44 nell'ordine cronologico 2• Si Geschichte der Kategorienlehred i F.A. Trendelenburg manife
tratta in realtà, come è noto, di un solo lungo trattato,
stano al meglio questa lettura: « ... ci si chiede se ciò sia di
diviso in tre da Porfirio nella sua edizione delle Enneadi,
ventato un'armoniosa mescolanza [tra concetti platonici e ari
dedicato alla dottrina delle categorie. La tripartizione por
stotelici], oppure sia rimasto un'accozzaglia» 6 La confusione,
firiana corrisponde bene all'andamento dello scritto: in VI 1 •
l'aridità, l'esasperante oscurità di VI 1-3 (der monstrose Trak
Plotino esamina criticamente le teorie delle categorie dei
tat) 7 ne sono state per lungo tempo le caratteristiche più note
Peripatetici (capp. 1-24) e degli Stoici (capp. 25-30); in VI 8.
Simili apprezzamenti possono sembrare, a un primo
2 sviluppa la propria concezione dei generi del mondo intel
esame, più che giustificati. Un'esposizione malevola del con
legibile, in conformità alla dottrina dei µéytcna yévri del
Sofista platonico (essere, identico, diverso, movimento, tenuto di VI 1-3 potrebbe essere quella che segue. In VI 1,
quiete); in VI 3, infine, Plotino espone la sua teoria dei Plotino polemizza contro le tesi peripatetiche e stoiche mo-
generi del mondo sensibile (sostanza, quantità, qualità, mo
vimento, relativo).
Se l'opera di Plotino ha suscitato giudizi contrastanti, ) Cfr. C. PRANn, Geschichted er Logik im AbendlandeI,, Leipzig
talvolta tutt'altro che positivi, il trattato Sui generi del!'e ssere 1855, p. 613 sg. Prantl rivolge critiche molto aspre all'insieme della
filosofia plotiniana e non solo alla teoria delle categorie.
ha ricevuto, nella storia degli studi, vere stroncature, e solo di
' Cfr. E. ZEl.l.ER,D ie Philosophie der Griechen in ihrer geschicht
recente gli interpreti si sono avvicinati a questo scritto con
lichen Entwicklung, m/2, Leipzig 1903 ', p. 578.
atteggiamento più equanime. Come esempi della tradizionale 5 Cfr. D. INGE, The Philosophy o/Plotinus, II, London 1918, p. 58:
svalutazione della dottrina plotiniana delle categorie si pos- «The long discussion of the Categories in the Sixth Ennead seems to me
the least interesting part of the whole book».
6 F.A. TRENDELENBURGG, eschichte der Kategorienlehre, Berlin
1846, p. 232.
7 Cfr. T.A. SzLEZAK,r ecensione di K. WuRM, Substanz und Qua
litii,t. Ein Beitrag zur Interpretation der plotinischen Traktate VI 1, 2 und 3,
Berlin-New York 1973, «Gèittingische Gelehrte Anzeigen», CXXVII
{1975) pp. 216-25, partic. p. 216.
Cfr., tuttavia, le pagine molto più sottili e perspicaci dedicate
' Cfr. PoRPH. vita Plot. 5, 51 sgg. Questi trattati sono situati alle categorie plotiniane già da E. VON HARTMAN •, Geschichte der Meta
cronologicamente alla fine del soggiorno di Porfirio presso la scuola di pbysik, 1 Leipzig 1899, pp. 106-76, panie. pp. 108-35 sulle categorie del
Plotino. Sulla cronologia della Vita di Plotino e i problemi che essa pone, mondo sensi.pile. Sulla ricezione di v1 1-3 nelle ricerche plotiniane, dr.
dr. R. GoULET, Le système chronologique de la 'Vie de Plotin', in V. CILENTO,C ategorie del sensibile, in In., Saggi su Plotino, Torino 1973,
AA.VV., Porphyre. La Vie de Plotin, 1, Travaux préliminaires et index pp. 83-96; K. WuRM, Substat1<u nd Qualitiit (cit. supra, nota 7), p. 139
grec complet, Paris 1982, pp. 187-227 = R. GouLET, Études sur !es Vies nota 13; I.A. SZLEZAKa rt. cit., p. 216 sg.; C1-1H. ORN, Plotin iiberSein,
de philosophes de l'Antiquité tardive, Paris 2001, pp. 153-90. Zahl und Einheit, Stuttgart-Leipzig 1995, p. 30 sg.
18
SOSTANZA MOVIMENTO ANALOGIA PLOTINO E LE CATEGORIE DI ARISTOTELE 19
strandone capziosamente l'insufficienza 9• Egli presuppone in riprende dottrine aristoteliche (quelle stesse dottrine che
fatti come criterio di valutazione delle teorie respinte la con erano state criticate in VI 1), pur associandole a elementi dot
trapposizione - di ispirazione platonica - tra generi e sostanza trinali tipicamente platonici. Ne risulta una concezione ibrida
sensibili e generi e sostanza intellegibili. L'obiezione generale e oscura che Plotino esprime, per di più, con un linguaggio
contro la teoria peripatetica si limita così ad affermare la sempre difficile e tecnico, talora quasi incomprensibile. La
validità del dualismo platonico, dualismo del quale i Peripate teoria plotiniana delle categorie apparirebbe così come un
tici avrebbero mancato di dare conto nella loro divisione (v1 1 completo fallimento. In questo studio cercherò, invece, di
[42), 1. 28-9). L'omonimia tra l'oùaia sensibile e quella ìntel mostrare come le argomentazioni di VI 1-3 non incorrano in
legibile ossia - secondo la nozione aristotelica dell'omonimia nessuna delle critiche che una presentazione affrettata o ma
che Plotino riprende e ritorce contro Aristotele - la diversa levola porterebbe a sollevare, e neppure nell'accusa, a prima
essenza di queste realtà provviste di nome comune t0, e la vista giustificata, di oscurità; come si tratti di testi profondi,
relazione gerarchica sussistente tra di esse, impediscono di la cui comprensione permette di intendere in modo per alcuni
sussumerle sotto un solo genere, e dimostrano dunque come versi inatteso l'insieme della filosofia di Plotino.
la lista aristotelica delle categorie (che di questa omonimia non Non sono d'altra parte affatto mancate, neppure nel pas
ha tenuto conto) sia insufficiente. È facile deouociare il ca sato, letture approfondite ed equilibrate dei trattati Sui generi
rattere dogmatico, specioso ed estrinseco di una simile critica, dell'essere. È significativo che, sebbene gli studiosi di Plotino
che accetta, senza discuterla, la validità della tesi platon.iz abbiano più volte notato il carattere filosoficamente insoddi
zante, valutando a partire da questo criterio le posizioni degli sfacente di VI 1-3, sia stato proprio un filosofo illustre, E.
avversari. Parimenti fuorviante ed estrinseca appare la teoria Lask, a rivendicare tra i primi il valore di questi scritti. La
di VI 2 (43], nella quale Plotino riprende i cinque generi del sua Kategorienlehre reca in esergo la frase di VI 1, 1 a cui ho
Sofista platonico interpretandoli nel quadro della propria con prima fatto allusione, nella quale Plotino contesta alla divi
cezione del voùç. Ancora una volta, non si è mancato di sot sione aristotelica delle categorie di non aver tenuto conto dei
tolineare i fraintendimenti generati da una simile interpreta generi del mondo intellegibile: «Ma essi non fanno parola
zione u. In VI 3 [4 4], ossia la sezione del trattato dedicata alle degli intellegibili nella loro divisione: non hanno dunque vo
categorie del mondo sensibile, la confusione sembra poi di luto dividere tutti gli enti, ma hanno lasciato da parte quelli
ventare totale. Plotino presenta una lista di cinque generi, che che lo sono massimamente (ÙÀ.Àm.à :pì téòv vorit&v Katà tiJv
òtaipscnv où Myoucnv· où na.v-caè ipa tà ovta ò1mpdcr8m t~ou
À:iJ8ricrcxàvU, à tà µa.À.tcrtao vm napaÀ.sÀ.oinacnv)»(V I 1, 1.28-
' La critica antistoica di VI 1, 25-.30 non sarà presa in considera•
zione in questo studio. Per un suo esame si veda A. GRAESER, Plotim,s 30) 12• Secondo Lask, la concezione plotiniana delle categorie
and the Stoics. A PreliminaryS tudy, Leiden 1972, pp. 87-100. segnerebbe una tappa decisiva nella storia del pensiero antico.
1° Cfr. vr 1, 1.24 sgg.; 2. 1 sgg. vs AR.ISToTc. at. 1. 1 a 1-6. Plotino avrebbe diretto la riflessione logica su una questione
11 Cfr., ad esempio, F. CORNFORD,P lato's Theory o/ Knowledge.
The 'Theaeletusa' nd the 'Sophist',L ondon 1935, 19708, p. 274. E. Za
LER, op. cit., p. 578 osservava: <<... witl<lich hat ja auch PJotin seine 12 Cfr. É. LASK, Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre.
iibersinnlicheK ategorienn ur an der Hand Platos mii.hseligg eaug gefun Bine Studie iiber den Herrschaftsbereichd er logischenF orm, Ttibingen 1911
dero>.
(1993', mit einem Nachwort von F. KAULBACH).
20 21
SOSTANZA MOVIMENTO ANALOGIA PLOTINO E LE CATEGORIE DI ARISTOTELE
che Platone e Aristotele non avevano messo a fuoco. Plotino che - come si vedrà - lo porta a respingere ogni tentativo di
sarebbe infatti stato il primo a fare dell' "universalità del lo conciliazione tra categorie peripatetiche e dualismo plato
gico" l'oggetto esplicito del suo pensiero. Per la prima volta, nico.
egli portò la riflessione sulla possibilità che il "logico" eserciti Un importante progresso nella comprensione di VI 1-3
il proprio dominio anche su ciò che è sovrasensibile u. Mentre venne dalle introduzioni a questo trattato scritte da É. Bré
Aristotele concepisce le proprie categorie come dotate di un hier nella sua traduzione delle Enneadi11 Alla valutazione fi
•
valore universale, che ingloba la totalità di ciò che è pensabile, losofica si associava finalmente una equilibrata comprensione
Plotino mette in questione il problema stesso dell'universalità storica, nella quale la dottrina plotiniana era esaminata non
della logica. Ciò lo porta a contestare ad Aristotele di aver solo in rapporto alle teorie platonica, aristotelica e stoica, ma
trasposto acriticamente all'intellegibile una teoria delle cate anche alla tradizione esegetica antica testimoniata dai com
gorie che poteva applicarsi soltanto al mondo sensibile 14• Se menti neoplatonici alle Categorie18• Molto pregevoli sono le
condo Lask, per Plotino «l'incomparabilità tra i due emisferi pagine dedicate alla critica plotiniana della teoria del movi
del tutto, stabilita dalla teoria dei due mondi»15 doveva tro mento di Aristotele, nelle quali Bréhier confronta l'atteggia
vare espressione anche nella dottrina delle categorie. Dall' op mento di Plotino con la conciliazione tra platonismo e aristo
posizione all'interno di ciò che è pensabile si sarebbero dovute telismo propria dei Platonici successivi e, in particolare, di
trarre tutte le conseguenze, affermando una dualità all'interno Giamblico.
del contenuto categoriale: «Plotino mette fine all'uso acritico Un importante contributo alla valutazione della conce
di determinazioni categoriali comuni per i due mondi. Per la zione plotiniana del mondo sensibile è stato portato da Ch.
prima volta, egli mise in evidenza nella dottrina delle catego Rutten nel 1961, con il suo studio dedicato alle categorie del
rie la dualità fondamentale, l'irriducibilità delle sfere diffe mondo sensibile 19• La sua interpretazione si basa su una lettura
renti che costituiscono ciò che è pensabile»16 "idealistica" della filosofia di Plotino, filosofia che - come
•
Sebbene la lettura di Lask abbia un carattere marcata Rutten sostiene seguendo M. De Corte - manifesterebbe
mente personale e speculativo, alcune sue osservazioni col una confusione tra l'essere e il conoscere20, tra l'oggetto for
gono con illuminante precisione i motivi soggiacenti alla teo male quo e l'oggetto formale quod, tra il mezzo e il fine, tra la
rie di Plotino. Su tutti, come cercherò di mostrare, sta l'esi ricerca e il sistema che si scopre in essa 21• Le ipostasi andreb
genza di comprendere in se stessa la natura degli intellegibili, bero dunque concepite come "livelli noetici": «In ogni ipostasi
senza trasferirvi indebitamente i princìpi adeguati alla spie
gazione delle realtà sensibili. Questa esigenza viene fatta va
17 Cfr. É. BRÉHIERP, lotin. Ennéades, Texte établi et traduit, v11,
lere da Plotino con un rigore ignoto agli altri Platonici, rigore
Paris 1936, pp. 7-58.
1• Un impulso in questa direzione, soprattutto per quanto con
cerne il rapporto tra Plotino e i suoi predecessori, era venuto dagli studi
" Ivi, p. 234: «. .. die Herrschaft des Logischen auch uber das di K. Praechter (cfr. infra, p. 43 nota 85).
Ùbersinnliche». 19 Cfr. CH. RuTTEN, Les catégories du monde sensible dans !es 'En
" Ivi, p. 237. néades' de Plotin, Liège-Paris 1961.
" Ivi, p. 235. 20 Ivi, p. 31.
1• Ivi, p. 236. 21 Ivi, p. 16.