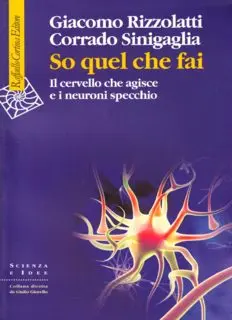Table Of ContentGiacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia
So quel che fai
Il cervello che agisce e i neuroni specchio
~
Raffaello Cortina Editore
www.raffaellocortina.it
ISBN 88-6030-002-9
© 2006 Raffaello Cortina Editore
Milano, via Rossini 4
Prima edizione: 2006
INDICE
Ringraziamenti IX
Premessa
n
1. sistema motorio 5
n
2. cervello che agisce 23
3. Lo spazio intorno a noi 53
4. Agire e comprendere 79
5. I neuroni specchio nell'uomo 113
6. Imitazione e linguaggio 135
7. Condividere le emozioni 165
Bibliografia 185
Indice analitico 211
VII
RINGRAZIAMENTI
Desideriamo anzitutto ringraziare Giulio Giorello per avere scom
messo sul progetto di un libro come questo. Senza il suo sostegno
difficilmente avremmo potuto portarlo a termine.
Molti dei lavori e dei risultati descritti nel volume sono il frutto di
anni di ricerche condotte presso l'Università di Parma. A esse hanno
partecipato in maniera decisiva numerosi amici e colleghi. Massimo
Matelli, Maurizio Gentilucci e Giuseppe Luppino hanno contribui
to enormemente alla definizione della molteplicità delle aree moto
rie corticali e allo studio delle loro funzioni. Luciano Fadiga, Leo
nardo Fogassi e Vittorio Gallese hanno condiviso sin dall'inizio la
scoperta delle sorprendenti proprietà dei neuroni specchio. Michael
Arbib, Mare Je annerod, Hideo Sakata hanno svolto un ruolo chiave
nell'elaborazione del quadro teorico qui presentato. Scott Grafton,
Marco Iacoboni, Giovanni Buccino e il gruppo di brain imaging di
Milano diretto da Ferruccio Fazio hanno permesso di realizzare non
pochi esperimenti di PET e di risonanza magnetica funzionale. Laila
Craighero, Pier Francesco Ferrari, Christian Keysers e Maria Ales
sandra Umiltà si sono fatti carico di un grande lavoro sperimentale.
A loro e a tutti gli altri che hanno fatto e continuano a far parte del
l'équipe di Parma va il nostro più sentito ringraziamento.
Siamo grati anche a Claudio Barrocci, Giorgio Bertolotti, Anto
nino Cilluffo, Gabriella Morandi, Stefano Moriggi per aver avuto la
cortesia di leggere parti del manoscritto e per non averci fatto man
care consigli e suggerimenti. Domenico Mallamo ci ha aiutato nel
reperire il materiale iconografico.
Un grazie, infine, a Mariella Agostinelli per la passione e compe
tenza con cui ha seguito ogni fase del nostro lavoro, e a Raffaella Voi
e Giorgio Catalano per la preziosa e paziente cura editoriale.
IX
PREMESSA
Qualche tempo fa Peter Brook ha dichiarato in un'intervi
sta che con la scoperta dei neuroni specchio le neuroscienze a
vevano cominciato a capire quello che il teatro sapeva da sem
pre. Per il grande drammaturgo e regista britannico il lavoro
dell'attore sarebbe vano se egli non potesse condividere, al di
là di ogni barriera linguistica o culturale, i suoni e i movimenti
del proprio corpo con gli spettatori, rendendoli parte di un e
vento che loro stessi debbono contribuire a creare. Su questa
immediata condivisione il teatro avrebbe costruito la propria
realtà e la propria giustificazione, ed è a essa che i neuroni
specchio, con la loro capacità di attivarsi sia quando si compie
un'azione in prima persona sia quando la si osserva compiere
da altri, verrebbero a dare base biologica.
Le considerazioni di Brook rivelano quanto interesse ab
biano destato al di fuori degli stessi confini della neurofisiolo
gia le inaspettate proprietà di quei neuroni. Esse hanno colpi
to non soltanto gli artisti, ma anche gli studiosi di psicologia,
di pedagogia, di sociologia, di antropologia, ecc. Pochi forse
conoscono, però, la storia della loro scoperta, le ricerche spe
rimentali e i presupposti teorici che l'hanno resa possibile,
nonché le implicazioni che essa avrebbe sul nostro modo di
intendere l'architettura e il funzionamento del cervello.
È appunto tale storia che questo libro vuole provare a rac
contare. È una storia che inizia con l'analisi di alcuni gesti (c o
me raggiungere e afferrare qualcosa con la mano, portare del
cibo alla bocca) che per la loro familiarità tendiamo a sottova-
PREMESSA
lutare, e che ha un protagonista cui a lungo le neuroscienze (e
non solo loro!) hanno assegnato un ruolo di secondo piano,
riducendolo talvolta a semplice comparsa: il sistema motorio.
Per decenni ha dominato l'idea che le aree motorie della
corteccia cerebrale sarebbero destinate a compiti meramente
esecutivi, privi di alcuna effettiva valenza percettiva e, meno
che mai, cognitiva. Le difficoltà maggiori nello spiegare i no
stri comportamenti motori riguarderebbero l'elaborazione
dei diversi input sensoriali e l'individuazione dei substrati
neurali dei processi cognitivi legati alla produzione di inten
zioni, credenze, desideri. Una volta che il cervello è in grado
di selezionare il flusso di informazioni proveniente dall'ester
no e di integrarlo con le rappresentazioni mentali generate più
o meno autonomamente al suo interno, i problemi inerenti al
movimento si risolverebbero nella meccanica della sua esecu
zione - secondo il classico schema: percezione -+ cognizione
-+ movimento.
Uno schema del genere poteva risultare convincente finché
del sistema motorio si aveva un'immagine estremamente sem
plificata. Ma oggi non è più così. Sappiamo che tale sistema è
formato da un mosaico di aree frontali e parietali strettamente
connesse con le aree visive, uditive, tattili, e dotate di pro
prietà funzionali molto più complesse di quanto si potesse so
spettare. Si è scoperto, in particolare, che in alcune aree vi so
no neuroni che si attivano in relazione non a semplici movi
menti, bensì ad atti motori finalizzati (come lafferrare, il tene
re, il manipolare, ecc.), e che rispondono selettivamente alle
forme e alle dimensioni degli oggetti sia quando stiamo per in
teragire con essi sia quando ci limitiamo a osservarli. Questi
neuroni appaiono in grado di discriminare l'informazione
sensoriale, selezionandola in base alle possibilità d'atto che es
sa offre, indipendentemente dal fatto che tali possibilità ven
gano concretamente realizzate o meno.
Se guardiamo ai meccanismi secondo cui funziona il nostro
cervello ci rendiamo conto di quanto astratta sia la descrizione
abituale dei nostri comportamenti che tende a separare i puri
movimenti fisici dagli atti che tramite questi verrebbero ese-
2