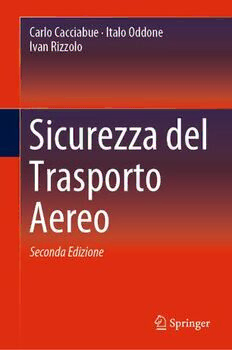Table Of ContentC
a
c
c Carlo Cacciabue · Italo Oddone
i
a
b
u
e Ivan Rizzolo
·
O
d
d
o
n
e
·
R
i
z
z
o
l
o
Sicurezza del
Trasporto
S
i
c
u
r
e
z
z
a Aereo
d
e
l
T
r
a
s
p
o Seconda Edizione
r
t
o
A
e
r
e
o
2nd Ed.
Sicurezza del Trasporto Aereo
Carlo Cacciabue Italo Oddone
(cid:129) (cid:129)
Ivan Rizzolo
Sicurezza del Trasporto
Aereo
Seconda Edizione
123
CarloCacciabue Italo Oddone
KingstonUniversity London Politecnico di Milano
KingstonuponThames, UK Milano,Italy
IvanRizzolo
Universitàdi Padova
Padova,Italy
ISBN978-88-470-3988-9 ISBN978-88-470-3989-6 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-88-470-3989-6
LibraryofCongressControlNumber:2019933177
©Springer-VerlagItaliaS.r.l.,partofSpringerNature2010,2019
Thisworkissubjecttocopyright.AllrightsarereservedbythePublisher,whetherthewholeorpart
of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations,
recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission
orinformationstorageandretrieval,electronicadaptation,computersoftware,orbysimilarordissimilar
methodologynowknownorhereafterdeveloped.
The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this
publicationdoesnotimply,evenintheabsenceofaspecificstatement,thatsuchnamesareexemptfrom
therelevantprotectivelawsandregulationsandthereforefreeforgeneraluse.
The publisher, the authors and the editors are safe to assume that the advice and information in this
book are believed to be true and accurate at the date of publication. Neither the publisher nor the
authorsortheeditorsgiveawarranty,expressorimplied,withrespecttothematerialcontainedhereinor
for any errors or omissions that may have been made. The publisher remains neutral with regard to
jurisdictionalclaimsinpublishedmapsandinstitutionalaffiliations.
ThisSpringerimprintispublishedbytheregisteredcompanySpringer-VerlagItaliaS.r.l.partofSpringer
Nature
Theregisteredcompanyaddressis:ViaDecembrio28,20137Milano,Italy
Prefazione
Questotestocontienel’insiemedellelezionirelativealcorsoaccademicoperinge-
gneri aerospaziali orientato allo sviluppo di una competenza teorica e applicativa
nella “Sicurezza del Trasporto Aereo”. Particolare attenzione è dedicata all’anali-
si dei rischi associati alle operazioni, attività e gestione di situazioni normali e di
emergenza.Isistemiconsideraticopronotuttoildominiodeltrasportoaereo,com-
prendenteilvoloetrasportopasseggeri,lagestionedegliaeroportiedelleoperazioni
di terra, il controllo del traffico aereo e la manutenzione. Nella presente edizione,
iltestoèstatoaggiornato,perquantoconcernelapartetecnica,conmetodologiee
metodirecentiedinnovativie,perlapartenormativa,conuninterocapitolodedi-
catoallenormeestandarddefinitinegliultimiannidalleautoritànazionaliitaliane
edeuropee.
Il volume è stato sviluppato per rispondere alla necessità di raggruppare in un
unicotestocinqueaspettiimportantiesinergiciperlaformazionediuningegneredi
sicurezza.Taliaspettisono:1)lenozionidistatistica,necessarieperlavalutazione
quantitativa del rischio; 2) gli approcci di analisi di sicurezza sistemica, indispen-
sabiliperlostudioeprogettazionediimpiantibasatisuvalutazioniprobabilistiche
di sicurezza; 3) la considerazione dei fattori umani, sia sotto il profilo modellisti-
cocheprobabilisticoesistemico,fondamentaliperl’inclusionedelcontributodell’
“erroreumano”allavalutazionequantitativadelrischioglobaledelsistemauomo-
macchina;4)lametodologiaintegrativadituttetaliteorieetecnicheinunavisone
piùampiadiSistemadiGestionedellaSicurezza(“SafetyManagementSystem”),
che risponde alle attuali esigenze e richieste normative delle Autorità di sicurezza
internazionalienazionali;edinfine5)gliaspettinormativieregolamentaridellasi-
curezzaaereaperlacertificazionerichiestaaigestoriaeroportualiedaglioperatori
aerei.
Per mantenere uno sviluppo logico di apprendimento progressivo degli aspetti
teoricieperlaloroinquadraturainunprocessometodologicodianalisidisicurez-
za sistemica, sono stati previsti cinque capitoli principali e tre appendici. Il primo
capitoloaffrontaleproblematicherelativeaglielementifondamentalidistatisticae
descriveletecnichepiùcomunementeutilizzatepereffettuareanalisiprobabilistica
prospetticadirischio.Ilsecondocapitoloèinteramentededicatoaimodellidicom-
v
vi Prefazione
portamento umano, orientati all’identificazione delle cause e modalità degli errori
umani,nonchéalladescrizionedelletecnicheprincipaliperlavalutazioneprobabi-
listica del contributo dell’errore umano all’analisi del rischio. Il terzo capitolo af-
frontailproblemadell’analisidirischioperlavalutazioneretrospettivadeipericoli
edelleconseguenzechesisonorealmenteverificateinun’organizzazione.Nelquar-
tocapitolosiinquadral’analisidirischioinunaprospettivadiSistemadiGestione
dellaSicurezzaconl’obbiettivodimostrareilcontributodell’analisidisicurezzain
unaprospettivametodologicapiùampiaedintegratadituttiisistemideltrasporto
aereo.Ilquintocapitoloèinteramentededicatoallanormativavigenteinmateriadi
sicurezzadeltrasportoaereoedaiprocessievolutivichel’hannogeneratanegliulti-
mianniconlaformalizzazionedell’AgenziaEuropeaperlasicurezzadeltrasporto
aereo,EASA(“EuropeanAviationSafetyAgency).Infine,letreappendicisonode-
dicateadaltrettantiesempiapplicativipratici,relativiasistemiedeventireali,delle
tecniche e metodologie descritte nei capitoli precedenti: il primo caso riguarda la
valutazionedelrischioassociatoadunaoperazioneaeroportuale;ilsecondocasoè
basatosullostudiodidettagliodellecausediunincidentereale,applicandodiverse
tecnichedianalisideifattoriumani;ilterzocasorappresental’analisiretrospettiva
diunincidenterealeavvenutoall’internodiunsedimeaeroportuale,sottoilprofilo
normativo.
Piùindettaglio,ilCapitolo1,intitolato“Analisisistemicadisicurezza:concetti
emetodi”,rappresental’elementoportantedelteso,inquantocontienelarassegna
deimetodistatisticiediconcettifondamentalidellateoriadellaprobabilitàcherap-
presenta la tecnica di base per l’analisi quantitativa di rischio. Sono poi passati in
rassegna i metodi più comuni per la valutazione e quantificazione prospettica del
rischioassociatoallagestionedisistemicomplessi,dai“classici”AlberidiGuasto
edAlberidiEventoallapiùrecenteteoriadianalisifunzionaledeisistemi.IlCapi-
tolo2,intitolato“Fattoriumaninell’analisidisicurezza”,presentaleteorie,modelli
di comportamento e metodi per l’implementazione dei fattori umani in analisi di
sicurezza.Inparticolare,vienediscussaindettagliounadelletecnicheclassichepiù
comunementeutilizzateperl’inclusionedeifattoriumaniinanalisidirischio,con
esempiapplicativisemplici.NelCapitolo3,intitolato“Metodiperanalisiretrospet-
tive”,sonodiscussiicomponentifondamentalipereffettuarelostudiodioccorrenze
edeventirealmenteaccaduti.L’obbiettivoèquellodimostrarecomemetodieteorie
dianalisidelrischiovenganoapplicatiperlavalutazionedisituazionireali,epertan-
tocomequestipossanoessereapplicatiperlaraccoltadiinformazioni,l’implemen-
tazioneinbanchedati,esoprattuttoperl’analisielosviluppodiraccomandazioni
relativeadoccorrenze,inconvenientigraviedincidenti.NelCapitolo4,intitolato“Il
SafetyManagementSystememetodologiaintegrataperl’analisidisicurezza”,vie-
neaffrontatalaproblematicadellagestionedellasicurezzasottounprofiloglobale,
checopretuttigliaspettidistudioedanalisideipericoliassociatialtrasportoaereo
edallalorogestione.Ciòchiudeilciclodipresentazionedelprocessometodologico
diapplicazionedelconcettodirischioperanalisidisicurezzaintegrateretrospettive
eprospettiche,iniziatofindalcapitolouno,echerappresentailfiloconduttoredel
discorsosullasicurezzaneltrasportoaereodiquestotesto.Infine,nelCapitolo5so-
noesaminatil’evoluzionedellanormativacogenteedirisultatiottenutifinoadoggi
Prefazione vii
pergarantirelasafetyeleimplicazionigestionalichenederivanopergliaeroporti
e le compagnie aeree. In particolare, si entrerà nel dettaglio della certificazione di
aeroportoedelleoperazionidivolo,rispettivamenteconiRegolamentiUE139/14e
UE965/12.L’Appendice1contieneilcasostudioprospetticosicurezzadelrischio
diincidentedacambiopista.Diversimetodipresentatineltestovengonoapplicati
econfrontaticriticamente.L’Appendice2prendeinesamel’incidentedicollisione
conilterrenodelvoloAZ404avvenutail14Novembre1990neipressidiZurigo,
acuivengonoapplicatituttiimetodiperlaclassificazionedellecauserelativeagli
erroriumanipresentatineltesto.Anchel’Appendice3prendeinesameuncasorea-
lediincidenteaereo.Inquestocaso,sitrattadiunincidenteavvenutoall’internodi
unaeroporto,cuisiapplicanolemetodologiedianalisiretrospettivadescrittenelte-
sto,mainrelazionealrispettodellenormativeeregolamentazionivigentiall’epoca
dell’incidente,giungendoadunadescrizioneevalutazionedellacausediincidente
sotto il profilo normativo, piuttosto che di analisi dettagliata della sequenza degli
eventiedelcomportamentoumano.
Essendo questo libro dedicato agli studenti di Ingegneria Aerospaziale, è stato
scrittoconintentodidatticoedinun’otticadiletturacompletaeprogressiva.Pertan-
to,siconsigliatadileggereicapitoliinsequenza,passandoalleappendiciqualora
sivolesseacquisirefamiliaritàconl’applicazionepraticadeimetoditeorici.Peral-
tro,unlettorepiùespertoeconoscitoredeimetodidianalisiprobabilisticapotrebbe
concentrarsisuicapitoli3e4diapplicazionemetodologicaedutilizzareleappen-
dici come banco di prova e valutazione di applicazioni pratiche. Qualora vi fosse
lanecessitàdiinquadrareleproprieanalisiinbaseallenormevigenti,ilCapitolo5
offresupportoeguidasiaperilgestoreaeroportualecheperl’operatoredicompa-
gniaaerea.Infine,sinoticome,inconcomitanzaconlapubblicazionedelpresente
testo, è stata pubblicata la versione 4 del Manuale ICAO 9859 (ICAO, 2018), che
contienediversiaspettiinnovativiinmeritoall’analisidirischiocheèunadisciplina
“evolutiva” in permanente sviluppo e crescita. I contenuti del presente testo resta-
noconcettualmenteconsolidatiedallineatialcontenutodelManualeICAO,ferme
restando le necessarie estensioni dei concetti ivi espressi ed, in particolare, della
specificitàdellaMatricediRischiochedeveessereadattatadaogniorganizzazione
allapropriadimensioneedattivitàspecifiche.
Ringraziamenti
RingraziamoprofondamenteGiuseppeBorgna,StanislaoLanciaeFabioTotie,in
generale,ilcomitatoitalianodisicurezzavolo(IFSC)perilsupportoedilconfronto
sugliaspettifondantiilSafetyManagementSystem(SMS)epiùinparticolaresugli
aspettiapplicatividiconcettiqualirischio,pericolo,tassonomieemetodidianalisi.
Ringraziamo inoltre per le discussioni avvenute all’interno del comitato ristretto,
delleassembleeplenarieeall’internodeicorsiformatividell’IFSC.
Alivellopersonale,siringrazialo“zio”,mentoredaquasi30anni,edilmigliore
allievo,“ilsaggio”,peravercondivisointereseratesultemadelrischioeleanalisi
neisuoirisvoltipratici.Perentrambivastimapersonaleeprofessionale.
Ringraziamo tutti gli studenti e partecipanti al Corso “Sicurezza del Trasporto
Aereo” del Politecnico di Milano degli anni passati per aver “studiato” sulla pri-
ma edizione del testo ed aver richiesto delucidazioni e chiarimenti che sono stati
utilissimiperlastesuradellasecondaedizione.
Infine,siamosentitamentegratiallenostreFamiglie,ed,inparticolare,allenostre
compagnedivita,Catherine,ClaudiaePamela,peraverpazientementeedamore-
volmenteaccettato“assenze,distrazioniedisattenzioni”legatealladiscussione,ge-
nerazione,scritturaerevisionedeicontenutideltesto.AdEsse,edainostriFigli,è
dedicatoquestolibro.
ix
Autori
Pietro Carlo Cacciabue è l’autore della prima edizione del presente volume ed è
statopercirca10annititolaredelCorsodiSicurezzadelTrasportoAereopressoil
PolitecnicodiMilano,DipartimentodiIngegneriaAerospaziale.
Ricercatoredaoltre30annineldominiodellasicurezzanucleareedaeronautica,
CarloCacciabueèautoredinumerosepubblicazioniscientificheecontinual’attività
accademica e di ricerca presso la Kingston University London, UK, Dipartimento
“AerospaceandAircraftEngineering”.
ItaloOddoneèl’attualetitolaredelCorsodiSicurezzadelTrasportoAereopresso
il Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale. Egli ha conse-
guitolaLaureainScienzeAeronautichepressol’UniversitàFedericoII,Napoliela
LaureainScienzePolitichepressol’UniversitàdiTrieste.
È pilota militare/civile, attualmente in pensione, con oltre 14.000 ore di vo-
lo ed è il Presidente del Comitato Italiano Sicurezza Volo (“Italian Flight Safety
Committee”–IFSC).
Ivan Rizzolo, titolare del corso di Sicurezza nel Trasporto e nelle Infrastrutture
StrategicheecollaboraalladocenzanelcorsoSicurezzadelTrasportoAereopresso
l’Università di Padova. Ha conseguito la laurea in Scienze Giuridiche presso l’U-
niversità di Ferrara e la laurea in Scienze Criminologiche per l’investigazione e la
Sicurezza presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Ha al suo attivo
numerosepubblicazioniecollaborazioniconaltriateneiitalianieistituzionisuite-
mi della Safety aerea e Security e gestione del rischio delle operazioni in sistemi
organizzativicomplessi.
xi
Indice
Abbreviazioni...................................................... xix
1 Analisisistemicadisicurezza:concettiemetodi ................... 1
1.1 Introduzione............................................... 1
1.1.1 Iconcettidisistemaesicurezza ........................ 1
1.1.2 Ilconcettodirischio.................................. 9
1.2 Cennidimetodistatistici .................................... 16
1.2.1 Lateoriadellaprobabilità ............................. 16
1.2.2 Grandezzetipicheinanalisistatistica.................... 19
1.2.3 Alberidiprobabilitàedistribuzionidiscreteecontinue..... 23
1.2.4 Cennidialgebrabooleana............................. 29
1.3 Rassegnadimetodiperlaquantificazionedelrischio............. 31
1.3.1 Fasiemetodologieprincipaliperquantificareilrischio..... 31
1.3.2 Analisipreliminaredeipericoli......................... 33
1.3.3 Analisidelrischiodelsistema.......................... 34
1.3.4 Implementazionedellemisuredisicurezza............... 36
1.4 AlberidiEventoeAlberidiGuasto ........................... 37
1.4.1 AlberidiEvento ..................................... 37
1.4.2 AlberidiGuasto ..................................... 39
1.5 SicurezzaFunzionale ....................................... 44
1.5.1 Definizione e concetto di integrità dei sistemi
disicurezza-SIL .................................... 45
1.5.2 SILeaffidabilità..................................... 46
1.5.3 CalcolodelvaloredelSIL............................. 47
1.6 Metodologiaglobaleperlavalutazioneprospetticadelrischio ..... 59
2 Fattoriumaninell’analisidisicurezza ............................ 65
2.1 Introduzione............................................... 65
2.2 IFattoriUmaninellatecnologiamoderna ...................... 66
2.3 Definizioniedelementicaratteristicidisistemiuomo-macchina.... 68
xiii