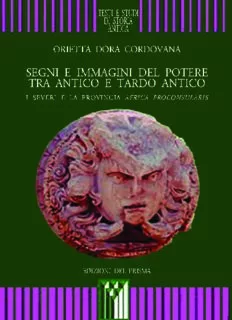Table Of ContentORIETTA DORA CORDOVANA
SEGNI E IMMAGINI DEL POTERE
TRA ANTICO E TARDOANTICO
I SEVERI E LA PROVINCIA
AFRICA PROCONSULARIS
EDIZIONI DEL PRISMA
Volume pubblicato con il cofinanziamento del MIUR
Università degli Studi di Roma «La Sapienza»
Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche
Antropologiche dell’Antichità
Cordovana, Orietta Dora <1966>
Segni e immagini del potere antico e tardoantico: i Severi e la provincia:
Africa proconsularis / Orietta Dora Cordovana – 2 ed. – Catania: Edizioni
del Prisma, 2007.
(Testi e studi di storia antica; 17)
1. Impero romano – Storia - Sec. 2-3 d.C. 2. Severi <dinastia>.
937.07 CDD-21 SBN Pal0207722
CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana «Alberto Bombace»
Seconda edizione rivista ed aggiornata
© Copyright Edizioni del Prisma s.r.l.
Via G. Lavaggi, 12, scala H - 95123 Catania
Tel./Fax 095/430750
http://www.edprisma.com
[email protected]
ISBN 978-88-86808-32-3
Tutti i diritti di riproduzione sono riservati. Sono vietate la conservazione in
sistemi reperimento dati e la riproduzione o la trasmissione, anche parziali, in
qualsiasi forma e mezzo (elettronico, meccanico, incluse fotocopie e registrazioni)
senza il consenso scritto dell’editore.
INDICE
Prefazione pag. 1
Introduzione » 3
PARTE PRIMA
I SEGNI
CAPITOLO PRIMO. La provincia Africa Procon-
sularis e gli Emporio, in età imperiale < » 19
1. La regio tripolitana: cenni di geografia regio-
nale e condizioni climatiche » 19
2. Tratti distintivi dei primi insediamenti costieri:
le origini fenicio-puniche e la sudditanza
cartaginese » 28
3. Tardo ellenismo e ingerenza numida: l'Africa
di Massinissa » 37
4. La formazione della provincia Africa Vrocon-
sularis e gli Emporia: caratteri di un rap-
porto di privilegio » 48
5. Città liberae et immunes » 58
6. Aspetti di storia giuridico-istituzionale: assi-
milazione e 'provincializzazione' » 62
7. La I fase 'neo-punica' » 79
8. La II fase della 'provincializzazione': il pro-
console eja città » 84
8a. Adsimulatio-interpretatio: il forum vetus » 89
8b. Verso la civitas. Lep titani e cives » 108
9. La III fase: Vadlectio senatus » 115
VII
CAPITOLO SECONDO. L'entroterra: le strutture
economiche e i sistemi produttivi pag. 123
1. Gli èthne dell'entroterra: alcuni aspetti lin-
guistici e culturali » 124
2. Nomadi e sedentari nel pre-deserto tripolitano:
organizzazioni sociali ed economia » 133
3. Le forme della produzione: le strutture della
proprietà agraria » 147
4. Coloni, conductores, procuratores: la proprietà
imperiale e la produttività economica » 162
5. I volti del fiscus » 183
6. Settimio Severo e il controllo del territorio » 197
CAPITOLO TERZO. Potere e territorio » 209
1. I fines d'Africa: evoluzione e struttura della
frontiera » 212
Y
2. Tribù semi-nomadi e terre del demanio tra
l'Alto Impero e la Tarda Antichità: il limes
severiano » 235
3. Divide et impera: la creazione della provincia
Numidia » 259
4. Cartagine, Utica, Leptis Magna e lo ius italicum » 267
PARTE SECONDA
LE IMMAGINI
CAPITOLO QUARTO. Immagini e simboli del potere 283
1. I temi del consensus: Virtus, Fax, Felicitas nel-
l'arco di Marco Aurelio e Lucio Vero ad Oea » 288
2a. Felicitas temporum in communi patria: il tem-
pio al genio della colonia » 301
2b. Consecratio: legittimazione dinastica e tra-
smissione del potere nel santuario ed. 'di
Èrcole' a Sabratha » 309
Vili
3. I Severi e i temi del consensus: motivi politici
e mediazione in immagini pag. 323
4. I Severi e i temi del consensus: favoritismo
dinastico o sviluppo reale? » 329
5. Forum Novum Severianum: il complesso
basilica - portico - tempio » 341
6a. Il problema della destinazione cultuale » 366
6b. Cognata numina divinae domus » 371
7a. Arte della persuasione: uso e manipolazione
del mito classico » 377
7b. Nemesi e gli dii patrii: armonia solare, pace e
benessere al mondo » 394
8. Visioni di sintesi: i rilievi dell'arco tetrapilo » 404
Appendice » 433
Le fonti numismatiche » 433
Conclusioni » 449
Indici
Indice degli autori antichi » 463
Indice delle iscrizioni » 466
Indice dei nomi e delle cose notevoli » 469
Indice dei luoghi __ » 475
Indice delle figure » 481
Bibliografia » 485
IX
PREFAZIONE
In un momento critico e difficile per la ricerca scientifica
italiana nel suo complesso, considero la pubblicazione di
questo libro frutto di fortuna e di un sostanziale privilegio.
Ho contratto numerosi debiti. In primo luogo nei confronti
di Mario Mazza, che ha rappresentato un punto di riferimen-
to professionale ed umano per la sua concezione dei saperi
trasmessi attraverso una dedizione profonda per la ricerca,
che spero di avere assimilato almeno in minima parte.
Durante proficue e stimolanti conversazioni, tenute in più di
un’occasione, ho potuto contare sui preziosi suggerimenti di
Andrea Giardina, sempre disponibile e rassicurante. Ho rice-
vuto ugualmente sostegno e consiglio affettuoso da Cettina
Molè Ventura e da Patrizio Pensabene. Nino Di Vita, mae-
stro acuto ed appassionato, mi ha iniziata alla conoscenza del
territorio libico, ma ho potuto valermi anche dell’esperienza
di Enrica Fiandra che mi ha coinvolta nella missione di Lep-
tis Magna. Grazie alla cortesia dimostratami dalle rispettive
Direzioni, ho usufruito di un accesso – di fatto illimitato – ad
istituti culturali prestigiosi come l’École Française e il Deut-
sches Archaeologisches Institut di Roma. Il personale di
entrambe le biblioteche nei miei riguardi ha usato sempre la
massima gentilezza e disponibilità, instaurando un clima ami-
chevole in numerosi casi al di là dei formalismi e, quindi, per
me incomparabilmente sereno. I debiti che ho contratto tut-
tavia, sono ben maggiori e si estendono anche nei confronti
di altri, senza il cui aiuto questo libro non sarebbe stato rea-
lizzato: il mio più sincero ringraziamento è diretto alla signo-
ra Paola Frattarelli Mazza, per la sua pazienza e disponibilità
senza limiti; a Marco Galli, a Laura Mecella, ad Adolfo La
Rocca, amici preziosi, oltre che attenti revisori di bozze. Il
signor Franceso D’Abronzo mi ha resa partecipe della sua
1
notevole competenza professionale di disegnatore, scrupoloso
e sensibile nell’era virtuale dei computer – che non vuole
usare, mantenendo un contatto reale e diretto con quanto
per lui è frutto di passione.
2
INTRODUZIONE
Plutarco di Cheronea, intellettuale e storico, rifletteva sull’ar-
te e di arte si intendeva. In un suo scritto, La Gloria degli
Ateniesi, giunto sino a noi nel corpus dei Moralia, l’arte di quel
popolo era per lui oggetto di meditazione critica, intesa nel suo
significato più ampio e nella sua più ampia applicazione: non solo
poetica e figurativa, ma anche – nelle ascendenze dell’insegna-
mento aristotelico – quale arte politica del governo e del coman-
do. È cosa abbastanza nota e universalmente accettata che la pit-
tura, la scultura e le arti figurative in genere, come anche la
poesia e il teatro, assolvevano un ruolo per certi versi analogo a
quello delle moderne televisioni, dei nostri quotidiani e della
‘Rete’ per eccellenza, Internet: contribuivano a diffondere idee ed
opinioni. Poesia e pittura per uno storico dell’età antonina erano
fortemente accomunate nel loro valore di comunicazione artisti-
ca, calate nel sociale. Nella cultura greco-romana non esistevano
storia ed arte senza società e l’agire sociale era oggetto e strumen-
to dell’arte attraverso la riflessione nella storia. Plutarco così rife-
risce di Simonide, uno dei poeti più famosi ed amati nel mondo
ellenico: «È pur vero che Simonide definisce la pittura poesia
muta e la poesia pittura parlante: infatti quelle azioni che i pittori
rappresentano come se stessero avvenendo, i racconti le espongo-
no e descrivono come già avvenute. Se però i medesimi soggetti i
pittori li rappresentano con i colori e con il disegno mentre gli
scrittori li espongono con i nomi e con le parole, essi differiscono
nel materiale e nella tecnica dell’imitazione, ma entrambi si pro-
pongono un unico fine, e lo storico più valente è colui che fa la
sua narrazione descrivendo i sentimenti e delineando il carattere
dei personaggi come se si trattasse di una pittura»1.
1 Plut. Moralia, 346, 3; 347, 1: Plh;n oJ Simwnivdh" th;n me;n zwgrafivan
poivhsin siwpw`san prosagoreuvei, th;n de; poivhsin zwgrafivan lalou`san. a}"
3
È difficile resistere al fascino di questa prosa. Al di là delle
peculiarità nelle riflessioni plutarchee sulla validità del genere
storiografico delle biografie, che come è noto ebbero in lui
uno dei massimi esponenti dell’antichità, appare assai stimo-
lante il binomio storia-arti figurative. Tale accostamento in
Plutarco sembra tracciare la via che fino a noi ha determinato
una scelta di metodo. Si tratta di un percorso lungo e fervido
di dibattito, in cui basilari sono state le riflessioni prodotte
dalla critica storica e storico-artistica fiorita tra l’Otto e il
Novecento. Impossibile prescindere da quei fondamentali
insegnamenti-guida.
A memoria di Aby Warburg, la comprensione di una situa-
zione storica può essere impostata in base ad un’analisi com-
parativa tra fonti figurative e documentarie, accostandosi ad
un problema storico con gli strumenti offerti dalla storia del-
l’arte e, tuttavia, senza privilegiarne in modo preponderante
l’analisi iconografica2. Nel campo degli studi sull’antichità
classica, sulla base di tale prospettiva, fu merito di Otto Bren-
del aver delineato la necessità metodologica di un coordinamen-
to sostanziale tra i dati storici e quelli più prettamente archeolo-
gici, giungendo ad estrapolare di volta in volta le singole
componenti che condizionarono e sfociarono in determinate
produzioni artistiche3. Una conferma in tal senso si riscontrava
ga;r oiJ zwgravfoi pravxei" wJ" gignomevna" deiknuvousi, tauvta" oiJ lovgoi
gegenhmevna" dihgou`ntai kai; suggravfousin. eij d’oij me;n crwvmasi kai; schv-
masin, oiJ d’ojnovmasi kai; levxesi taujta; dhlou`sin, u{lh/ kai; trovpoi" mimhvsew"
diafevrousi, tevlo" d∆ajmfotevroi" e}n uJpovkeitai, kai; tw`n iJstorikw`n kravti-
sto" oJ th;n dihvghsin w{sper grafh;n pavqesi kai; proswvpoi" eijdwlopoihvsa".
(T.d.A.)
2Su Aby Warburg deve essere segnalata la singolare biografia, in tradu-
zione italiana, redatta dal suo allievo E.H. Gombrich, Aby Warburg. Una
biografia intellettuale, Bologna 2004 (rist.). Una panoramica generale relativa
alla storia della critica d’arte è stata condotta da C. Ginzburg, Da A. War-
burg a E.H. Gombrich. Note su un problema di metodo, in Id., Miti emblemi e
spie. Morfologia e Storia, Torino 1992, part. 29-106, a cui si rimanda per una
più dettagliata bibliografia in margine.
3Oltrepassando i principi del classicismo panellenico, permeati da pre-
giudizi di stampo nazionalistico, Otto Brendel trasformava e sovvertiva il
significato di un’essenza artistica della ‘romanità’. Scopriva, per esempio, il
valore di interazione nella polisemia delle culture locali in rapporto con il
potere ufficiale dominante: si vd. O. Brendel, Prolegomena allo studio del-
4