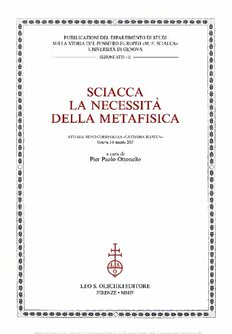Table Of ContentPUBBLICAZIONIDELDIPARTIMENTODISTUDI
SULLASTORIADELPENSIEROEUROPEO«M.F.SCIACCA»
UNIVERSITAÁ DIGENOVA
SEZIONEATTI-11
SCIACCA
Á
LA NECESSITA
DELLA METAFISICA
ATTIDELNONOCORSODELLA«CATTEDRASCIACCA»
Genova5-6maggio2003
a cura di
Pier Paolo Ottonello
LEOS.OLSCHKIEDITORE
FIRENZE.MMIV
ISBN 8822253523
INDICE
. . . . . . .
I. PIERP AOLOO TTONELLAOpe,r tura del Corso Pag. 7
La
11. VITTORIOST ELLA, necessità di una coscienza metafisi-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ca in Gentile e in Sciacca >> 9
111. ANTIMON EGRI,S ciacca: una metafisica senza nichilismo . >> 37
Iv.
PAOLOPA GANMI,e tafisica e antropologia in Sciacca e in
................................
Rosmini >> 41
V. MARIAL UISAF ACCOL’,o scuramento dell’intelligenza me-
tafisica nella diagnosi di Sciacca . . . . . . . . . . . . . . . . >> 83
VI. ALESSANDRMA ODUGNOF,i losofia e metafisica secondo
.................................
Sciacca >> 97
VII. CARLO LUPI, Metafisiche non meazioniste e metafisica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
creazionista >> 109
VIII. CARLOL UPI,P resentazione del volume di Roberto Rossi
<<MariaA delaide Raschini. L’intelligenza della carità. Lo
. . . .
spirito della filosofia di Rosmini dopo Nietzsche,, >> 115
Ix. . . . . . . . . .
ROBERTOR OSSI,L ’intelligenza della carità >> 117
- 5 -
I
PIERPAOLOOTTONELLO
UniversitaÁ diGenova
APERTURA DEL CORSO
Anche a nome del Magnifico Rettore, apriamo il IX Corso della «Cat-
tedraSciacca»,esprimendolanostrariconoscenzaatutticolorochehanno
contribuito a realizzarla, e, in particolare, fra i presenti, agli ospiti che ge-
nerosamentehannoaderitoall'invitodelDipartimentointitolatoaSciacca.
NonabbiamomaiamatoquellecheungrandeAmicochiama,conspi-
rito sapiente, «societaÁ di mutua ammirazione»: e certo non cominceremo
ora ad auspicarne, o a incignarne. Ma eÁ giusto ricordare anzitutto che la
«Cattedra Sciacca» eÁ oggi, nel mondo, una delle pochissime iniziative del
generecheancorasiavitale,rinnovandoun'altissimatradizionedellacultu-
ra europea. E inoltre che, in rapporto a Sciacca, il maestro comune, il no-
stroDipartimento,neldecenniocheorasicompiedellasuavita,fral'altro
hapubblicatosulsuopensierodiciassette degli oltre sessantavolumiusciti
per le sue cure.
Se guardiamo alla situazione odierna del nostro Ateneo siamo forse
tentati di prevedere che questa «Cattedra Sciacca» possa essere l'ultima
promossa al suo interno. Non sarebbe la prima volta nella quale ci trove-
remmo a dover attraversare pesanti difficoltaÁ. Sono piuÁ che mai certo
che ± quali che potranno essere le difficoltaÁ: ad ogni giorno la sua pena,
dunque la gioia del portarla ± il nucleo della Scuola di Sciacca continueraÁ
ad essere attivo, tanto sul piano pubblico quanto su quello privato: facen-
doci attivi come se tutto dipendesse da noi, insieme perseverando nell'af-
fidarci alla Provvidenza come se tutto dalla Provvidenza dipendesse.
Una sola parola riguardo alla Scuola di Sciacca. Gli oltre sessant'anni
delsuosussisterehannodimostratonelmodopiuÁ persuasivoquantoSciac-
ca stesso ha sempre sostenuto: essa eÁ costituita da coloro che, fattisi suoi
Ð 7 Ð
PIERPAOLOOTTONELLO
«ascoltatori» o «lettori», attraverso una sua lezione, o una conferenza, o
uno scritto, hanno risvegliato e rifecondato in se stessi il proprio pensare.
EdeÁ unfattochelaquasitotalitaÁ dicostoro,inquestiventott'annidallasua
morte,sieÁ ritrovatanelnucleodiGenova:enelsuoambitoeÁ statapubbli-
cata la quasi totalitaÁ degli oltre cinquanta volumi sul suo pensiero usciti in
taleperiodo.IlchehafattosõÁche,sostanzialmenteintornoalnucleodiGe-
nova, sia cresciuta la bibliografia sciacchiana, che, con i suoi quasi seimila
titoli,eÁ oggilapiuÁ cospicuanell'ambitodellafilosofiaitalianadelNovecen-
to.Unfiloaureo,alimentatoanche,sulpianoprivato,dalperiodico«Studi
Sciacchiani», oggi alla sua diciannovesima annata: mentre sono presto
scomparsi i periodici di polso dedicati, ad esempio, a Gentile o al Croce;
e mentre si contano sulle dita di una sola mano le riviste che nel mondo
siano dedicate per intero a singoli pensatori del Novecento.
Che tutto questo sia mal accetto e peggio digerito dai piuÁ la considero
controprova dell'odierno stato palustre della residua filosofia in Italia: per
giunta senza prospettive ne di palafitte ne di futuribili depositi petroliferi.
Esempio eloquente, fra i molti, la paginetta dedicata a Sciacca delle quasi
ottocentodelsettimotomo,appenaristampato,dell'``aggiornatissima''Sto-
ria della filosofia dell'Abbagnano: dove non si cita nessuno dei suoi cin-
quantavolumi,e,incompensoliquidatorio,losi«elogia»come«unodegli
autori piuÁ prolifici del periodo».1
Nontoccaameentraredirettamenteneltema«inattualissimo»cheab-
biamosceltoperquestaCattedra:la«necessitaÁ dellametafisica».DiroÁ solo
che, a rileggere di Sciacca l'articolo del '39 sulla NecessitaÁdi una coscienza
metafisica, nonche l'articolo di apertura del suo «Giornale di Metafisica»,
del'46±dunqueall'inizioeallafinedellasecondaguerramondiale±misi
confermanelmodopiuÁ nettoepersuasivochevieÁ segnatoilperimetroteo-
retico non solo dell'intero percorso di Sciacca, ma anche ±sebbene preva-
lentemente in negativo ± del pensiero novecentesco nel suo complesso e
nella sua articolazione. Ne dobbiamo certo illuderci che il secolo, anzi il
millennio``nuovo'',inquantotaleportinovitaÁ,enovitaÁ positive:noncidi-
mentichiamo degli ``almanacchi'' del Leopardi.
1 Rinvio in proposito alla mia nota Sciacca ``glissato'', «Studi Sciacchiani», Genova, XIX,
2003,n.1-2,pp.123-125.
Ð 8 Ð
II
VITTORIOSTELLA
UniversitaÁ diRoma
Á
LA NECESSITA DI UNA COSCIENZA METAFISICA
IN GENTILE E IN SCIACCA*
Dire della coscienza metafisica in Gentile e in Sciacca non eÁ tema che
possa ricevere adeguatosviluppoda poche pagine: al piuÁ si puoÁ cercare di
circoscriverne il rapporto. Il pensiero di Gentile eÁ particolarmente com-
plesso: non si riduce ± eÁ ovvio ± alla formula di `filosofia dell'atto in atto',
comepresuntodaqualcheinterpretesprovvedutooironico,ancheseeÁ del
tuttoverochefulcrodelsuosistemaeÁ laconcezionedell'atto;cosõÁcomela
filosofia crociana non eÁ la danza delle quattro parole ± quale purtroppo
*ABBREVIAZIONI:
OperediGiovanniGentilecitate:
SP =Sommariodipedagogiacomescienzafilosofica(1912)IPedagogiagenerale;IIDidattica,
Firenze,Sansoni,19425;
RH =Lariformadelladialetticahegeliana(1913),Firenze,Sansoni,19543;
FD = I fondamenti della filosofia del diritto (1916) con aggiunti due studi sulla Filosofia di
Marx(1899),Firenze,Sansoni,19373;
TG =Teoriageneraledellospiritocomeattopuro(1917),Firenze,Sansoni,19446;
SL =SistemadilogicacometeoriadelconoscereIIntroduzioneeLogicadell'astratto(1917);II
Lalogicadelconcreto(1921),Firenze,Sansoni,19423;
FA =Lafilosofiadell'arte(1930),Firenze,Sansoni,19502;
IF =Introduzioneallafilosofia(1933),Firenze,Sansoni,19522;
GS =GenesiestrutturadellasocietaÁ.Saggiodifilosofiapratica(1943),Firenze,Sansoni,1946.
OperediMicheleFedericoSciaccacitate:
DASC =Dall'attualismoallospiritualismocritico(1931-1938),Milano,Marzorati,1961;
FO =Lafilosofia,oggi(1945),2voll.,Milano,Marzorati,19625;
FP =Figureeproblemidelpensierocontemporaneo(1952-1973),Milano,Marzorati,1973;
FM =Filosofiaemetafisica,2voll.(1947-1949),Milano,Marzorati,19623;
GC =«Giornalecriticodellafilosofiaitaliana»,fondatodaGiovanniGentilenel1919(Iserie
1919-1932;IIserie1933-1945;IIIseriedal1947).
Ð 9 Ð
VITTORIOSTELLA
venneirrisa,auncertopunto,dallostessoGentile±ancheselacircolaritaÁ
dellospiritosireggesulquaternariodistinguersiinpassaggiodialetticodel-
le categorie o forme. L'aspra verticalitaÁ di Gentile si avverte giaÁ nello stile,
soprattuttonelle articolazionidove ildisegnostrutturale emerge daunles-
sico preciso e gravido di un significato spesso decisamente innovativo e
proprio per questo nello stesso tempo radicato nella storia. EÁ infatti uno
stilerobustoedefficace,determinatodall'attritofrapronuncieintenzionali
opposte e dall'esigenza, ora di confermarle incompossibili, ora di ricom-
porle su un livello ulteriore; un'esigenza rispecchiata dalla densitaÁ dei rac-
cordi come dalla reiterazione verbale per rafforzamento o per chiarimento
didascalico. Le frange retorico-oratorie tardo-ottocentesche si lasciano
espungereacolpod'occhiodaunaletturaodiernacomeadditividisturban-
ti e superflui. L'asciuttezza di Sciacca eÁ fatta di un rapido seguirsi di scatti
nella mira diritta al nucleo dei problemi e anch'essa si serve della efficace
energia comunicativa dell'iterazione. Di questo carattere della scrittura in
entrambi alterna d'irruenza e di riposata esposizione, e tantopiuÁ impressi-
va inquantodistante dal consuetolinguaggioaccademico, esangue e palu-
datoquandononcompassatooturgido,Sciaccaeraconsapevolese,quando
rilevava il vigoroso temperamento di Gentile, unendo la percezione della
personalitaÁ teoreticaaisuoiriflessipsicologici,edavarisaltoalcordialeca-
lore e all'impeto, fossero poi o no dovuti ± come credeva ± alla comune
sicilianitaÁ, in colui che egli sentõÁ inizialmente come maestro e in lui stesso.
Vienfattodiritenerechequesta`virtuÁ'espansiva,perquantodissimile,
siastatadavveroiltramitedellalorooriginariaereciprocasimpatia,mentre
la vicinanza non eÁ stata durevole sul piano speculativo. In Sciacca un non
trascurabileelementodifferenziatoriopuoÁ farsirisalireall'accentuarsidiun
diversohintergrundsiaduranteilcorsodilaurea,siadopolasineresi,nella
sedimentazione formativa di secondostrato. Laddove inGentile la cultura
filosoficarisentiva,sõÁ,dellostudiogiovanilediRosminiediGioberti,masi
confermavafondamentalmente idealistica,hegeliano-immanentisticaanche
attraverso la lezione di grandi personalitaÁ del passato a partire dai prepla-
tonici senza turbare l'istanza progettuale del rinnovamentoanzi essendone
impulso, in Sciacca l'appassionamento conoscitivo per l'antico eÁ connatu-
rato e orientante muovendo da Platone alla tradizione cristiano-cattolica
deltrascendentismointerioristicodiS.Agostinodalqualel'orizzontediri-
ferimento si estende fino all'onnipresente Rosmini e ai contemporanei spi-
ritualisti francesi e ispanici.
LacomplessitaÁ diGentilederivadallaradicaleaudaciadeisuoinessiar-
gomentativi,inunaconsecutioilcuirigorenonfaconcessioni.Qui,inrela-
zione a un tema che, a svolgerlo nella sua interezza, investirebbe tutte le
Ð 10 Ð
LANECESSITAÁ DIUNACOSCIENZAMETAFISICA
operepropriamentespeculativedeiduefilosofi,sitracceraÁ unexcursussche-
maticodall'esordiosciacchianoaFilosofiaemetafisica,premessononesser
dubbio che la coscienza metafisica pervade il pensiero dell'uno non meno
chedell'altro,siachenerappresentiilfulcro,comeinSciacca,siachevenga
retrocessaalpassatodacuicisieÁ liberati,anzidacuiperennementel'auto-
coscienza ci libera nell'attualitaÁ della sintesi come impone il pensiero di
Gentile.L'attualismoeÁ bendiversodaun'antimetafisicainconsapevoledella
enormeincidenzachelametafisicahaavutonellastoriadellaspeculazionee
ha in cioÁ che attualisticamente si denomina logica dell'astratto. In tutto il
suosviluppoessoeÁ protesoallafondazioneteoreticadelvaloredelrealepo-
nendoloinunprincipiotrascendentaleperennementeautocreativolacuiat-
tivitaÁ sidispiegaeconcretanelrenderepossibilel'esperienza.CioÁ nonvuol
direempiricamenteconstatarlaeanalizzarla,bensõÁporla,farlavenireines-
sere, produrla, per l'appunto crearla. Si afferma dunque filosofia trascen-
dentalistica,inun'autodefinizionegeneralmentericonosciutaesattanonsol-
tanto da seguaci e affini, ma anche da quanti hanno percorso vie diverse e
professatoconvinzioniopposte. Queste ±nonoccorre dirlo±oggi sonodi
granlungalepiuÁ battute,senzachetaledisattenzioneoincapacitaÁ ermeneu-
ticaimplichiunrealesbiadimentodicioÁ cuinonsiprestaascolto,seeÁ vero
che lapresenzaeffettualedeiclassici±efra iclassiciGentilecertamente si
annovera ± non patisce scomparsa.
Si tratta di una concezione che si costruisce sulla coscienza ± egli scri-
ve ± dell'unitaÁ «giacente in fondo alla molteplicitaÁ dell'esperienza», unitaÁ
che non esita a definire «coscienza metafisica» quale posizione (oggettiva-
zione)dellarealtaÁ dapartedelsoggettopensante.EnonpernullaeÁ Sciacca
a ricordare che, nella sua Riforma della dialettica hegeliana, Gentile aveva
rilevatoesserci«unmomentoimmancabilenellosviluppoidealedellospiri-
toumano,chepotrebbedirsiilprincipioeternodellafilosofia:quelmomen-
toincuiilcontrastodellamorteconlavita,ladifferenzatrailnonesseree
l'essere, spinge l'uomo a proporsi il problema: Che eÁ l'essere?» (RH, 110).
CioÁ noncomporta±sivedraÁ ±cheeglisiaunsostenitoredellafilosofia
comemetafisicanelsensodifarneilcardinequalificatoredelsuopensiero.
Madellaimportanzacheilproblemametafisicocomeproblemadell'essere
ha nella sua riflessione di contro all'approfondita propria concezione del
divenire,laproposizionecitatanonconsentedubitare.GiaÁ nellaidentifica-
zionedialettical'esigenzastorico-filosoficaeÁ intrinsecamentepresenzaspe-
culativa,inquantoattendeallosvolgimentodellecorrenticonoscitivecome
espressionedellavolontaÁ dellamentedifarchiarezzainseÂ.CosõÁnonomet-
te di riandare, nella Teoria generale dello spirito come atto puro, al remoto
passato della metafisica ± passato solo cronologicamente remoto, poicheÂ
Ð 11 Ð
VITTORIOSTELLA
niente lo eÁ nel presente della coscienza in cui vive la perenne dialettica di
pensante e pensato. Metafisica eÁ «l'acqua di Talete, in quanto ha in se la
possibilitaÁ di tutte le forme [...] offerte dalla natura all'osservazione sensi-
bile»;l'esserediParmenidecomequellaunitaÁ «allaqualeilpensieroriduce
tutte le cose», l'idea di Platone «in quanto aduna in se l'essere disperso e
fluente in molti e fuggevoli aspetti dello spazio e del tempo» (TG, 151).
L'istanzaopposta all'unitaÁ ±e implicitamente,se nonsempre, oppostaalla
metafisica comunque propria del tendere all'unitaÁ del principio, ma, in
quanto `naturalistica', metafisica anch'essa ± ha il suo sostegno primario
nell'empirismo,prospezionetantopiuÁ resistenteinquantolesueirradiazio-
ni, pur fra diloroquantomai disparate,si orientano tutte «versola molte-
plicitaÁ» (TG, 151).
La posizione dualistica viene definita mediante l'esame del rapporto
identitario di causa-effetto che non eÁ invalidato dalle verifiche dell'espe-
rienza,ossiailloroprocedereperconstatazioneecomparazioninonrisulta
leso dall'unitaÁ immanente che eÁ sintesi, unitaÁ dialettica. La connessione di
causa-effetto±sisa±eÁ stataperlungotempolabasedidibattititeorici,sia
filosoficisiaspecificamentescientifici.Perrimuoverel'ostacolochesifrap-
poneallatesidel«puntodivistametafisico»dell'unitaÁ,occorreconcepireil
rapporto stesso necessario nel pensiero in forza di «una unitaÁ che stia alla
basedeiduetermini».PensarlicomecostitutividiunitaÁ comportapensarli
istituentisi in relazione assoluta. Non sarebbe relazione assoluta se non
avesse il carattere della unificazione, della reductio ad unum non come re-
cezione di una astratta `datitaÁ', ma come genesi veritativa concretamente
agente. «Chi dice relazione, dice differenza, ma dice anche identitaÁ di ter-
mini. Due termini differenti si penserebbero in modo che pensando l'uno,
si penserebbe l'altro» (TG, 88-89), mentre l'enunciazione di un che, che
qualifichiamo causa, nell'atto stesso di pensarlo diviene una cosa sola
conl'effetto,nonpiuÁ `altro',delquale,senonfossecosõÁ,quelquidnonpo-
trebbe esser ritenuto causante. Quindi cioÁ che il pensiero richiede eÁ che
essi±causaedeffetto±costituiscanounplessoindisgiungibile,annullatore
della dualitaÁ. Supporre la relazione come assertiva di una sussistente alte-
ritaÁ esterna varrebbe negarne l'assolutezza. La «pura differenza puoÁ inten-
dersi soltanto tra due termini irrelativi. Per quanto diversi, questi termini
della relazione son tuttavia tali che, pensando l'uno, si pensa l'altro, e il
concetto dell'uno contiene pure in qualche modo l'altro» (TG, 89).
L'assunzionedell'unocomesoggetto(ponente)senzailqualenonsidaÁ
relazioneall'altro(l'oggettoposto),implicaperl'appuntolacondizionedel
porre.L'unitaÁ consisteintaleattivitaÁ condizionante,inquestomovimento,
inquestoprocessod'immedesimazionedialettica.Ilrapportodicondizione
Ð 12 Ð