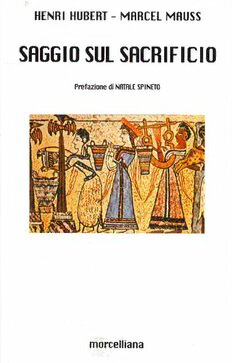Table Of ContentHENRI HUBERT -MARCELMAUSS
SAGGIO SUL SACRIFICIO
Prefazi.oneall'edizioneitalianadi.NATAl.ESPINETO
Nellastessacollaua:
CiprianiR. (acuradi),Lalegittimazionesimbolica,.pp.248
EliadeM..,.Lanascitamistica.Ritiesimbolid'iniziazione,3 ed.,pp.224
EliadeM..,.LanostalgiadeUeorigini.. Storia esignificatonel/areligione, 2ed.,
pp.214
Fib:}fluIJ.oG.,Figure delsacro. Saggidi storiareligiosa,PP'.368
Frank-lV.E.,Dio ndl'inconscio. Psicoterapiae religione, 4ed., pp. 180
!Frank.1V.E.,Logoterapiaean.alisiesistenziale,5'ed.,pp.288
!Frank.1v.E., Teoria etempia dellenevrosi,3ed..,pp.224
MomiiglianoA.,. Saggi di storia della religiOne roma.na. Studi e lezioni 1983-
1986,1'1'.206
RicoeurP:.,Tradizione oalternativa. Tresaggisuideologiaeutopia, pp. 156
Sh.ilsE.,Centroeperiferia. Elementidimacrosodologia,pp. 200
TerrinAN..,Ilrito.Antropologiaefenomenologia dellaritualità,pp.. 448
TemnAN.,«Leitourgia».Dimensionefenomenologicaeaspettisemiotici,pp.262
TerrinAN., Mistiche dell'Occidente. NewAge~ Orientalismo, Mondo Pente-
costale, pp. 288
TerrinAN..,Nuovereligioni.AUaricercadella terrapromessa,2ed., pp.184
TurneI"V.,Laforesta deisimboli.AspettidelritualeNdembu, 3ed., pp.488
TurneI"V.,Ilprocessorituale.. Struttura eantistruttura,.2ed., pp. 240
ZadlraD..,Iltemposimbolico: la liturgia della vita, pp. 140 MORCELLIANA
HENRI HUBERT -MARCELMAUSS
SAGGIO SUL SACRIFICIO
Prefazi.oneall'edizioneitalianadi.NATAl.ESPINETO
Nellastessacollaua:
CiprianiR. (acuradi),Lalegittimazionesimbolica,.pp.248
EliadeM..,.Lanascitamistica.Ritiesimbolid'iniziazione,3 ed.,pp.224
EliadeM..,.LanostalgiadeUeorigini.. Storia esignificatonel/areligione, 2ed.,
pp.214
Fib:}fluIJ.oG.,Figure delsacro. Saggidi storiareligiosa,PP'.368
Frank-lV.E.,Dio ndl'inconscio. Psicoterapiae religione, 4ed., pp. 180
!Frank.1V.E.,Logoterapiaean.alisiesistenziale,5'ed.,pp.288
!Frank.1v.E., Teoria etempia dellenevrosi,3ed..,pp.224
MomiiglianoA.,. Saggi di storia della religiOne roma.na. Studi e lezioni 1983-
1986,1'1'.206
RicoeurP:.,Tradizione oalternativa. Tresaggisuideologiaeutopia, pp. 156
Sh.ilsE.,Centroeperiferia. Elementidimacrosodologia,pp. 200
TerrinAN..,Ilrito.Antropologiaefenomenologia dellaritualità,pp.. 448
TemnAN.,«Leitourgia».Dimensionefenomenologicaeaspettisemiotici,pp.262
TerrinAN., Mistiche dell'Occidente. NewAge~ Orientalismo, Mondo Pente-
costale, pp. 288
TerrinAN..,Nuovereligioni.AUaricercadella terrapromessa,2ed., pp.184
TurneI"V.,Laforesta deisimboli.AspettidelritualeNdembu, 3ed., pp.488
TurneI"V.,Ilprocessorituale.. Struttura eantistruttura,.2ed., pp. 240
ZadlraD..,Iltemposimbolico: la liturgia della vita, pp. 140 MORCELLIANA
Titolooriginaledell'opera:
Essaisurlanatureetlafonctiondusacrifice
«L'AIIlIléesociologique» 1898(pp.29-138)
©EditrieeMorceHiana
ViaG.Rosa71··25121Brescia
PREFAZIONEALL'EDIZIONEITALIANA
TraduzionediVEI.LEDAMENEGHEITIMINELU
Il Saggio sulla natura e la junzio";e del sacrificio fu pubblicato
Primaedizione: 1981 neUa seconda annata della rivista «Année sociologique» (1897-1898),
Secondaedizione:2002 uscita a Parigi nel 1899 per I tipi di Félix Alcan. In quel perIodo la
«Scuola sodologica francese»· andava forrmandosIgrrazie all'attività
scientificaeorgani.zzativadiÉmileDurkheim,cheavevaraccolto intor
no a sé alcuni giovani ricercatori interessati all'appmfondimento deUe
tematichesodaii. L'«Annéesociologique» era1'«organo»del gmppo: i
suoi collaboratori, con formazioni e seUori dispecializzazione diversi,
condividevàno icapìisaIdidel metodo durkheimiano, che applicavano e
v,erificavano nei loro rispettiviambitidi comp,etenza. Traloro spiccava
lafiguradiMarcelMauss(1872-1950),nipotedi Durkhteimesuoallie
vo alI'UniversitàdiBordeaux.. Maussunivaallapreparazionefilosofica
laconoscenzadellereligionidell'India,deII'ebraismoedeglistudietno
logici, ,che aveva perfezionato, oltre che aU'École Pratique dies Hautes
Études, consoggiorni in manda e in Inghìherra. Scriverànel 1930: «È
per gusto filosofico e cosciente destinazione che, su indicazione di
Durrkheim, mi specializzai nella conoscenza dei fatti religiosi, consa
www.moJrCelliana.eo,m crandomi ad essi quasi del tuttoe persempre».All'École aveva incon
trato, ne] 1896,HenrriHubert(1870-1927)che,diformaz10ne storica,.si
interessava principalmente delle lingue semitiche e deIIe religioni del
Vicino Oriente antico. All'interno della rivista fondata da Durkheim., i
dluesidedicavanoinmanieraparticolarealsettoredella«sociologiareH
giosa», dii cui Mauss era responsabile e, apartire dal 1900, correspon
sabile con Hubert. In attesa di un posto di insegnante (che arrivò nel
ISBN88-372-1893-1 1901),Mauss, dlopo aIcuniscrittidiminoreestensione,diede allestam·
Tipografia.CamunaS.p.A-FilialediBrescia,.ViaA.Soldini25 pe,. assieme a Hubert, la prima delle sue op,efe maggiori:. il Saggio.,.
Titolooriginaledell'opera:
Essaisurlanatureetlafonctiondusacrifice
«L'AIIlIléesociologique» 1898(pp.29-138)
©EditrieeMorceHiana
ViaG.Rosa71··25121Brescia
PREFAZIONEALL'EDIZIONEITALIANA
TraduzionediVEI.LEDAMENEGHEITIMINELU
Il Saggio sulla natura e la junzio";e del sacrificio fu pubblicato
Primaedizione: 1981 neUa seconda annata della rivista «Année sociologique» (1897-1898),
Secondaedizione:2002 uscita a Parigi nel 1899 per I tipi di Félix Alcan. In quel perIodo la
«Scuola sodologica francese»· andava forrmandosIgrrazie all'attività
scientificaeorgani.zzativadiÉmileDurkheim,cheavevaraccolto intor
no a sé alcuni giovani ricercatori interessati all'appmfondimento deUe
tematichesodaii. L'«Annéesociologique» era1'«organo»del gmppo: i
suoi collaboratori, con formazioni e seUori dispecializzazione diversi,
condividevàno icapìisaIdidel metodo durkheimiano, che applicavano e
v,erificavano nei loro rispettiviambitidi comp,etenza. Traloro spiccava
lafiguradiMarcelMauss(1872-1950),nipotedi Durkhteimesuoallie
vo alI'UniversitàdiBordeaux.. Maussunivaallapreparazionefilosofica
laconoscenzadellereligionidell'India,deII'ebraismoedeglistudietno
logici, ,che aveva perfezionato, oltre che aU'École Pratique dies Hautes
Études, consoggiorni in manda e in Inghìherra. Scriverànel 1930: «È
per gusto filosofico e cosciente destinazione che, su indicazione di
Durrkheim, mi specializzai nella conoscenza dei fatti religiosi, consa
www.moJrCelliana.eo,m crandomi ad essi quasi del tuttoe persempre».All'École aveva incon
trato, ne] 1896,HenrriHubert(1870-1927)che,diformaz10ne storica,.si
interessava principalmente delle lingue semitiche e deIIe religioni del
Vicino Oriente antico. All'interno della rivista fondata da Durkheim., i
dluesidedicavanoinmanieraparticolarealsettoredella«sociologiareH
giosa», dii cui Mauss era responsabile e, apartire dal 1900, correspon
sabile con Hubert. In attesa di un posto di insegnante (che arrivò nel
ISBN88-372-1893-1 1901),Mauss, dlopo aIcuniscrittidiminoreestensione,diede allestam·
Tipografia.CamunaS.p.A-FilialediBrescia,.ViaA.Soldini25 pe,. assieme a Hubert, la prima delle sue op,efe maggiori:. il Saggio.,.
8 Prefazione Prefazion.e '9
costruitofaticosamente, nonsenzamomentidi sconforto (come mostra strabile. Nel denunciare il problema teorico basilare delle concezioni
l'epistolario dei due autori),. nelcorsodel 1898. del sacrificio dei loro contemporanei, HuberI e Mauss mettevano così
Inseritonel programmaculturaledielaborazioneediffusione delle in lucela precarietà.di tuttalacostruzione intellettuale deHe pmspetti
idee sociologiche dell'«Année,), USaggio sottende le coordinate con ve evoluzioniste, in un periodo nel qjualeesse erano dominanti. Ci si
cetltuali fIssate dai lavori di Durkheim, il qualle, fielIo stesso numero può chIedere se, nella10mpmpostateorica- dovuta principalmente a
della rivista, insisteva sull'origine sociale deUa nozione di sacro. Mauss, cuI significativamente Hubert rimprovera, in una lettera, gli
HuberteMaussscrivonoche «lenozioni religiose, poichésonocredu eccessispeculativi- nonsI possaindividuareuna tracciadeglistudidI
te, sono; esse esistono oggettivamel1tecome fatti sociali».. La loro filosofia- di orientamento neokantiano- ,compiuti dal giovane :5ocio
caratteristicaè di avere achefare con unarealtà«sacra", che,sedaun logo a Bordeaux. D'altra parte, quanto innovativa fosse la critica dei
latorisultaseparata,edistantedalI'uomo, dall'altrositrova in rapporto due autorièmostratodalfattoche,moltiannidopoilSaggio,certevoci
conlui. Ora, «tale carattere di intimapenetrazIone edIseparazione, di del dibattito su] temasi inquadr,eranno ancora enl:roschemi analloghi a
Immanenz.a'editrascendenza, ,è,nel suo piùaltogrado, pecuHare deUe qjuelliche Hubert e Mauss avevano inteso superare: WìlhelmSchmidt,
cose sociati». Nel momento in cui decidono di sottoporre ad analisi il nellasua polemica'antI-evoluzionista, sioccuperàdelle civiltà «primi
temadelsacrificio, Idue autorientranotuttaviain unterrenochenonè tive» pIù antiche (secondo i criteri deUti scuola storico-culturale) per
più soltantosociologico, ma è oomune adiscipline come l',etnologiae rinvenire al loro Interno un tipo originario di sacrificio (che comporta
la storiadelle religioni. unomaggioprimiziale)ericonoscereneUealtreformedelritualealtret
Negli ultimianni l'Interesse perirituali sacrificatierastatointen tantisviluppIsecondaridi esso..
so 'e aveva dato luogo a uIli ampIo dibattito,. all'interno del quale si Respinta la prospettIva metodologica dell'indagine genetica ed
erano delineate alcune posizioni principati: Edward Burnett Tylor evolutiva, Hubert e Mauss procedono secondo una via differ,ente:
avevainterpretato ilsacrificiocomeundono,. ilcuiscopoeraquello di prendono le mosse da testi nei qjuali il sacrificio è documentato in
instaurare fra uomini ed esseri sovrumani un rapporto di «do ut des» manieraarticolataericcadiparticolari- quellivediciebiblici-ecer
che allontanass,e gli eventi negativi e favorisse queUi positivI. Più cano di definire i tratti generali dei riti sacrificali, per costruire un
recentemente,. William Robertson Smith, richiamandosi alle teorie del «sistema», uno «schema»,un «meccanismo» utile asist·emare e inter
totemismo,. av'eva proposto una concezione del sacrificio inteso come pretare ifatti religiosI che l'osservazIoneetnologica e l'Indagine sto
«comunione»: nellaprassisacrificale eracentral'e,perlui, laconsuma rica pongono in luce. In questo modo, applicano la comparazIone
zione comunitaria dI un animale sacro,. attraverso la quale si potesse che, secondo Durkheim,costituivailcaratterepeculiaredella «manie
conseguIr,euna assimilazIonedeimembridelgruppofra loro,econciò rasociologica» di studiare ifenomeni ~ in manieradIfferente rispetto
che la vIttima rappresentava. James Georges Frazer, infine, aveva al metodo comparativo proprio delle due tradizioni culturali dalle
costruito un modello di sacrificio che comportavala morte di un dio e quali si era svIluppata la storia deUe religioni: quella antropologica e
la sua rInascita.. È dal confronto con quesIe posizioni che emergono i quella mitologica che si richiamava a Max MilUer. La ricerca porta
tratti di originalità. dell'impostazione di Hubert ,e Mauss. Tylor,. alI'indIviduazionedel procedimento comune deisacrifici, che «consi
RobertsonSmithe Frazeraspirano atrovare, nellavarietàdeUeespres ste nello stabilire una comunicazione fra il mondo sacro e il mondo
sIoniculturali,unaforma unicaeprimadel sacrificio. Macomeconci~ profano mediantel'intermediario diunavittima, cioèuna cosaconsa
liare l'esistenza di un tipo orIginario di sacrificio (come il dono o la crata distrutta nel corso della oerimonia». La necessità den'interme
comunione) COn ladiversitàdi caratteristichepresentatadai ritualI che diario è legata alle caratteristiche deUe forze religIose, che sono vitali
ladocumentazIonestoricaedetnologicaciattesta?Latispostaconsiste ma neUo stesso tempo temibìli e l'importanza del sacrificio consiste
neldisporre idifferentigeneridisacrificioin1mordinecmnologiooed nella suafunzione sociale.
n
evolutivo. UnasuccessionelogicavieneCOSI presentatacomefosse un Iavomriscosseunbuonsuccesso,anchesul pianointernazionale,
divenire storico, che, sevagliato alla prova deifatti, risulta non dimo- fin danasuapubblicazione, masuscitòlemaggiorireazioni~apprezza-
8 Prefazione Prefazion.e '9
costruitofaticosamente, nonsenzamomentidi sconforto (come mostra strabile. Nel denunciare il problema teorico basilare delle concezioni
l'epistolario dei due autori),. nelcorsodel 1898. del sacrificio dei loro contemporanei, HuberI e Mauss mettevano così
Inseritonel programmaculturaledielaborazioneediffusione delle in lucela precarietà.di tuttalacostruzione intellettuale deHe pmspetti
idee sociologiche dell'«Année,), USaggio sottende le coordinate con ve evoluzioniste, in un periodo nel qjualeesse erano dominanti. Ci si
cetltuali fIssate dai lavori di Durkheim, il qualle, fielIo stesso numero può chIedere se, nella10mpmpostateorica- dovuta principalmente a
della rivista, insisteva sull'origine sociale deUa nozione di sacro. Mauss, cuI significativamente Hubert rimprovera, in una lettera, gli
HuberteMaussscrivonoche «lenozioni religiose, poichésonocredu eccessispeculativi- nonsI possaindividuareuna tracciadeglistudidI
te, sono; esse esistono oggettivamel1tecome fatti sociali».. La loro filosofia- di orientamento neokantiano- ,compiuti dal giovane :5ocio
caratteristicaè di avere achefare con unarealtà«sacra", che,sedaun logo a Bordeaux. D'altra parte, quanto innovativa fosse la critica dei
latorisultaseparata,edistantedalI'uomo, dall'altrositrova in rapporto due autorièmostratodalfattoche,moltiannidopoilSaggio,certevoci
conlui. Ora, «tale carattere di intimapenetrazIone edIseparazione, di del dibattito su] temasi inquadr,eranno ancora enl:roschemi analloghi a
Immanenz.a'editrascendenza, ,è,nel suo piùaltogrado, pecuHare deUe qjuelliche Hubert e Mauss avevano inteso superare: WìlhelmSchmidt,
cose sociati». Nel momento in cui decidono di sottoporre ad analisi il nellasua polemica'antI-evoluzionista, sioccuperàdelle civiltà «primi
temadelsacrificio, Idue autorientranotuttaviain unterrenochenonè tive» pIù antiche (secondo i criteri deUti scuola storico-culturale) per
più soltantosociologico, ma è oomune adiscipline come l',etnologiae rinvenire al loro Interno un tipo originario di sacrificio (che comporta
la storiadelle religioni. unomaggioprimiziale)ericonoscereneUealtreformedelritualealtret
Negli ultimianni l'Interesse perirituali sacrificatierastatointen tantisviluppIsecondaridi esso..
so 'e aveva dato luogo a uIli ampIo dibattito,. all'interno del quale si Respinta la prospettIva metodologica dell'indagine genetica ed
erano delineate alcune posizioni principati: Edward Burnett Tylor evolutiva, Hubert e Mauss procedono secondo una via differ,ente:
avevainterpretato ilsacrificiocomeundono,. ilcuiscopoeraquello di prendono le mosse da testi nei qjuali il sacrificio è documentato in
instaurare fra uomini ed esseri sovrumani un rapporto di «do ut des» manieraarticolataericcadiparticolari- quellivediciebiblici-ecer
che allontanass,e gli eventi negativi e favorisse queUi positivI. Più cano di definire i tratti generali dei riti sacrificali, per costruire un
recentemente,. William Robertson Smith, richiamandosi alle teorie del «sistema», uno «schema»,un «meccanismo» utile asist·emare e inter
totemismo,. av'eva proposto una concezione del sacrificio inteso come pretare ifatti religiosI che l'osservazIoneetnologica e l'Indagine sto
«comunione»: nellaprassisacrificale eracentral'e,perlui, laconsuma rica pongono in luce. In questo modo, applicano la comparazIone
zione comunitaria dI un animale sacro,. attraverso la quale si potesse che, secondo Durkheim,costituivailcaratterepeculiaredella «manie
conseguIr,euna assimilazIonedeimembridelgruppofra loro,econciò rasociologica» di studiare ifenomeni ~ in manieradIfferente rispetto
che la vIttima rappresentava. James Georges Frazer, infine, aveva al metodo comparativo proprio delle due tradizioni culturali dalle
costruito un modello di sacrificio che comportavala morte di un dio e quali si era svIluppata la storia deUe religioni: quella antropologica e
la sua rInascita.. È dal confronto con quesIe posizioni che emergono i quella mitologica che si richiamava a Max MilUer. La ricerca porta
tratti di originalità. dell'impostazione di Hubert ,e Mauss. Tylor,. alI'indIviduazionedel procedimento comune deisacrifici, che «consi
RobertsonSmithe Frazeraspirano atrovare, nellavarietàdeUeespres ste nello stabilire una comunicazione fra il mondo sacro e il mondo
sIoniculturali,unaforma unicaeprimadel sacrificio. Macomeconci~ profano mediantel'intermediario diunavittima, cioèuna cosaconsa
liare l'esistenza di un tipo orIginario di sacrificio (come il dono o la crata distrutta nel corso della oerimonia». La necessità den'interme
comunione) COn ladiversitàdi caratteristichepresentatadai ritualI che diario è legata alle caratteristiche deUe forze religIose, che sono vitali
ladocumentazIonestoricaedetnologicaciattesta?Latispostaconsiste ma neUo stesso tempo temibìli e l'importanza del sacrificio consiste
neldisporre idifferentigeneridisacrificioin1mordinecmnologiooed nella suafunzione sociale.
n
evolutivo. UnasuccessionelogicavieneCOSI presentatacomefosse un Iavomriscosseunbuonsuccesso,anchesul pianointernazionale,
divenire storico, che, sevagliato alla prova deifatti, risulta non dimo- fin danasuapubblicazione, masuscitòlemaggiorireazioni~apprezza-
lO Prefazione
menti e: critiche ~ dopo la riedizioIle avvenuta nel 1909 all'interno dei
Mélangesd'histoire des religions, diverdando,. inbrevet,empo, un das
sioo della sodologia. La concezione generale proposta da Hubert e
Mausscontribuìinoltre in manierasignificativaal dibattitostorico-reli
gioso, etnologico e filosofico,imponendlosi quale punto di riferimento SA'GGIO SULLA NATURA
imprescindibileperognistudiodeIIe tematichesacrificali. E LA FUNZIONE DEL SACRIFICIO
NataleSpineto
Premessa
In'quest.o lavoro ci siamo proposti di definire la nat.ura e la
funzione sociale del sacrifh::io. L'impresa sarebbe ambiziosa se non
fosse stata preparata dalle ri,cerclite"dei Tylor, dei Robertson
Smit.h ,e dei Frazer.
Sappiamo di quantosiamo10:1:0.debitori, ma studi successivi ci
permettonodi proporre ulla teoria diversa dana loro e che ci sem
bra più ,comprensiva. n'altra part.e, pensiamo di present.arla sol·
tanto come ipotesi provvisoria: su di un t.ema t.anto vasto e com·
ptesso ulteriori informazioni potrebbero indurci, in futuro., amo·
dificare le nostre idee attuali. Ma, fatte quest.e riserve, abbiamo
pensato che possa essere ut.ile coordinare i fatti dli cui disponiamo
e darne una concezione d'insieme.
Non ci fermeremo sulla storia delle concezioni antiche ePOPI)·
lari del sacrificio dono, del sacrificio nutrimento, del sacrific~o
,contratto ,e sullo studio delle ripercussioni chepossl:mo avere avu
to sul rituale,qualun.que possa esserne l'inleresse. Le teorie' del
sacrificio sono antiche quanto le reUgioni, ma per trovarneal·
cune che abbiano un carattere scientifico bisogna scendere fino
a questi ullimianni. Il merito di averle elaborate va attribuito
alla scuolaantropologi,ca e soprattutto ai suoi rap,presentantiin.
glesi.
Sotto l'ispirazion.e paraUela di Bastian, di Spencere di Dar·
win, E.B. Tylorl,confrontando fatti attinti da razze e da civiltà
diverse, tracciò una genesi delle forme del sacrHicio. Il sacrifi·
ciò, secondo, questo autore, è, originariamente,. un dono che iI
selvaggio oUre a degli esseri soprannaturali che ha bisogno di
rendersi benevoli.. In seguito, quando gli dèi acquisirono maggior
grandezza e, si allontanarono dall'uomo, la necessità di continua·
lO Prefazione
menti e: critiche ~ dopo la riedizioIle avvenuta nel 1909 all'interno dei
Mélangesd'histoire des religions, diverdando,. inbrevet,empo, un das
sioo della sodologia. La concezione generale proposta da Hubert e
Mausscontribuìinoltre in manierasignificativaal dibattitostorico-reli
gioso, etnologico e filosofico,imponendlosi quale punto di riferimento SA'GGIO SULLA NATURA
imprescindibileperognistudiodeIIe tematichesacrificali. E LA FUNZIONE DEL SACRIFICIO
NataleSpineto
Premessa
In'quest.o lavoro ci siamo proposti di definire la nat.ura e la
funzione sociale del sacrifh::io. L'impresa sarebbe ambiziosa se non
fosse stata preparata dalle ri,cerclite"dei Tylor, dei Robertson
Smit.h ,e dei Frazer.
Sappiamo di quantosiamo10:1:0.debitori, ma studi successivi ci
permettonodi proporre ulla teoria diversa dana loro e che ci sem
bra più ,comprensiva. n'altra part.e, pensiamo di present.arla sol·
tanto come ipotesi provvisoria: su di un t.ema t.anto vasto e com·
ptesso ulteriori informazioni potrebbero indurci, in futuro., amo·
dificare le nostre idee attuali. Ma, fatte quest.e riserve, abbiamo
pensato che possa essere ut.ile coordinare i fatti dli cui disponiamo
e darne una concezione d'insieme.
Non ci fermeremo sulla storia delle concezioni antiche ePOPI)·
lari del sacrificio dono, del sacrificio nutrimento, del sacrific~o
,contratto ,e sullo studio delle ripercussioni chepossl:mo avere avu
to sul rituale,qualun.que possa esserne l'inleresse. Le teorie' del
sacrificio sono antiche quanto le reUgioni, ma per trovarneal·
cune che abbiano un carattere scientifico bisogna scendere fino
a questi ullimianni. Il merito di averle elaborate va attribuito
alla scuolaantropologi,ca e soprattutto ai suoi rap,presentantiin.
glesi.
Sotto l'ispirazion.e paraUela di Bastian, di Spencere di Dar·
win, E.B. Tylorl,confrontando fatti attinti da razze e da civiltà
diverse, tracciò una genesi delle forme del sacrHicio. Il sacrifi·
ciò, secondo, questo autore, è, originariamente,. un dono che iI
selvaggio oUre a degli esseri soprannaturali che ha bisogno di
rendersi benevoli.. In seguito, quando gli dèi acquisirono maggior
grandezza e, si allontanarono dall'uomo, la necessità di continua·
12 Saggio sulla natura e la funzione del sacrificio
Premessa
re a [rasmeUer,e loro questo dono fece nascere i rhi sacrificali,
divisa e mangiata dai fedeli, era generalmeute distrutta tnUa in
des[inatia far giungere fino a questi esseri spiri[uali le eosespi
tera nei piacula.
ritualizzate. Al dono segui l'omaggio" con il quale il fedele rinun
In realtà dal momento in cui gli antichi totem furono sop
ciò ad ogni speranza di ricompensa. Di qui.a che il SBicrificio di c~l~o. ?astor~,
piantati dagllanimali domestici.nel dei. popoli f.n
venisse abnegazione· e rinunzia, il pa:sso era breve: l'evoluzione
remo prese.nti solo raramente n.el sacrifiCI e lU occas,lOne di CIT
trasformò così il rito, dai doni del selvaggio, al sacrificio di se.
costanze particolarmente gravi. Di conseguenza, esslapparv~ro
Ma se questa teoria descriveva bene le fasi dello svolgersi morale troppo sacri perché i p.rofani potessero prenderne:. ne mangIa
ddfenomeno, non ne spiegava il meccanismo; in ultima analisi vano soltanto i sacerdoti,. oppure si faceva scomparITe tuUo. In
non faceva che riprodurre in un linguaggio definito le vecchie tal caso,. l'estrema santità della vittima finì con il volgersi in imo
concezioni popolari. Senza dubbio aveva, di per sé, una parte di purità: il carattere ambiguo delle co,se sacre, che lo S~ith.aveva
ve.rifà storica: è cedo che i sacrifiei furono, generalmente, a messo in luce in modo cosÌ mirabile, gli permetteva. di spIegare
qualche stadio, ,dei doni1. che conferivano al fedele dei diritti facilmente come fosse potntaavvenire una simile t.rasformazione.
sul suo' dio e che essi servirono anche a nutrire la divinità. Ma D'altro canto, quando la parentela fra gli uomini e gli ani~~
constatare il fatto non era sufficiente, bisognav,a renderne conto. cessò di essere intelligibile ai Semiti:il sacrificio umano SOStItUl
In reall:à,fiu Robertson Smith il primo a tentare una spiega il sacrificìo animale; era infatti il solo mezzo per stabilire uno
3
zione ragionata del sacrificio., Era ispirato dalla recente scoperta scambio diretto del sangue fra il clan e il dio. Ma an.0~a.~e.ide,e
IndiVldu~,
del totemismo 4: come l'organiz,zazionedel clan totemico gli aveva e i costumi che pro[eggevano nelIa società la vita.degli
spiegato la. famiglia araba e semitica allo stesso modo V'olle ve vietando l'antropofagia, fecero cadere in disuso il pasto sacn
5,
dere nene prati,che del ,culto totemico il nucleo radicale del sa ficale.
sa~r? ani~ali
crificio. Nel toternismo il totem o il dio è della stessa famiglia D'altra parte, a pòco a poco, il caratte:e degli
dei. suoi adoratori; essi posseggono medesima carne e medesimo domestici, profanati quotidianamente per Il nu[rlmento delluo
sangue;. il rito ha lo scopo di tener viva e di difendere questa vita mo andò anch'esso dissolvendosi; la divinità si staccò dalle sue
for:Ue animali eIa vittima, allon[anandosi dal dio, si avvicinò
comune che li animae il vincolo che li lega; se è necessario, poi,
ristabilisce l'unità. L'« alleanza mediante il sangue» ed il «( pa all'uomo, padrone del gregge. Allora, per spiegarsi l'offerta che
né veniva fatta, la si rappresentò come un dono dell'uomo alle
sto in 'comune ) sono i mezzi più semplici per raggiungere questo
divinità.. Nacque cosÌ il sacrificio-dono. Nello stesso tempo, Ia
risultato. Ebbene, per Robertson Smith, il sacrificio non si di
somiglianza dei riti de.ila pena e del rito..sacrificale, l'effu~ione
stingue da questepraticbe.. Per lui era un pasto nel quale i fede
del sangue che si ritrova dall'una e ,dall'altra parte, confen.un
li, mangiando del totem, selo assimilavano, si assimilavano a lui,
carattere penale alle comunioni piaculari originarie e le trasfor-
si alleavano fra di loro o con lui. L'uccisione sacrificale non ave
va altro scopo ,che permettere la consumazione di un animale sa., mò in sacrifici esp.iatori.. '" .. . .'. ... .'.
A quest!=l ricerche si ricollegano, da una parte, I lavorI dI J.
e,di conseguenza, p,roibito. Dal sacrificio di comunione lo
CI"O
Frazer e, dall'altra, le teorie di Jevous. Queste ultime rappresen
Smith deduce i sacriifici espiatori o propiziatori, vale a d.ire i
tano.con una maggiore ,circospezione sualcu.ui punti. l'esaspera
piacula. e i sacrifici-dono od onorari. L'espiazione, secondo la. sua z;ion~
teologica della dottrÌlna di SmÌlth Quanto a J. Frazers,eg?
tesi, non è altro che un ristabilire l'alleanza interrotta; ebbene, iI 7•.
vi aggiunge un ,con[ributo importante. La s~iegazi?ne del sa,cn·
sacrificio totemi,co aveva tutti gli effetti di un rito espiiatoriio.. Del
fido del dio era rimast!o in Smithallo stadio rudimentale; pur
resto, egli ritrova questa virtù in tutti i sam:ifici,anche dopo la
senza disconosc,erne il carattere naturalislta, ,eglì ne fa,ceva un pia
totale.scom.parsa d,e} totemismo.
culum di. ordine superiore. L'antica idea; poi., deUaparentela
Rimaneva da spiiegare perche la vittima, primitivamente sud-
della vittimaltoternica con gli d.èi. sopravviveva pe,r spiega.re il sa.-