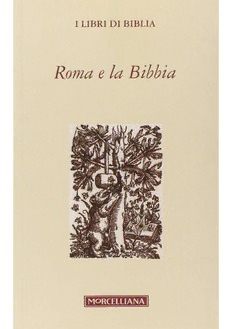Table Of ContentI LIBRI DI BIBLIA
ROMA E LA BIBBIA
a cura di Piero Capelli
MORCELLIANA
--PPaaggiinnee ddii gguuaarrddiiaa..iinndddd 33 1177//0011//1111 0099..1199
© 2011 Editrice Morcelliana
Via Gabriele Rosa 71 - 25121 Brescia
Prima edizione: ?????????? 2011
In copertina:
Frontespizio della Bibbia Reina, Amsterdam 1602
(“Quanto sono dolci al mio palato le tue parole:
più del miele alla mia bocca”, Sal 119,103)
www.morcelliana.com
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento
totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche),
sono riservati per tutti i Paesi. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere ef-
fettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso
previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dell’accordo
stipulato tra SIAE, AIE, SNS, SLSI e CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIA-
NI, CLAAI e LEGACOOP il 17 novembre 2005. Le riproduzioni ad uso differente da
quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del
presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via
delle Erbe n. 2, 20121 Milano, telefax 02.809506, e-mail [email protected]
ISBN 978-88-372-2445-5
Tipografia La Grafica s.n.c. - Vago di Lavagno (Vr)
--PPaaggiinnee ddii gguuaarrddiiaa..iinndddd 44 1177//0011//1111 0099..1199
Prefazione 5
PREFAZIONE
Nel 1975 Arnaldo Momigliano dava il felicissi-
mo titolo di Saggezza straniera a una sua concisa,
magistrale raccolta di saggi dedicati all’atteggia-
mento dei greci verso le civiltà con cui erano ve-
nuti in contatto tra il iv e il i secolo a.e.v., durante
il declino della loro storia politica: celti, romani,
iranici ed ebrei1. Quel titolo ci sembra adatto an-
che a suggerire sinteticamente la rete di rapporti e
di interazioni culturali che si distese sul Mediter-
raneo orientale durante il dominio romano, tra il
i secolo a.e.v. e il iv e.v. In quest’epoca anche la
Palestina fu sotto la sovranità di Roma, mentre una
diaspora ebraica era diffusa già da secoli per tutto il
Mediterraneo ora interamente romano. Quello che
chiamiamo per comodità “ebraismo” si confi gurava
come «una sottocultura in un più ampio mondo me-
diterraneo», secondo la precisa espressione di Seth
Schwartz2, e benché si trattasse di un’etnia in cresci-
ta demografi ca, è inverosimile che gli ebrei di Pale-
stina fossero più di mezzo milione alla vigilia delle
1 A. Momigliano, Saggezza straniera. L’elleismo e altre culture,
Einaudi, Torino 1980.
2 S. Schwartz, Imperialism and Jewish Society, 200 B.C.E. to 640
C.E., Princeton University Press, Princeton 2004, p. 3.
0011 PPrreeffaazziioonnee..iinndddd 55 1177//0011//1111 0099..2200
6 Piero Capelli
rivolte del i e ii secolo e.v., che decimarono le éli-
tes scribali e sacerdotali come anche le masse3. Già
da secoli, durante tutta la dominazione persiana e
quella ellenistica, questo ebraismo di piccoli nume-
ri aveva dovuto necessariamente elaborare modelli
di confronto ideale e comportamentale verso poteri
stranieri numericamente schiaccianti, per tanti versi
lontani nella cultura e nello spirito, spesso politica-
mente oppressivi, ma ricchissimi di prestigio e di
attrattiva anche al di là della sola forza istituzionale.
Questa lunga elaborazione, che aveva raggiunto esi-
ti politici anche asperrimi (come durante le guerre
maccabaiche del ii secolo a.e.v.), riceveva ora, sot-
to la dominazione romana, nuovi impulsi e nuove
ragioni, sui quali la minore distanza cronologica ci
garantisce una documentazione ancora più ampia.
Si discute se la chiave interpretativa più utile
per capire il confronto tra Gerusalemme, la dia-
spora e Roma sia quella dello «scontro di civiltà»,
come sembra suggerire il sottotitolo del libro Roma
e Gerusalemme di Martin Goodman (2002), o piut-
tosto quella della dialettica tra governanti stranieri
da una parte e, dall’altra, una variegata popolazione
di dominati, divisa tra elementi “collaborazionisti”
– anche e soprattutto nel senso delle dinamiche di
3 Vedi le stime (basate sulla capacità di sostentamento fornita dal
territorio e sulla densità di popolazione nelle aree urbanizzate) di M.
Broshi, The Population of Western Palestine in the Roman-Byzantine
Period, in «Bulletin of the Schools of Oriental Research» 236 (1979),
pp. 1-10, e G. Hamel, Poverty and Charity in Roman Palestine, First
Three Centuries C.E., University of California Press, Berkeley 1990,
pp. 137-140 (discussione in Schwartz, Imperialism, cit., pp. 10-12).
0011 PPrreeffaazziioonnee..iinndddd 66 1177//0011//1111 0099..2200
Prefazione 7
acculturazione – ed elementi “integralisti”. Già nel
1937, nel suo Der Gott der Makkabäer, Elias J. Bi-
ckerman reinterpretava in questo senso le guerre
maccabaiche, attraverso uno scavo documentario a
monte della narrazione dei libri deuterocanonici dei
Maccabei, tanto idealizzata (e ideologizzata) in sen-
so epico-patriottico4. A partire dal lavoro di Bicker-
man, anche nel pensare e presentare il confronto tra
cultura ebraica e civiltà romana, le categorie su cui
lungamente si era fatto affi damento (quelle di “or-
todossia”, “deviazione”, “ellenizzazione”, “giudai-
smo normativo”, e così via) hanno nel tempo ceduto
il passo a quelle, più produttive, di acculturazione,
adattamento, assimilazione5. Il quadro dei rappor-
ti fra le due culture divenne nel tempo sempre più
variegato, nella stessa Palestina ebraica non meno
che nella diaspora, soprattutto dopo la repressione
delle rivolte antiromane del 70 e del 135. Ne fanno
fede, più che le fonti letterarie, alcuni casi archeo-
logici spettacolari proprio in quella Galilea spesso
ancora descritta come culla e roccaforte del nascente
ebraismo rabbinico. Il grandioso mosaico dionisiaco
della villa romana di Sefforis e l’edifi cio sacrale di
Qasyon, dotato di altare, aquila romana in pietra e
dedica in greco all’imperatore Settimio Severo e ai
4 Sull’opera di E.J. Bickerman e sulle tematiche culturali a essa
sottese vedi oggi A.I. Baumgarten, Elias Bickerman as a Historian of
the Jews. A Twentieth Century Tale, Mohr Siebeck, Tübingen 2010.
5 Cfr. p. es. le considerazioni metodologiche di A. Thomas Kraabel,
recensione a J.M.G. Barclay, Jews in the Mediterranean Diaspora from
Alexander to Trajan, T. & T. Clark, Edinburgh 1996, in «Journal of
Theological Studies» 49 (1998), pp. 724-727: 726.
0011 PPrreeffaazziioonnee..iinndddd 77 1177//0011//1111 0099..2200
8 Piero Capelli
suoi fi gli «per voto degli ebrei (ioudaioi)», mostra-
no che tra gli ebrei la perdurante consapevolezza di
una propria identità separata coesisteva con la piena
(ancorché obbligata) partecipazione alla vita religio-
sa imperiale romana6. Perché il rabbinismo si affer-
masse tra gli ebrei come paradigma di maggioranza,
e perché tra Gerusalemme e Roma prendesse defi ni-
tivamente piede una logica di contrapposizione etni-
co-religiosa, furono necessari lo scorrere di diversi
secoli e la cristianizzazione uffi ciale dell’impero.
Intorno a questi temi, e a questi problemi meto-
dologici, ruota la presente nuova edizione degli atti
del convegno di Biblia tenuto a Verbania-Intra dal
31 gennaio al 3 febbraio 2002, riveduta in molti dei
saggi che la compongono e ampliata con due nuo-
vi contributi di Silvia Castelli e Liliana Rosso Ubi-
gli. La successione degli eventi storici è delineata
da Jan Alberto Soggin, mentre Günter Stemberger
analizza il variegato e spesso confl ittuale panorama
dei diversi movimenti ideologici in cui l’ebraismo
di Palestina si articolava. Francesca Calabi e Silvia
Castelli prendono in esame i casi emblematici di
due ebrei come Giuseppe Flavio e Tiberio Giulio
Alessandro, che riuscirono a percorrere, per vie e
ragioni diverse, carriere di primissimo piano nella
società e nell’amministrazione romane. Analizzata
così la condizione dell’ebreo nella civiltà romana,
principalmente in base alle fonti documentarie, i
saggi di Giancarlo Lacerenza e Giancarlo Rinaldi
6 Cfr. Schwartz, Imperialism, cit., pp. 131-134.
0011 PPrreeffaazziioonnee..iinndddd 88 1177//0011//1111 0099..2200
Prefazione 9
sono dedicati alla sua immagine e a quella della sua
cultura e delle sue Scritture nelle fonti letterarie ro-
mane d’epoca imperiale7. Corrispondentemente, gli
altri saggi che compongono il volume sono dedicati
all’immagine di Roma e della sua civiltà nella lette-
ratura ebraica e protocristiana del periodo: il Nuovo
Testamento (Giorgio Jossa), gli scritti apocalittici
ebraici e cristiani (Liliana Rosso Ubigli e Piero Ste-
fani) e le più tarde fonti rabbiniche (Alberto Mo-
she Somekh). Chiude il volume un breve elenco di
suggerimenti di letture qualifi cate e recenti, di facile
accesso per il lettore italiano.
L’intento di questo libro è di esporre le ragioni,
le modalità e le circostanze in cui il confronto tra
Gerusalemme e Roma sembrò produrre linguaggi
comuni, o almeno reciprocamente comprensibili,
e possibili interazioni pacifi che; e, dall’altra parte,
anche i momenti in cui lo stesso confronto sfociò
in attriti violenti. Come già avvertiva Momiglia-
no, il mondo ellenistico-romano dell’antichità tar-
da fornisce un vastissimo materiale di confronto
all’interpretazione della mobile e diffi cile realtà a
noi contemporanea. E così in particolare il perio-
do della dominazione romana sulla Palestina e sugli
ebrei è uno specchio lontano in cui vediamo rifl esse
le categorie di imperialismo, fondamentalismo, re-
sistenza, confronto, acculturazione, omologazione,
7 Cfr. le osservazioni di G. Lacerenza, recensione ad A. Lewin
(cur.), Gli ebrei nell’impero romano. Saggi vari tr. it. Giuntina, Firen-
ze 2001, in «Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli» 63
(2003) pp. 249-252: 251.
0011 PPrreeffaazziioonnee..iinndddd 99 1177//0011//1111 0099..2200
10 Piero Capelli
assimilazione. Le rifl essioni contenute in questo
volume proporranno al lettore una consapevolezza
storicamente più avvertita e un uso più adeguato di
questa terminologia.
Piero Capelli
0011 PPrreeffaazziioonnee..iinndddd 1100 1177//0011//1111 0099..2200
La Palestina sotto i romani, 63 a.C. - 135 d.C. 11
Jan Alberto Soggin
LA PALESTINA SOTTO I ROMANI,
63 A.C. - 135 D.C.
Nell’anno 63 a.e.v. Pompeo entrava in Giudea da
Damasco ove si trovava, dietro invito degli ultimi
discendenti della casa regnante asmonea, erede dei
Maccabei, i quali nel ii secolo a.e.v. avevano libera-
to Israele dal giogo dei Seleucidi di Siria. L’invito
gli era stato rivolto al fi ne di dirimere il contenzio-
so nato da una guerra civile, fi nita senza vincitori
né vinti, per cui i contendenti si erano appellati a
Roma. E Pompeo non si fece sfuggire l’occasione.
Occupò Gerusalemme dopo un breve assedio, e pe-
netrò nel tempio, dove entrò nel luogo santissimo,
causando la comprensibile costernazione dei fedeli:
il luogo santissimo infatti era accessibile soltanto
una volta all’anno, nel giorno dell’espiazione (jom
ha-kippurim), quando vi entrava il sommo sacerdo-
te (e solo lui), per cui l’atto di Pompeo costituiva
una vera e propria profanazione. Tacito (Storie 5,9)
esprime, peraltro, tutto il disappunto del condottiero
romano – il quale, si vede, pensava di trovarvi chi sa
quali statue e altri oggetti di valore – nell’aver con-
statato che il tempio era privo di immagini: vacuam
sedeni et inania arcana, secondo la descrizione
0022 SSooggggiinn..iinndddd 1111 1177//0011//1111 0099..2200