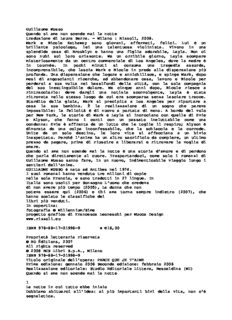Table Of ContentGuillaume Musso
Quando si ama non scende mai la notte
traduzione di Laura Serra. - Milano : Rizzoli, 2008.
Mark e Nicole Hathaway sono giovani, affermati, felici. Lui è un
brillante psicologo, lei una talentuosa violinista. Vivono in una
splendida casa di Brooklyn e hanno una figlia adorabile, Layla. Non ci
sono nubi sul loro orizzonte. Ma un orribile giorno, Layla scompare
misteriosamente da un centro commerciale di Los Angeles, dove la madre è
in tournée. In pochi minuti si consuma una tragedia assurda,
incomprensibile, che lascia Mark e Nicole in preda alla disperazione più
profonda. Una disperazione che logora e annichilisce, e spinge Mark, dopo
mesi di angoscianti ricerche, ad abbandonare casa, lavoro e Nicole per
perdersi a sua volta nei bassifondi della città, con la sola compagnia
del suo inestinguibile dolore. Ma cinque anni dopo, Nicole riesce a
rintracciarlo: deve dargli una notizia sconvolgente, Layla è stata
ritrovata nello stesso luogo da cui era scomparsa senza lasciare tracce.
Stordito dalla gioia, Mark si precipita a Los Angeles per riportare a
casa la sua bambina. È la realizzazione di un sogno che pareva
impossibile: la felicità è di nuovo a portata di mano. A bordo del volo
per New York, le storie di Mark e Layla si incrociano con quelle di Evie
e Alyson, che fanno i conti con un passato ineluttabile come una
condanna: Evie è affranta da un lutto che le toglie il respiro; Alyson è
divorata da una colpa inconfessabile, che la schiaccia e la corrode.
Unite da un solo destino, le loro vite si affacciano a un bivio
inaspettato. Perché l'anima ha un altro sacrificio da compiere, un ultimo
prezzo da pagare, prima di riuscire a liberarsi e ritrovare la voglia di
amare.
Quando si ama non scende mai la notte è una storia d'amore e di perdono
che parla direttamente al cuore. Trasportandoci, come solo i romanzi di
Guillaume Musso sanno fare, in un nuovo, indimenticabile viaggio lungo i
sentieri dell'anima.
GUILLAUME MUSSO è nato ad Antibes nel 1974.
I suoi romanzi hanno venduto tre milioni di copie
nella sola Francia, e sono tradotti in 27 lingue. In
Italia sono usciti per Sonzogno L'uomo che credeva
di non avere più tempo (2005), La donna che non
poteva essere qui (2006) e Chi ama torna sempre indietro (2007), che
hanno scalato le classifiche dei
libri più venduti.
In copertina:
fotografia © Millennium/Sime
progetto grafico di Francesca Leoneschi per Mucca Design
www.rizzoli.eu
ISBN 978-88-17-01998-9 x €18,00
Proprietà letteraria riservata
© XO Éditions, 2007
All rights reserved
© 2008 RCS Libri S.p.A., Milano
ISBN 978-88-17-01998-9
Titolo originale dell'opera: PARCE QUE JE T'AIME
Prima edizione: gennaio 2008 Seconda edizione: febbraio 2008
Realizzazione editoriale: Studio Editoriale Littera, Rescaldina (MI)
Quando si ama non scende mai la notte
1
La notte in cui tutto ebbe inizio
Dobbiamo abituarci all'idea: ai più importanti bivi della vita, non c'è
segnaletica.
Ernest Hemingway
Dicembre 2006
È la sera di Natale nel cuore di Manhattan...
La neve cade incessante dalla mattina. Intirizzita, la «città che non
dorme mai» gira al rallentatore, nonostante l'orgia di luminarie.
Il traffico è stranamente scorrevole per un giorno di festa, ma lo strato
di neve farinosa e i grossi mucchi ai lati della strada rendono difficile
ogni spostamento.
All'angolo tra Madison Avenue e la 36a, le limousine sfilano una dopo
l'altra, e si fermano a scaricare i passeggeri davanti all'edificio in
stile rinascimentale della Morgan Library, una delle istituzioni
culturali più prestigiose di New York, che festeggia oggi il suo
centenario.
La scala d'ingresso è un turbinio di pellicce, gioielli, smoking e abiti
lunghi. La folla confluisce verso un padiglione di vetro e acciaio di più
recente costruzione, che proietta armoniosamente il palazzo nel
Ventunesimo secolo. All'ultimo piano, un lungo corridoio conduce a una
sala dove sono esposti i tesori della Morgan: una Bibbia di Gutenberg,
alcuni manoscritti miniati medievali, disegni di Rembrandt, Leonardo da
Vinci e Van Gogh, lettere di Voltaire e Einstein, e perfino il tovagliolo
su cui Bob Dylan scrisse le parole di Blowin in the Wind.
A poco a poco si fa silenzio e i ritardatari raggiungono i propri posti.
Per la serata una parte della sala lettura è stata attrezzata per
ospitare il concerto della violinista Nicole Hathaway, che esegue alcune
sonate di Mozart e Brahms.
La Hathaway entra in scena tra gli applausi. È una donna sui trent'anni,
sofisticata, con un elegante chignon alla Grace Kelly che le dà un'aria
da eroina hitchcockiana. Ha inciso il primo disco a sedici anni, suonato
con le maggiori orchestre del mondo e ottenuto i riconoscimenti più
prestigiosi. Cinque anni fa la sua vita è stata sconvolta da una tragedia
di cui hanno parlato stampa e televisione, e da allora la sua celebrità
ha superato i confini della cerchia degli appassionati di musica da
camera.
Nicole saluta il pubblico e sistema il violino sotto il mento. La sua
bellezza classica si accorda alla perfezione con la sala piena di
incisioni e manoscritti rinascimentali, come se quello fosse il suo
habitat naturale. Con un attacco schietto e profondo, l'archetto entra
immediatamente in sintonia con le corde. Intorno, ogni dettaglio è
imbevuto di buongusto e raffinatezza.
Fuori la neve continua a cadere nella notte fredda.
A meno di cinquecento metri da lì, non lontano dalla Grand Central
Station, la lastra di un tombino si solleva lentamente e ne emerge la
testa irsuta di un uomo dallo sguardo vacuo e il viso sciupato.
Dopo aver liberato il labrador nero che teneva in braccio, l'uomo si tira
su a fatica e attraversa la strada barcollando, col rischio di farsi
investire, in mezzo a un concerto di clacson. È debole e malconcio, perso
nel suo cappotto logoro e sporco. Istintivamente la gente lo scansa e
affretta il passo.
Ha trentacinque anni, ma ne dimostra cinquanta. Una volta aveva un
lavoro, una moglie, una figlia e una casa, ma è stato tanto tempo prima.
Oggi quest'uomo è solo un fantasma di stracci che biascica parole
incoerenti.
Che giorno è? Che ora è?
Non lo sa più. Nella sua testa tutto si confonde. Vede le luci della
città sfocate davanti a sé. I fiocchi di neve portati dal vento gli
feriscono il viso, ha i piedi ghiacciati, lo stomaco vuoto che urla di
dolore, le ossa sul punto di rompersi.
Sono già due anni che ha abbandonato la propria vita per rintanarsi nelle
viscere della città. Come tanti altri, ha trovato riparo nei tunnel del
metrò, nelle fogne e sui binari morti delle ferrovie. La politica di
tolleranza zero dell'amministrazione cittadina ha ripulito
scrupolosamente Manhattan, ma sotto i grattacieli sfavillanti pulsa una
vita parallela: una New York di relitti umani che galleggiano nel dedalo
di cunicoli, nicchie e cavità. Migliaia di talpe respinte nei bassifondi
si nascondono dalla polizia nelle luride gallerie infestate dai ratti.
L'uomo si fruga in tasca e tira fuori una bottiglia di liquore di infima
qualità.
Per dimenticare il freddo, la paura, la sporcizia.
Per dimenticare la sua vita di un tempo.
Ultimo colpo d'archetto di Nicole Hathaway. Per lo spazio di due battute
- un silenzio che appartiene ancora a Mozart - la platea rimane con il
fiato sospeso prima di sciogliersi in un applauso scrosciante.
La violinista ringrazia con un inchino, riceve un mazzo di fiori e
attraversa la sala fra sorrisi e complimenti. Nonostante l'entusiasmo,
sente di non aver dato il massimo. Ha suonato con tecnica perfetta,
energia, purezza di ghiaccio.
Ma non con l'anima.
Stringe meccanicamente qualche mano, si bagna le labbra di champagne e si
guarda intorno inquieta.
«Vuoi che rientriamo, cara?»
Nicole si gira lentamente verso quella voce rassicurante. Eriq le sta
davanti, sorseggiando un Martini. È il suo compagno da qualche mese: un
avvocato, un uomo solido e premuroso, che ha saputo starle vicino in un
momento difficile.
«Sì, mi gira la testa. Portami a casa.»
Avendo previsto la sua risposta, Eriq era già andato al guardaroba e,
ora, le porge un cappotto di flanella grigia. Lei se lo infila e si
stringe il bavero intorno al collo.
Proprio mentre la festa comincia, i due scendono l'imponente scalone di
marmo tenendosi per mano.
«Ti chiamo un taxi» propone lui quando arrivano nell'atrio. «Io vado a
prendere la mia auto in ufficio e ti raggiungo.»
«Vengo con te. Saranno cinque minuti a piedi.»
«Scherzi? C'è un tempo da lupi.»
«Ho bisogno di camminare e respirare un po' d'aria fresca.»
«Ma è pericoloso!»
«Da quando in qua è pericoloso fare trecento metri a piedi? E poi ci sei
tu.»
«Come vuoi.»
Raggiungono in silenzio la 5a Avenue.
L'auto si trova a cento metri, dietro Bryant Park. Nelle belle giornate
il Bryant è un'oasi di verde, ideale per passeggiate, picnic o partite a
scacchi accanto alla fontana, ma di sera è buio e sinistro.
«FUORI I SOLDI!»
Nicole vede una lama, scintillante come un lampo.
«FUORI I SOLDI, HO DETTO!»
E un uomo senza età, con la testa rasata e una giacca a vento scura che
gli arriva alle ginocchia. Il viso, segnato da una lunga cicatrice,
incornicia due occhi animati dalla luce della follia.
«FORZA, SBRIGATI!»
«Va bene, va bene» si affretta a dire Eriq, tirando fuori portafogli,
orologio e cellulare.
L'uomo afferra gli oggetti, poi si avvicina a Nicole per strapparle la
borsa e l'astuccio con il violino. Lei serra forte gli occhi, e recita
mentalmente l'alfabeto al contrario, come faceva da bambina quando aveva
paura.
ZYXWVU...
È l'unica cosa che le viene in mente, l'unico sistema per neutralizzare
il terrore in attesa che quel momento diventi un ricordo.
TSRQPO...
Ora se ne andrà, ha avuto quello che voleva.
N M L K J I H...
Se ne andrà. A che gli servirebbe ucciderci?
G F E D C B A..
Ma quando Nicole riapre gli occhi, lo sconosciuto è sempre lì e ha il
braccio alzato.
Eriq vede la mano con il coltello abbassarsi, ma è paralizzato dalla
paura.
Lei guarda ipnotizzata la lama che sta per tagliarle la gola.
È tutta qui, la sua vita? Che strano. Dicono che a volte, in punto di
morte, si rivedano in rapida sequenza i momenti salienti della propria
esistenza. Nicole, invece, ha solo un'immagine impressa nella mente: una
spiaggia immensa, e due persone che la chiamano con la mano. Le distingue
bene. La prima è il solo uomo che abbia mai amato e che non ha saputo
trattenere. La seconda è sua figlia, che non ha saputo proteggere.
Sono morta.
No. Non ancora. Come mai? Qualcuno è sbucato fuori dal nulla.
Un barbone.
Lì per lì Nicole pensa a un altro teppista, poi capisce che il nuovo
venuto sta tentando di proteggerla. Anzi, è lui che si becca una
coltellata nella spalla. Benché ferito, si rialza, si lancia con rabbia
contro l'aggressore, lo disarma e lo costringe a mollare il bottino. Per
quanto sia più magro e più debole, il senzatetto prende il sopravvento
nel corpo a corpo e, con l'aiuto del suo labrador nero, mette in fuga
l'avversario.
Ma la vittoria lo ha provato. Sfinito, crolla per terra, sbattendo la
faccia sul marciapiedi ghiacciato.
Nicole si inginocchia sulla neve, cercando di soccorrere l'uomo che le ha
salvato la vita. Ci sono tracce di sangue.
«Diamogli venti dollari e andiamo via» propone Eriq, raccogliendo il
portafogli e il cellulare.
Ora che il pericolo è passato, l'avvocato ha ritrovato la sua parlantina.
Nicole lo guarda con disprezzo.
«Non vedi che è ferito?»
«Allora chiamo la polizia.»
«Non è la polizia che bisogna chiamare, ma un'ambulanza.»
Con qualche difficoltà, Nicole riesce a girare il corpo dello
sconosciuto. Gli posa una mano sulla spalla sanguinante e gli guarda il
viso dalla barba incolta.
In un primo momento non lo riconosce, poi i suoi occhi incrociano quelli
febbricitanti dell'uomo.
Qualcosa in lei si spezza. Si sente invadere da un'ondata di calore, non
sa ancora se è dolore o sollievo. Una fiamma che la ustiona o una
speranza che sorge nella notte.
Si china su di lui e avvicina il viso al suo come per difenderlo dalla
neve.
«Che cosa ti salta in mente?» chiede Eriq.
«Lascia perdere la telefonata e va' a prendere l'auto.»
«Perché?»
«Quest'uomo... lo conosco.»
«Come?»
«Aiutami a trasportarlo a casa» ordina lei senza far caso alla domanda.
Eriq scuote la testa, poi sospira: «Insomma, si può sapere chi è questo
tizio?».
Con lo sguardo perso nel vuoto, Nicole lascia passare un lungo istante
prima di rispondere: «È Mark, mio marito».
2 La scomparsa
Non siamo mai così esposti alla sofferenza, come nel momento in cui
amiamo.
Sigmund Freud
Brooklyn, dall'altro lato del fiume, in una piccola casa vittoriana
ornata di torrette e doccioni...
Un bel fuoco scoppiettava nel caminetto.
Ancora svenuto, Mark Hathaway era sdraiato sul divano del salotto, con
una pesante coperta avvolta intorno alle gambe. China su di lui, la
dottoressa Susan Kingston finì di applicargli i punti di sutura alla
spalla.
«La ferita è superficiale» spiegò a Nicole, togliendosi i guanti. «Semmai
sono le condizioni generali che mi preoccupano: ha una brutta bronchite e
il corpo coperto di ematomi e geloni.»
Poco prima, mentre era a tavola con i famigliari di fronte al
tradizionale pudding natalizio, Susan aveva risposto alla telefonata
della sua vicina, Nicole Hathaway, che la pregava di venire in soccorso
di suo marito ferito.
Benché stupita, non aveva esitato un istante. Lei e suo marito
conoscevano bene Mark e Nicole. Prima della tragedia, le due coppie
uscivano spesso insieme per provare i ristoranti italiani di Park Slope,
andare a caccia di oggetti antichi nei negozi di antiquariato di Brooklyn
Height o a correre a Prospect Park durante il weekend.
Ormai quell'epoca pareva lontanissima, quasi irreale.
Susan era sconcertata.
«Sapevi che viveva per strada?»
Nicole scosse la testa, incapace di parlare.
Una mattina di due anni prima, suo marito le aveva annunciato che aveva
deciso di andarsene: non riusciva più a vivere così, non ne aveva la
forza. Nicole aveva fatto di tutto per trattenerlo, ma a volte tutto non
basta. Da allora non aveva più avuto sue notìzie.
«Gli ho somministrato sedativi e antibiotici» disse Susan, rimettendo i
suoi strumenti nella valigetta.
Nicole la accompagnò alla porta.
«Ripasserò domattina ma...» la dottoressa si interruppe a metà,
terrorizzata e imbarazzata da ciò che stava per dire. «Non lasciarlo
andare in queste condizioni, altrimenti... morirà.»
«Allora?»
«Allora cosa?»
«Che ne facciamo di tuo marito?» Eriq camminava su e giù per la cucina
con un bicchiere di whisky in mano.
Nicole lo guardò con un misto di fastidio e disgusto. Che cosa ci faceva
insieme a quel tipo? Per quale motivo aveva lasciato che entrasse nella
sua vita?
«Vattene, per favore» disse.
Eriq scosse la testa.
«Non ci penso nemmeno ad abbandonarti in un momento come questo.»
«Quando avevo un coltello puntato alla gola non ti sei fatto troppi
problemi.»
«Non ho avuto il tempo di...» Eriq cominciò, senza riuscire a finire la
frase.
«Vattene» ripetè Nicole.
«Se è veramente questo che vuoi... Ma ti chiamerò domani.»
Contenta di essersene sbarazzata, Nicole tornò in soggiorno. Spense tutte
le lampade e, senza far rumore, accostò una poltrona al divano per stare
più vicina a Mark.
Nella stanza, illuminata solo dal chiarore incerto del fuoco, regnava la
calma.
Esausta e disorientata, Nicole strinse la mano del marito e chiuse gli
occhi. Erano stati così felici in quella casa. Quando, dieci anni prima,
avevano trovato quella villetta di fine Ottocento con la facciata di
arenaria scura e il giardino, erano impazziti di gioia. L'avevano
comprata all'istante, anche per crescere Layla lontano dalla frenesia di
Manhattan.
Sugli scaffali della libreria, alcune foto incorniciavano la felicità di
un tempo. Loro due, mano nella mano, si scambiavano uno sguardo complice.
Vacanze romantiche alle Hawaii e nel Grand Canyon in motocicletta. Poi
l'immagine di un'ecografia e, pochi mesi dopo, il faccino tondo di una
neonata che festeggiava il suo primo Natale. Nelle ultime istantanee, la
bambina era cresciuta e aveva perduto i primi denti. Posava orgogliosa
davanti alle giraffe dello zoo del Bronx, si aggiustava il berrettino
sulla neve del Montana e presentava all'obiettivo della macchina
fotografica i suoi due pesci pagliaccio, Ernesto e Cappuccino.
Il profumo dei giorni felici svaniti per sempre.
Mark tossì nel sonno. Nicole fu scossa da un brivido. L'uomo che dormiva
sul divano non aveva più niente a che vedere con quello che lei aveva
sposato. Solo i diplomi e le onorificenze che tappezzavano la parete
ricordavano lo psicologo di fama che era stato un tempo. Poiché era
specialista in resilienza, la capacità dell'uomo di affrontare e superare
le avversità della vita, la faa (Federal Aviation Administration) e l'FBI
si rivolgevano a lui in occasione di catastrofi aeree e sequestri di
persona. Dopo l'11 settembre Mark aveva fatto parte della squadra di
psicologi incaricata di seguire le famiglie delle vittime e dei
superstiti. Non si esce mai indenni da simili tragedie. Se non si muore,
ci si sente sporchi e tormentati dal senso di colpa, divorati da
un'angoscia sorda e straziati da una domanda che non avrà mai risposta:
perché noi siamo sopravvissuti e gli altri no? Perché proprio noi, e non
nostro figlio, nostra moglie, i nostri genitori?
Oltre a fare lo psicologo, un tempo Mark collaborava con diverse riviste
di divulgazione. Aveva contribuito a far conoscere al grande pubblico
terapie come il gioco di ruolo e l'ipnosi, alle quali lavorava con il suo
socio e amico d'infanzia Connor McCoy. Col tempo la sua fama era
cresciuta, e Mark era diventato un ospite fisso dei talk show. E così,
quasi senza accorgersene, Mark e Nicole erano diventati delle celebrità.
In un numero sulle coppie più in vista di New York, «Vanity Fair» aveva
dedicato loro un articolo di quattro pagine. Una vera consacrazione.
Ma la favola di carta patinata si era infranta da un giorno all'altro. Un
pomeriggio di marzo Layla, la loro bambina di cinque anni, era scomparsa.
Si trovava in un centro commerciale di Orange County, a sud di Los
Angeles, ed era stata vista per l'ultima volta davanti alla vetrina del
Disney Store. La baby-sitter, una ragazza alla pari australiana, l'aveva
lasciata sola qualche minuto, giusto il tempo di provare un paio di jeans
nel negozio Diesel lì accanto.
Quanto tempo era passato prima che notasse l'assenza della bambina? «Non
più di cinque minuti» aveva dichiarato alla polizia. Vale a dire
un'eternità. In cinque minuti può succedere di tutto.
Le prime ore che seguono la scomparsa di un bambino sono cruciali: è
allora che si hanno più probabilità di ritrovarlo. Già dopo due giorni le
speranze si riducono drasticamente.
Pioveva a dirotto, quel 23 marzo. Benché Layla fosse sparita in pieno
giorno e in un posto affollato, gli inquirenti avevano faticato a
raccogliere testimonianze attendibili. Le immagini registrate dalle
telecamere di sorveglianza non avevano fornito indizi di alcun genere, né
era servita la deposizione della baby-sitter, colpevole di negligenza, ma
non certo di rapimento.
Erano passati i giorni...
Per parecchie settimane, più di cento agenti, alcuni con i cani, o in
elicottero, avevano setacciato la zona.
Poi i mesi...
La polizia era disorientata dalla mancanza di indizi. Non c'erano state
richieste di riscatto, né erano emerse piste verosimili. Niente.
E gli anni...
La foto di Layla era stata affissa nelle stazioni, negli aeroporti e
negli uffici postali.
Ma la piccola era introvabile.
Svanita nel nulla.
Per Mark, la vita si era fermata quel 23 marzo 2002.
La scomparsa della figlia lo aveva gettato nella disperazione più nera.
Devastato da un terremoto interiore fatto di dolore e senso di colpa, si
era allontanato dal lavoro, dalla moglie, da Connor.
Aveva assunto i migliori investigatori privati perché riprendessero in
mano l'indagine, questa volta senza trascurare alcun dettaglio.
Senza esito.
Allora aveva cominciato a indagare di persona. La ricerca, destinata al
fallimento, era durata tre anni. Poi Mark era scomparso a sua volta, e
non aveva più dato notizie di sé.
Nicole, invece, non si era lasciata andare.
All'inizio aveva provato una disperazione senza fondo, aggravata da un
particolare senso di colpa: era stata lei a volere Layla con sé a Los
Angeles, dove si trovava per una tournée, ed era stata lei ad assumere la
baby-sitter. Poi si era buttata anima e corpo nella musica: aveva inciso
un disco dietro l'altro e perfino accettato di parlare della sua tragedia
ai giornali o in televisione, offrendosi come vittima consenziente del
voyeurismo mediatico.
Ogni qualvolta si sentiva sopraffatta dal dolore, allora prendeva una
stanza in albergo e si rintanava sotto le coperte, come fosse in letargo,
allontanandosi da tutto.
Ciascuno sopravviveva come poteva.
Un tizzone crepitò nel caminetto. Mark sussultò e aprì gli occhi. Si
drizzò a sedere e per qualche secondo si chiese dove fosse e che cosa gli
fosse capitato.
Vedendo Nicole, riordinò a poco a poco le idee.
«Sei ferita?» le domandò.
«Grazie a te, no.»
Per un istante lui sembrò ripiombare nel torpore, poi si alzò di scatto.
«Resta sdraiato, ti prego. Devi riposare.»
Come se non avesse sentito, Mark si avvicinò alla portafinestra. Dietro
la parete di vetro, la strada scintillava, bianca e silenziosa.
«Dove sono i miei vestiti?»
«Li ho buttati, Mark. Erano sporchi e stracciati.»
«E il cane?»
«L'ho portato qui con noi, ma è scappato.»
«Me ne vado» fece lui, avviandosi alla porta con passo malfermo.
Nicole lo bloccò.
«Senti, è notte, sei ferito ed esausto. Non ci vediamo da due anni.
Dobbiamo parlare.»
Gli tese le braccia, ma lui la respinse. Gli si aggrappò, ma lui si
divincolò, urtando contro gli scaffali. Una cornice cadde e il vetro si
ruppe.
Mark la raccolse: era una foto della figlia. Con gli occhi verdi ridenti
e il sorriso sulle labbra, la bambina sprizzava felicità e gioia di
vivere da tutti i pori.
In quel momento qualcosa in lui cedette. Si accasciò, con la schiena
appoggiata al muro, e scoppiò in lacrime. Nicole gli si strinse al petto
e rimasero a lungo così, abbracciati e affranti, pelle morbida contro
pelle rugosa, profumo di Guerlain contro odore di fogna.
Tenendolo per mano, Nicole accompagnò il marito in bagno, aprì il
miscelatore della doccia e si ritirò. Inebriato dall'odore dello shampoo,
Mark restò quasi mezz'ora sotto il getto: poi si avvolse tutto
gocciolante in un grande asciugamano e uscì nel corridoio. Aprì quello
che era stato il suo armadio. Non degnò di uno sguardo gli abiti Armani,
Boss, Zegna di una volta, reliquie di una vita che non era più la sua, ma
si infilò un paio di boxer, dei jeans larghi, una maglia a maniche lunghe
e un pullover pesante.
Quindi scese le scale e raggiunse Nicole in cucina.
Con la sua combinazione di legno, vetro e metallo, la stanza giocava su
effetti di trasparenza. Lungo una parete correva un ampio piano di lavoro
dalle linee essenziali, mentre al centro un'isola perfettamente
attrezzata invitava a mettersi ai fornelli. Anni prima, in quella stanza
aveva regnato l'atmosfera gioiosa delle prime colazioni in famiglia,
delle merende a base di pancake e delle cenette romantiche. Ma era ormai
molto tempo che nessuno vi cucinava più niente.
«Ti ho preparato un'omelette e del pane tostato» disse Nicole versandogli
il caffè fumante.
Mark si sedette davanti al piatto, ma si alzò quasi subito. Gli tremavano
le mani. Prima di toccare il cibo, aveva bisogno di bere.
Sotto lo sguardo sbalordito di Nicole, stappò con frenesia la prima
bottiglia di vino che gli capitò a tiro e ne scolò la metà con due lunghi
sorsi. Placato, trangugiò l'omelette senza dire una parola, finché Nicole
non gli rivolse una domanda.
«Dove sei stato, Mark?»
«In bagno» rispose lui, senza guardarla.
«No, dove sei stato negli ultimi due anni?»
«Giù.»
«Giù?»
«Nei tunnel del metrò, nelle fogne e nelle condutture, assieme ai
barboni.»
Con le lacrime agli occhi, Nicole scuoteva la testa.
«Ma perché?»
«Sai benissimo perché» alzò la voce.
Lei gli si avvicinò e gli prese la mano.
«Ma hai una moglie, una professione, degli amici.»
Mark ritrasse la mano e si alzò da tavola.
«Lasciami in pace!»
«Spiegami una cosa» disse lei per trattenerlo, «che senso ha vivere così?
Ti serve a qualcosa?»
Mark le scoccò un'occhiata intensa.
«Vivo così perché non posso più vivere in altro modo. Tu puoi, io no.»
«Non cercare di farmi sentire in colpa.»
«Non ti rimprovero niente. Rifatti pure una vita, se vuoi. Io non posso.»
«Ma sei uno psicologo, Mark. Hai aiutato tanta gente a superare le
peggiori catastrofi.»
«Questo dolore io non voglio superarlo, perché è l'unica cosa che mi
mantiene in vita. È tutto quello che mi resta di lei, capisci? Non passa
minuto che non pensi a lei, che non mi chieda dove si trovi in questo
momento e cosa le abbia fatto il suo rapitore.»
«È morta, Mark» sentenziò freddamente Nicole.
Era più di quanto Mark potesse sopportare. Alzò la mano verso la moglie e
l'afferrò per la gola come se volesse strangolarla.
«Come puoi dire una cosa simile?»
«Sono passati cinque anni!» gridò lei cercando di liberarsi dalla
stretta. «Cinque anni senza il minimo indizio, cinque anni senza nessuna
richiesta di riscatto!»
«Una possibilità c'è sempre.»
«No, Mark, è finita. Non è più lecito sperare. Layla non riapparirà
all'improvviso. Non succederà mai, capisci? MAI!”
«Zitta!»
«Se mai ritroveranno qualcosa, sarà soltanto il suo cadavere.»
«NO!»
«Sì. E non credere di essere l'unico a soffrire. Come credi che mi senta
io, che oltre a mia figlia ho perso anche mio marito?»
Senza rispondere, Mark uscì dalla cucina. Nicole lo seguì, decisa a
metterlo spalle al muro.
«Non hai mai pensato che potremmo avere altri bambini? Non ti sei mai
detto che, col tempo, la vita potrebbe tornare a sorriderci?»
«Prima di avere altri figli, voglio ritrovare la mia Layla.»
«Lascia che chiami Connor. Ti cerca dappertutto da due anni. Può aiutarti
a risalire la china.»
«Non è quello che voglio. Mia figlia soffre e io voglio soffrire con
lei.»
«Se continuerai a vivere in strada, morirai. È questo che vuoi? Fa' pure.
Sparati un colpo in testa!»
«Non voglio morire, perché voglio esserci il giorno in cui la
ritroveremo.»
Nicole aveva bisogno di aiuto. Prese il cellulare e compose il numero di
Connor.
Rispondi, Connor, rispondi!
Da qualche parte, nella notte, diversi squilli suonarono a vuoto. Nicole
capì che Connor non avrebbe risposto e che aveva perso la battaglia. Da
sola non sarebbe riuscita a trattenere il marito.
Mark tornò a coricarsi sul divano e dormì ancora qualche ora.
Si alzò all'alba, prese una borsa sportiva dal guardaroba e vi infilò una
coperta, una giacca a vento, qualche pacchetto di biscotti e diverse
bottiglie di alcolici.
Nicole aggiunse un cellulare e un caricabatteria.
«Se tu decidessi di chiamare Connor, o se io dovessi avere bisogno di
te...»
Quando Mark aprì la porta aveva smesso di nevicare e le prime luci del
giorno tingevano la città.
Appena Mark posò il piede sulla coltre di neve, il labrador nero apparve
come d'incanto da dietro un bidone della spazzatura e gli corse incontro.
Mark gli grattò la testa, si alitò sulle mani, prese la borsa e partì in
direzione del ponte di Brooklyn.
Sulla soglia, Nicole guardò l'uomo della sua vita allontanarsi nel
mattino.
«Ho bisogno di te! Adesso!» gridò, in mezzo alla strada.
Con l'aria di un pugile suonato, lui, che aveva percorso una decina di
metri, si girò e allargò le braccia a significare che gli dispiaceva
molto, ma non poteva farci niente.
Poi scomparve dietro l'angolo.
3 Qualcuno che mi assomiglia
La vita è una collana di paure.
Bjórk
La bambina che sognava un fusto di benzina e un fiammifero.
Titolo di un romanzo di Stieg Larsson
Lo studio del dottor Connor McCoy si trovava in una delle torri di vetro
del prestigioso Time Warner Center, all'estremità ovest di Central Park.
Connor ne era molto fiero, perché ogni particolare era studiato in modo
da mettere a proprio agio i pazienti e garantire loro le condizioni
migliori per essere curati. Grazie al passaparola la clientela era
aumentata esponenzialmente negli anni, anche se i suoi metodi eterodossi
non erano approvati da tutti i colleghi.
La notte di Natale, Connor era ancora in ufficio a studiare la cartella
clinica di uno dei suoi pazienti. Soffocò uno sbadiglio e diede
un'occhiata all'orologio.
L'una e mezza.
A casa non lo aspettava nessuno. Connor viveva soltanto per il lavoro e
non aveva una compagna né una famiglia. Molto tempo prima aveva aperto il
suo primo studio con Mark Hathaway, l'amico d'infanzia con cui aveva
condiviso la passione per la psicologia. Erano cresciuti in un quartiere
difficile di Chicago, e avevano conosciuto da vicino la sofferenza prima
di dedicarsi ad alleviare quella degli altri con le loro terapie
innovative. Insieme avevano raggiunto un successo strepitoso, fino a
quando la vita di Mark era stata distrutta dalla scomparsa della figlia.
Connor aveva fatto tutto il possibile per aiutarlo, riprendendo con lui
l'indagine quando la polizia aveva gettato la spugna, ma non era bastato.
Annientato dal dolore, Mark era sparito a sua volta. La fuga del socio
aveva lasciato Connor nel più profondo sgomento. Non solo aveva perduto
il suo migliore amico, ma aveva anche subito il più grande scacco
professionale della sua carriera.
Per scacciare i brutti ricordi, si alzò dalla poltrona e si versò un dito
di whisky di puro malto.
«Buon Natale» disse, alzando il bicchiere verso la propria immagine allo
specchio.
La stanza, circondata da vetrate, era immersa in una luce irreale e
offriva una vista formidabile del parco. L'ambiente era sobrio ed
essenziale. Su uno scaffale metallico due sculture di Alberto Giacometti
e appeso alla parete un quadro monocromo di Robert Ryman: un quadrato
bianco, semplice in apparenza, addirittura banale per chi non sapesse
cogliere le infinite variazioni di luce che si ricreavano sulla tela.
Intuire l'invisibile, vedere ciò che si nasconde dietro la superficie era
l'essenza stessa della sua professione.
Con il bicchiere in mano, Connor analizzò sullo schermo del computer una
zona del cervello di un paziente evidenziata con le neuroimmagini
funzionali. Sofferenza, amore, felicità o dolore: tutto accadeva
all'interno di quella scatola magica. Il desiderio, la memoria, la paura,
l'aggressività, il pensiero, il sonno dipendono in buona parte dal fatto
che nell'organismo vengono liberati i neurotrasmettitori, le sostanze
chimiche incaricate di far passare i messaggi da un neurone all'altro.
Connor era stato un pioniere nell'analisi delle cause biologiche della
depressione. Era stato lui a scoprire, insieme a un team di ricercatori,
che un gene trasportatore più corto del normale predispone alla
depressione e al suicidio. Gli individui dunque non nascono uguali e non
affrontano ad armi pari le prove della vita.
Connor, però, non aveva mai creduto ciecamente nel determinismo genetico.
Convinto che lo psichismo e la biologia fossero strettamente legati,
aveva sempre cercato di approfondire sia l'ambito psicologico sia quello
neurologico. Era impossibile stabilire una gerarchia tra esperienza e
corredo genetico.
In ogni caso, questa era la sua convinzione: niente può essere stabilito
in maniera definitiva.
Il palazzo in cui si trovava lo studio ospitava un albergo a cinque
stelle, diversi ristoranti e un locale jazz. Ogni rumore, ogni voce, ogni
risata lontana, in quel momento, sembravano sottolineare la solitudine di
Connor.