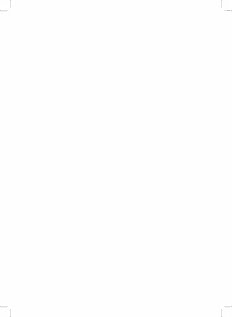Table Of ContentNella stessa collana:
Certi Confini
Sulla letteratura italiana dell’immigrazione
a cura di Lucia Quaquarelli
ombre
Quaderni di SynapSiS X
a cura di Francesco Cattani e Luca Raimondi
Sulle traCCe di HermeS
migrare, ViVere, riorientarSi
Peter Caravetta
roland bartHeS e la tentazione del romanzo
Guido Mattia Gallerani
Storie proprio CoSì
il racconto nell’era della narratiVità totale
Donata Meneghelli
narrazione e migrazione
Lucia Quaquarelli
bande à part
graphic noVel, fumetto e letteratura
a cura di Sara Colaone e Lucia Quaquarelli
elliSSi dello Sguardo
pathoSformeln dell’ineSpreSSiVità femminile
dalla cultura ViSuale alla letteratura
Beatrice Seligardi
Senza fine
SeQuel, preQuel, altre continuazioni: il teSto eSpanSo
Donata Meneghelli
Sorellanze
nella narratiVa femminile ingleSe tra le due guerre
Claudia Cao
bande à part 2
fumetto e tranSmedialità
a cura di Giuliana Benvenuti, Sara Colaone, Lucia Quaquarelli
eterolinguiSmo e traduzione
Chiara Denti
la traduzione nell’era digitale
Michael Cronin, traduzione di Gaia Ballerini e Chiara Denti
T
racciaTi
Collana diretta da
Giuliana Benvenuti, Donata Meneghelli e Lucia Quaquarelli
Pseudo-saggi.
(Ri)Scritture
tra critica e letteratura
Guido Mattia Gallerani
Copyright 2019 © Morellini Editore by Enzimi Srls
Via Carlo Farini, 70
20159 Milano
www.morellinieditore.it
[email protected]
facebook.com/morellinieditore
instragram.com/morellinieditore
Art director márGo
Impaginazione: Silvia Mussini
ISBN: 978-88-6298-712-7
Prima edizione: giugno 2019
Stampa: Rotomail S.p.A. – Vignate (Milano)
Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali.
Indice
Avvertenza e ringraziamenti …………………………………………………… 7
Introduzione ……………………………………………………………………… 9
1. Dal saggio allo pseudo-saggio ……………………………………………… 17
1.1. Tipologie generali di saggio ……………………………………………… 17
1.2. La relazione e la forma saggistiche: Montaigne ………………………… 21
1.3. La contraddizione storica, ovvero il modello divergente ……………… 29
1.4. La relazione metatestuale: dal saggio critico allo pseudo-saggio ……… 40
1.5. Pseudo-saggio: saggio ibrido? ……………………………………………… 46
1.6. Dal romanzo-saggio allo pseudo-saggio ………………………………… 60
2. Pseudo-saggi dialogici: maschere del lettore ……………………………… 67
2.1. Il lettore esteta: Oscar Wilde ……………………………………………… 67
2.2. Giacomo Debenedetti: i personaggi della critica ………………………… 75
2.3. Marcel Proust: il dialogo interrotto ……………………………………… 85
2.4. Pseudo-saggio dialogico: critica e rappresentazione …………………… 96
3. Pseudo-saggi, quadri e cornici: l’autoritratto ……………………………… 99
3.1. Renato Serra: lo specchio lettoriale ……………………………………… 99
3.2. Danubio, Mississippi: cornici d’acqua …………………………………… 108
4. Il saggio romanzesco ………………………………………………………… 123
4.1. La spirale di Jean-Paul Sartre: totalizzazione di Flaubert ……………… 123
4.2. La critica trans-finzionale: Jean Améry …………………………………… 146
5. Il saggio parallelo: la competizione della riscrittura ……………………… 155
5.1. Indizi di testi fantasma …………………………………………………… 155
5.2. Roland Barthes, l’intertesto e Sarrasine …………………………………… 165
5.3. Giorgio Manganelli: il commentatore e Pinocchio ……………………… 178
6. Pseudo-saggi autobiografici:
la cultura letteraria come forma della vita ……………………………… 189
6.1. Pseudo-saggio e non-fiction statunitense ………………………………… 189
6.2. Lo pseudo-saggio autobiografico in Italia ………………………………… 210
Coda: il video essay, ovvero il saggio mediatizzato …………………………… 221
Bibliografia ……………………………………………………………………… 231
Pseudo-saggi ……………………………………………………………………… 231
Opere citate ……………………………………………………………………… 233
Avvertenza e ringraziamenti
Quando le note non indicano il contrario, le traduzioni delle opere let-
terarie straniere sono mie. Per quanto riguarda i saggi di letteratura se-
condaria, talvolta ho fatto ricorso a traduzioni italiane.
Il presente volume attinge dalle mie ricerche di dottorato e da altre
successive. Riprende pertanto alcuni autori e alcune analisi presenti nel-
la tesi discussa all’Università di Firenze nel 2013, sotto la supervisio-
ne di Ernestina Pellegrini, benché la struttura, le ipotesi e le conclusio-
ni siano completamente diverse. Altro materiale è stato rielaborato da
due articoli, The Hybrid Essay in Europe in the Late Nineteenth and
Early Twentieth Century, pubblicato nel numero monografico Nar-
ration and Reflection della rivista «Compar(a)ison. An International
Journal of Comparative Literature», n. 33, 2015, pp. 109-128, e Libri
paralleli: saggi critici e ibridazione narrativa (Barthes, Manganelli, La-
vagetto, Deresiewicz), uscito sulla rivista «Ticontre. Teorie Testo Tra-
duzione», n. 5, 2016, pp. 67-88.
Altri testi, punti di vista e suggerimenti sono sorti da alcune con-
ferenze e seminari di ricerca, tra cui Hybridization of Critical Essays.
Can the Essay and Theory Go Together?, presso l’American Compara-
tive Literature Association, all’Università di Harvard, nel marzo 2016;
L’utopie de l’hybridation critique: l’essai américain comme produit de
presse, in occasione del seminario L’hybride et la littérature all’Univer-
sità di Paris-Est Créteil nel marzo 2017, e Hybrid Textuality: the Me-
diatization of (Two) Metatexts, intervento al seminario Mix and Match.
Poéticas do hibridismo all’Università di Aveiro nel novembre 2018.
Ringrazio dunque Claude Coste, Vincent Ferré, Irène Langlet, Paulo
Pereira, Andy Stafford, Christy Wampole, per i loro suggerimenti e per
lo scambio avuto nel corso di queste occasioni. In merito a una riflessio-
ne che procede, pur con tante interruzioni, da circa dieci anni, non pos-
7
Pseudo-saggi
so che dichiarare il mio debito verso altri amici e colleghi sparsi in varie
parti del mondo, come Federico Bellini, Mimmo Cangiano, Achille Ca-
staldo, Alberto Comparini, Stefano Ercolino, Marco Gatto, Francesco
Giusti, Lorenzo Mari, Beatrice Seligardi. Ringrazio l’amico e collega
Riccardo Gasperina Geroni per la sua attenta lettura e le sue preziose
osservazioni durante la stesura di questo volume.
Il supporto dei miei genitori e la guida intellettuale di Donata Me-
neghelli hanno consentito ai miei pensieri di trovare questo approdo,
sempre in divenire. Elisa Pederzoli ha accolto il mio vasto peregrinare
in una nostra comune “casa della vita”.
8
Introduzione
Gli pseudobiblia sono libri “presunti, fittizi, immaginari ma che tutta-
via esistono, a volte come eredi di lontanissime e più o meno misterio-
se tradizioni, altre volte come creazione degli scrittori all’interno delle
proprie opere”1. Rientrano in questa categoria non solo i libri che sono
esistiti e che oggi sono perduti per sempre (ad esempio perché distrutti
o censurati), ma anche quelli che potrebbero esistere, e a cui si fa rife-
rimento in altri testi, oppure che vengono annunciati per il futuro e re-
stano, invece, allo stato di progetto2; ancora, sono da classificarsi come
pseudobiblia i libri immaginari e finzionali, come quelli evocati nell’e-
spediente del manoscritto ritrovato, e che costituiscono la materia nar-
rativa di altri libri. Due casi sono particolarmente famosi. Il riferimento
più antico è quello mitologico del Libro di Thoth, il cui autore sarebbe
l’omonimo dio egiziano che ha inventato la scrittura e l’ha trasmessa al
genere umano. In campo strettamente letterario, lo pseudobiblion più
eclatante è inventato da Howard Phillips Lovecraft con il Necronomi-
con, che si erge a supporto dei miti che popolano il suo immaginario
fantastico e che diviene vero e proprio oggetto di culto, nonché di fan-
tasiose recensioni ed edizioni in più lingue.
Nel quadro di questo lavoro, a noi interessa la categoria degli pseu-
dobiblia allorché essa comprende i libri “falsi”. Vediamo di precisarne
il senso. Jorge Luis Borges ha fatto invero dei libri stessi, e di alcuni
1 Michele Santoro, Leggere o non leggere (gli pseudobiblia), in «Biblioteche oggi»,
vol. 31, n. 8, 2013, p. 37. Vedi la ricca bibliografia di Paolo Albani e Paolo Della Bel-
la, Mirabiblia. Catalogo ragionato di libri introvabili, Zanichelli, Bologna 2003.
2 “A ogni svolta del libro, un altro libro, possibile e anche spesso probabile, è stato
respinto nel nulla. […] E questi libri dissipati l’uno dopo l’altro, rigettati a milioni
nei limbi della letteratura […] questi libri che non hanno visto la luce della scrittura,
in un certo modo contano, non sono completamente scomparsi. Per pagine e pagine,
per capitoli interi è il loro fantasma che ha trascinato in avanti lo scrittore, e lo ha
rimorchiato” (Julien Gracq, Lettrines, Éditions José Corti, Paris 1967, p. 27).
9
Pseudo-saggi
immaginari, i protagonisti di molti suoi testi. L’accostamento ad Al-
motasim (1936) è costruito attorno a un romanzo inesistente, ma il suo
intento non è quello di una creazione narrativa, bensì di una documen-
tata analisi del libro stesso e dei suoi effetti sui lettori. Quando Borges
si troverà, nel suo Abbozzo di autobiografia, a commentare quel suo
vecchio testo, userà la formula “è uno scherzo e uno pseudo-saggio allo
stesso tempo”3. Il prefisso pseudo designa un testo che è un’invenzione
a scopo ludico, ma sottoposto a un rigore critico tutt’altro che improv-
visato e apparente.
Il genere letterario considerato in questo volume preciserà, per pseu-
do, un significato diverso da quello di un testo fittizio, immaginario o
inventato. Gli pseudo-saggi sono scritture saggistiche che commentano
testi esistenti, che possono essere anche di natura romanzesca o poetica.
Eppure, pur non rinunciando alla responsabilità critica, gli pseudo-sag-
gi sono testi che appaiono falsificando, o meglio camuffando, il saggio
critico. Per tale ragione, il primo capitolo si premurerà di indicare i
punti in comune tra il genere del saggio e la forma che chiamiamo pseu-
do-saggio, determinando la possibilità del camuffamento e della trasfor-
mazione del saggio critico. Si individuerà così nella relazione critica e
metatestuale il nodo nevralgico per comprendere il processo di trasfor-
mazione che ci porta dal saggio critico allo pseudo-saggio.
Conviene innanzitutto precisare che non si tratta, per lo pseudo-sag-
gio, di una sintesi metaforica condotta al livello del suo nome di genere.
Eric Donald Hirsch illustra come per alcuni generi letterari, ad esempio
per il poem’s epic di Byron e il genere della tragicommedia, intervenga
un meccanismo metaforico nella formazione delle parole che combina
due termini diversi per indicare l’apparizione di un nuovo genere4. Si
tratta di un’operazione abbastanza diffusa nel discorso teorico lettera-
3 Jorge Luis Borges, “Abbozzo di autobiografia”, in Id., Elogio dell’ombra, Einaudi,
Torino 1998, p. 160. “Finge d’essere la recensione di un libro pubblicato per la prima
volta a Bombay tre anni prima. Dotai la falsa seconda edizione di un editore vero,
Victor Gollancz, e di una prefazione fatta da uno scrittore vero, Dorothy L. Sayers.
Ma tanto l’autore che il libro sono interamente di mia invenzione. […] Forse non ho
reso giustizia a quel brano; ora mi sembra che abbia presagito e sia perfino servito da
modello per gli altri racconti che in un certo modo mi attendevano, e sui quali si basa
la mia fama di scrittore di racconti” (ivi, pp. 160-161).
4 Eric Donald Hirsch, Validity in Interpretation, Yale University Press, New Haven
1967, p. 76. Si veda anche David Fishelov, Metaphors of Genre. The Role of Analogies
in Genre Theory, Pennsylvania State University Press, University Park (PA) 1993.
10