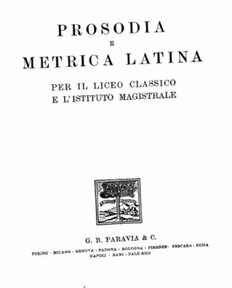Table Of ContentENRICO DI MARZO
PROSODIA
E
LATINA
METRICA
Opere curate da ENRICO DI MARZO
PER IL LICEO CLASSICO
Roma, viges. Antologia latina pn il Ginnasio Superiore
e le prime classi del Liceo Scientifico. E L'ISTITUTO MAGISTRALE
Prosodia e metrica latina. Per il Liceo Classico e
l'Istituto .Magistrale.
E. DI MARZO - C. CARAMELLO
Romana progenies. Antologia latina per il Ginnasio
Superiore.
G. B. PARAVIA & C.
TORINO. MILANO. GENOVA. PADOVA. BOLOGNA. FIRENZE· PESCARA. RO:r.IA
NAPOLI • BARI. PALERMO
SECONDA EDIZIONE - TRENTOTTESIMA RISTAMPA
PREFAZIONE
Il presente volume è dir iso in tre parti: la parte prosodica,
come preparazione indispensabile ad ulteriori indagini me
PROPRIETA' LETTERAHIA
triche (ed in essa vi sono delle novità, quali, ad esempio, il
richiamo di certe regole grammaticali, necessarie per la com
prensione e l'applicazione di altre regole prosodichc ,· il capi
Printed in ltaly
tolo riguardante la quantità delle sillabe interne delle furme
O verbali, ecc.),· la parte metrica, con le sue indispensabili no
1946 Paravia, Torino
zioni preliminari, e con l'esame dei singoli notissimi metri che
s'incontrano nei testi dei poeti latini che vanno lett-i nelle
Si ritengono contralfa tte le copie non firmate Scuole superiori,· infine la terza parte riguardante la metrica
o non munite del timbro della S. I. A. E. oraziana.
La trattazione è piana,· abbiamo bandito ogni frammen
taria erudizione che, secondo il nostro modesto giudi.zio, riesce
sempre inutile e non raggittnge lo scopo che un buon trattato
di prosodia e di rnet1·ica latica deve proporsi, quello, cioè, « di
porre il d·iscentc in condi.zioni di stabilire prontamente la
quantità della sWaba latina, individuare un metro, scompo
nendolo negli elementi costit·utivi, tracciandone la struttura,
sia che detto metro venga considerato isolatamente, sia in
aggruppamento con altri metri; riconoscere sen.za tituban.m,
una composi.zione poetica oraziana, scandendo e leggendo
metricamente i versi che la compongono».
Ogni capitolo del volume presenta degli esercizi pratici:
l'alunno, eseguendoli con pazienza ed amore, finirà col trovare
accessibile una via alquanto dura, e coll'interessarsi, forse,
allo studio della metrica. Parecchie tavole riassuntire corre
Società per Azioni G. B. Paravia & C .• 10139 Torino • Corso Racconigi, 16
dano il libro, chiare e lineari, che s'imprimeranno con sicura
70 (eA) 1974-16771 [205)
-IV-
traccia nello spirito del discente. Dopo l'esame delle singole
forme metr-iche oraziane, divise in composizioni monastiche
e nei sistemi distici, tetrastici ed ipermetri, chiude il volume
una tavola riassuntiva di tutta la metrica oraziana, tracciata
nei suoi caratteri essenziali, che farà orientare con sicurezza
il giovane studioso.
Se in questo volumetto ci sono delle manchevolezze (quale
libro ne è esente?), prego gli egregi Colleghi a volermele se
gnalare ed io sarò loro grato.
E. DI l\IARZO.
P .ARTE PRIMA
PROSODIA
- I;;, DI }IARZo, Prosodia t metrica latino.
§ l. - La parola r.pocrcp~(oc (da 7tp6ç, ad e <i>~~' cantus) fu
resa in latino con l'espressione: ad cantum, da cui si ebbe
accentua.
Il termine greco etimologicamente valse a significare l'ele
vazione della voce nel pronunziare la sillaba accentata; poi
. indicò la durata della pronunzia di ciascuna sillaba nel corpo
della parola; da ultimo significò l'insieme delle regole e dei
precetti che ci fanno conoscere la quantità delle sillabe, dalle
quali è formata una parola.
Noi intendiamo il vocabolo in quest'ultimo significato, sl
che ((la prosodia è la dottrina che studia la quantità delle sillabe
che compongono la parola >>,
CAPO I.
POESIA ACCENTUATIVA E QUANTITATIVA
A) Poesia accentuativa.
§ 2. - Leggiamo ad alta voce:
«Ne l mézzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una sélva osc1àa,
ché la diritta via era smarrita >>.
(DANTE, Inferno, c. I, v. 1-3).
Ciascuna di codeste righe contiene un verso endecasillabo,
cioè, di undici sillabe; alCune di dette sillabe sono accentate
-5-
-4-
6) il senario, che consta di sei sillabe, con accenti soli
o toniche, altre disaccentate o atone. Prova ne sia che se noi
tamente sulla seconda e quinta sillaba;
leggiamo uno dei tre versi, ad es.: il primo, calchiamo la voce,
7) il quinario, che consta di cinque sillabe, con un solo
quasi senza accorgercene, su la sillaba mé di mezzo, su la sil
accento fisso sulla quarta s llaba;
laba min di cammin, su la sillaba no di nostra e su la sillaba
8) il quadrisillabo, che consta di quattro sillabe, con un
vi di vita; vale a dire pronunziamo accentandole la seconda,
accento fisso sulla terza sillaba;
la sesta, l'ottava e la decim::t sillaba; all'incontro, pronun
9) il trisillabo, che consta di tre sillabe, con un solo ac
ziamo lievemente le rimanenti sillabe disaccentate, dette
cento sulla seconda sillaba.
atone, che compongono il verso prescelto.
I versi composti italiani più usati sono: l'ottonario doppio,
Questo svolgersi di suoni forti e di suoni deboli, questo
il settenario doppio, il senario doppio, il quinario doppio.
succedersi ad intervalli determinati di sillabe accentate e disac
centate, genera una certa piacevole musicalità, che accarez B) Poesia quantitativa.
zando l'orecchio, sviluppa una cadenza ritmica, la quale co
§ 4. - La poesia latina, diversamente dall'italiana, si basa
stituisce il principio formativo ed essenziale della poesia ita
soltanto sulla quantità delle sillabe che compongono il verso:
liana, che è detta, perciò, accentuativa, giacchè è basata sul
ossia, sulla durata di pronuncia, di ciascuna sillaba nel corpo
l'accento.
della parola. Il verso latino, come si vedrà più innanzi, non
L'accento governa non soltanto il verso italiano endeca
tiene affatto conto del numero delle sillabe che lo compongono.
sillabo, ma anche tutti gli altri versi semplici e composti,
usati nella nostra lingua.
Cenni intorno all'origine della poesia quantitativa
Versi accentuativi italiani semplici e composti. ed accentuativa.
§ 5. - È da sapere che i Romani furono soliti distinguere
§ 3. - I versi semplici italiani sono:
le sillabe componenti una parola, in due specie o categorie:
l) l'endecasillabo, che consta di undici sillabe, con ac
lu7:tghe e brevi, a seconda della durata di tempo che essi impie
centi forti, sulla quarta, ottava e decima sillaba (ovvero:
gavano nel pronunziarle, come si vedrà più innanzi. La sil
sulla sesta e decima sillaba; ovvero: sulla quarta, settima e
laba lunga, sia. in prosa che in poesia, era pronunziata lenta
decima sillaba, ecc.);
mente; la sillaba breve, celermente. Con l'andare del tempo
2) il decasillabo, che consta di dieci sillabe, con tre ac
accadde che tale distinzione di brevità e di lunghezza delle
centi forti, sulla terza, sesta e nona sillaba;
sillabe nel corpo delle parole, andò sempre più attenuandosi
3) il novenario, che consta di nove sillabe, con tre ac
nella lingua parlata, sino a che non se ne tenne più conto:
centi forti, sulla seconda, quinta e ottava sillaba;
all'incontro, tale distinzione si conservò e rimase nella poesia
4) l'ottonario, che consta di otto sillabe, con accenti
che, come si è detto, si basò unicamente sulla qnantità delle
forti sulla terza e settima sillaba (ovvero: sulla seconda,
' sillabe formanti il verso.
quinta e settima sillaba; ovvero: sulla seconda, quarta e set-
In quanto all'origine della poesia accentuativa italiana,
tima sillaba);
gli studiosi unanimemente ammettono che essa derivi dalla
5) il settcna rio, eh e consta di sette sillabe, con due ac
poesia latina. Ma come mai dalla poesia quantitativa si passò
centi forti, sulla sesta e su una delle prime quattro sillabe;
-6- -7-
alla poesia accentuativaY Pare che ciò i'!ia derivato da una l) Una vocale seguita da un'altra vocale, eccetto cho
lenta e graduale trasformazione della prima. È noto, infatti, non formi dittongo, fa sillaba a sè: de-a, pi-e. All'incontr<>:
che nel secolo IV circa dopo Cristo il senso della quantità andò poe-na, Oae-sar.
a poco a poco estinguendosi nella poesia latina, e si fini, in 2) Una consonante posta fra due vocali appartiene alla
seguito, col badare soltanto al ritmo risultante dal numero sillaba seguente: pa-nis, ma-ter.
determinato delle sillabe e dalla successione degli accenti che
3) Di due consonanti uguali, la prima va con la sillaba
coincisero con gli accenti grammaticali. Non si può stabilire
precedente e l'altra con la seguente: ter-ra, an-nus.
con precisione quando finisca la poesia quantitativa ed inco·
4) Una consonante muta (c, p, t, g, b, d) seguita da una
minci la accentuativa. Alcuni inni della Chiesa ed i cosi detti
liquida (l, r) forma con quest'ultima un gruppo inseparabile:
canti goliardici, per non citare altre poesie dell'età medioevale,
a-gri-co-la, te-ne-brae.
sono regolati ad un tempo dal ritmo e dalla quantità, cioè,
dal ritmo quantitativo-accentuativo 1• 5) Se fra due vocali c'è un gruppo di due o più conso
nanti con le quali può cominciare la parola latina, queste
fanno parte della sillaba seguente: e-sca, a-strum, scri-psi.
CAPO II. 6) Le parole composte sono separate nelle parti com
ponenti: ad-eo, prae-mo-ve-re.
NOZIONI PRELIMINARI INTORNO ALLA SILLABA LATINA
7) Il gruppo ps appartiene alla sillaba seguente: nu-psi;
E ALLA SUA QUANTITÀ il gruppo mn nelle parole derivate dal greco appartiene alla
sillaba seguente: Le-mnos, ma nelle parole latine d'ordinario
A) La sillaba latina.
si divide: om-nis.
§ 6. - Comunemente intendiamo per siilaba l'articolazione
o il gruppo fonetico, che si pronunzia con una sola emissione O) Sillabe aperte e chiuse.
di fiato. Anche in latino la sillaba può talora essere costituita
da una semplice vocale o da un dittongo. § 8. - Le sillabe latine si distinguono in aperte e chiuse,
Sono aperte quelle che terminano per vocale: ro-sa, fe-ro.
B) Divisione delle sillabe latine nel corpo della S~o chiuse quelle che terminano per consonanti: car·men,
parola. tem-pus.
§ 7. - Le sillabe latine nel corpo della parola generalmente
vengono divise come nella lingua italiana. C'è da osservare D) Quantità delle sillabe latine.
le seguenti regole fondamentali:
§ 9. - Secondo la durata o la quantità le sillabe latine
possono essere brevi, lunghe, ancipiti, a seconda che le vocali
ra.turl aI nd i teRmopmia n ionntr mavoildteor olo nnetal npi.i ùa lacnutnici oil lvuesrtsroi sltautidnioos, ii ld esclllatu rlinniog,u au ne vdeerlslao lseitltlea · che le formano siano brevi, lunghe o ancipiti 1•
bico accentuativo, formato di cinque parole, divise in due emistichi, con tre o due a) Dicesi sillaba breve quella che ha la durata di un
accenti; se tale ipotesi fosse stata provata, si sarebbe potuto conchiudere che la
tempo primo, cioè, quella che si pronunzia in un solo tempo.
primissima. poesia. latina. sarebbe stata accentuativa: se non che, alcuni valenti
studiosi moderni hanno sostenuto con validi argomenti la scansione quantita.tiva
di questo antichissimo verso e la sua derivazione da schemi lirici greci. (Cfr. Leo,
l Quando parliamo di vocali brevi, lunghe, ancipiti, non intendiamo già parlare
Pasquali, ecc.).
delle sole vocali, ma. di tutta la sillaba., cui la vocale o.ppartiene.
-8- -9-
A chiarimento di quanto diciamo è da sapere che la durata c) le parole polisillabe hanno l'accento tonico:
di un tempo primo, presso i Romani, non era affatto deter l) sul l a penultima, se questa e' l unga: infi,d us, per-
minata da frazione di minuto, ma era lasciata all'arbitrio di muto, praedamnare;
chi parlava o di chi leggeva. Un tempo primo poteva durare
2) sulla terzultima, se la penultima è breve: célere,
uno o più secondi: tuttavia i Romani osservavano sempre il
malédicus, infero;
rapporto di durata tra sillaba breve e sillaba lunga, e questa
ultima aveva sempre una durata doppia di tempo della sil d) l'accento tonico non cade mai oltre la terzultima
laba breve. sillaba (legge del trisillabismo): infidélitas, infirmitas, ecc.
NOTA. -a) Quando le enclitiche que, ve, ce, ne, pte si attaccano
Si suole indicare la sillaba breve con un semicerchio che ad una parola, l'accento tonico cade sempre sulla sillaba che le
va posto sopra la vocale che la forma (v): terra, poeta. precede, anche se questa sia breve: cura (nom, e voc. ), cuTaque
(nom. e voc.).
b) Dicesi sillaba lunga quella che ha una durata di tempo
doppia della breve, cioè, quella che si pronunzia in due tempi b) Quando l'enclitica que perde il suo valore copulativo (que
=el) dando origine ad una parola composta, l'accento si regola
primi. La sillaba lunga è indicata con una linea orizzontale secondo le norme generali: itdque = et ita = e così; ma si dirà:
sulla vocale o dittongo che la forma (-): iimplus, a,uriga. undique = da ogni parte, iMnique = finalmente. Tale uso è spesso
trascurato da noi moderni; noi diciamo più spesso armiique invece
c) Dicesi sillaba ancipite (da anceps: amb e caput, con
di armaque, come sarebhe più preciso, secondo le sopra ci~ate regolo;
due teste, doppio) quella che viene considerata ora breve ed CUraque (nom. e VOC. sing.) e Ourt.<Ji'6 (abJ. sing.).
ora lunga. Per indicare una sillaba ancipite si collocano i due
segni su accennati sopra la vocale che la forma ('=:'): voliicris,
tcnebrae. ESERCIZIO l.
Si scompongano nelle loro sillabe foTmative le paTole seguenti,
E) Rapporto fra l'accento tonico e la quantità e si precisi se la sillaba finale di ciascuna paTola sia aperta o
delle sillabe. chiusa:
Venio - credere - expositus - quoque - adt.tare - nut,rix
§ 10. - L'accento tonico non è affatto legato alla quan
- scripserant - Luperei - 1\lars - constitit - arbor - ambo
tità delle sillabe; esso può cadere tanto sulle sillabe brevi
- patria - poena - poenitentia - coelicola - taedium - coelum
quanto sulle lunghe. In un solo caso l'accento tonico coincide
- amor - amans - praeficio - tenebrosus - infandum - tuus -
con la quantità della sillaba, e cioè, nelle parole polisillabe,
faber - praesim - corripio - discumbere - relucet - quaestio
quando la penultima sillaba è lunga: N eptunus, timére.
- quantum - excurro - decidunt - lenimen - pauxillus - sex
In quanto alla posizione dell'accento tonico si possono
angulus - pedcster - tennis - tradere - discolor - Roma -
fissare le seguenti leggi:
torridus - Sulmo - volucris - tenebrarum - abstinens - abs
a) le parole monosillabe, tmnne le enclitiche e le procli
tinentia - contineo - continuus - pertinacia - obtinueram
tiche, hanno l'accento tonico su se stesse: fans, réx, p6ns, mé;
- contentus - exprobro - patraverant - administrare - per
b) le parole bisillabe hanno l'accento t(mico sulla penul! Iucidus - collustrant - illuminari - auferunt - differt - pro
tima sillaba, sia essa lunga o breve: prcfztor, pater; tulit - transtulero - rettulit - antepono - perturbatum -
-IO- -Il-
respondens - perutilis - Psammetichus - scripserunt - pu
blicus - publicatio - pulsatio - reptatio - Samnis - Samnium
- sarcinae- strigmentum - omnipotens - omnimodis - Lemnias CAPO III.
- trimestris - cycnus.
QUANTITÀ DELLE SILLABE LATINE PER NATURA
E PER POSIZIONE
ESERCIZIO 2.
Le sillabe latine possono essere brevi o lunghe per natura
Si segni l'accento tonico nelle parole seguenti: e per posizione.
Undique - omniaque - denique - deque - suopte -·
dixeruntne - celerisque - bice - huncine - hoce - itaque ( = et A) Quantità delle sillabe per natura.
ita) - itemque (avv.) - musaque (nom. e voc.) - rex - par
§ 11. - Sono lunghe per natura:
- plus - cor - mel - cunctaque (nom. e voc.) - suapte (abl.)
- plusve - minusve - crudelitas - feritas - pater - mater - l) le sillabe formate da dittonghi: Caesar, curae, poena,
fulgidus - terribilis - innocentissimus - infirmissima (nom.) taedium, coelum. (Si eccettua il dittongo di prae dinanzi a vo
- munitissimum - eripio - erogatio - errabundus - fataliter cale: prae-erat; ma dinanzi a consonante rimane lungo: prae
- fatuitas - feretrum - fidicina - foedifragus - formositas - mium - Cfr. § 14, Nota 1);
gratulor - gubernaculum - gustavimus - herbosus - bine -
2) le sillabe formate da vocali derivanti da contrazione
hippodromos - hirundinis - hoc - humanitas - iactans -
o da un originario dittongo: tibicen (da tibiicen), mi (da mihi),
eademque (nom.) - identidem - ignipotens - illacrimabilis -
di (da dii), cogo (da coago), includo (da in e claudo), ecc ...
imaginor - imago - immobilis - impatiens - impotens - im
puritas - intercido - libamen - lucubro - manus - mergimur NOTA. - Per riconoscere la quantità delle altre sillabe brevi o
- morbus - mons - obloquor - octogiens - oculus - omissum - lunghe per natura, i grammatici non hanno fissato altre regole,
all'infuori delle anzidette. Ed allora bisognerà ricorrere ad un buon
omniparens - pactum - peculiariter - pecudis - pergravis -
dizionario prosodico, quale, ad esempio, la Regia Parnassi.
poenaque (abl.) - praeceps - praeceptor - provoco - qui - Sovente la posizione dell'accento tonico fa da guida nella cono
quies - reddidimus - reditus - sal - sagaciter - scalptum - scenza della quantità di una sillaba. Se esso, ad esempio, cade
seges - semita - spes - telum - temere - tempestivitas - vas sulla terzultima sillaba, la penultima è breve: tim~dus, amabilis;
d'altra parte, nelle parole plurisillabe se cade sulla penultima sil
- velox - veneficus - viscera - vis - vox - vultus - zephyrus
laba, questa è lunga: conticuére, terrénus.
- zonula - lucifer - deditus - finitimus - magnanimitas -
- necessitas - innumerus - commodum.
B) Quantità delle sillabe per posizione.
§ 12. - Una vocale di natura breve, formante sillaba, può
trovarsi in posizione forte o debole.
'C!r. l'antica regola: • Dipbtbongus longa est iu graeeis atque latlnls;
• Prae rape praepositam vocali dieque praeustu!! •·
-!:l- - 13-
a) Si dice che una vocale è in posizione forte, quando come in s·apra, vol1Jcres (mentre si dirà laràcrum. salubris, ec!'.,
viene a trovarsi: giacché la vocale è di natura lunga, essendo derivate queste parole
da laràre, .~alus ... );
1) dinanzi a due o più consonanti: dictus, sancta;
b) La vocale a di acer è lunga e rimane sempre tale: àcris ...
2) dinanzi a consonante composta (x, z): gaza, exitus;
3) dinanzi a consonante finale di parola, cui segue § U. - Una \'Ocale seguita immediatamente da m~'altra
un'altra consonante iniziale di a:tra parola: sub monte. vocale è breve, anche se sia interposta la h, che non conta:
NoTA. - a) Il gruppo qu è consonante semplice, e però non erudio, arduus, nihil 1•
fa posizione: liiquor, iiqua l.
b) La Il non fa posizione, perchè non è considerata consonante: ECCEZIONI. - Sono lunghe:
inhumanus, dixit homo. 1) la e della terminazione ei del genitivo e dativo sin·
c) La i ( = j) che sta a principio di parola ed è seguita da vo golare della 5"' declinazione, quando è preceduta da vocale:
cale, è consonante, e come tale, quando è preceduta da altra conso
diei, aciei (non preceduta da vocale è regolarmente breve:
nante, fa posizione: àdiuvo, sub Jove.
spei, rei);
d) La i fra due vocali ( = j), e che suole essere resa in italiano
con gg, viene considerata consonante doppia, e. per c?nseguenza 2) l'a e l'e nel vocativo singolare dei nomi propri in
la vocale che la precede è lunga: rnàior = maggwre. S1 eccettua: aius ed eius: Gai, Pompei;
biiugus, t1.,'iiugus, quadriiugus, nelle quali la prima i resta b~eve,
considerandosi la i di iugum, solo in composizione, come semplice 2• 3) l'i di fio nelle forme senza r: fiebam (ma fieri, fierem ... ,
ecc.);
b) Si dice che una vocale è in poszzwne debole, quando
viene a trovarsi dinanzi a due consonanti, delle quali la prima 4) l 'i della desinenza ius del gen. sing. dei pronomi della
za
è muta (c, p, t, g, b, d) e l'altra è liquida (l, r). declinazione, che originariamente era lungo: illius, solius,
unius. (Nei poeti è usata anche come breve, tranne in alius);
§ 13. - Una sillaba che è in posi.zione forte è lunga 8• 5) l'a del genitivo arcaico singolare della l"' declin.:
Una sillaba che è in posizione debole in poesia è ancipite, auliii (sta per aulae). Nei nomi greci le vocali conservano la
in prosa è breve '· quantità originaria: Darius, Academia;
6) la e dell'interiezione eh eu.
NOTA. - a) Per considerare ancipite una sillaha non basta che
Ja vocale sia seguita da muta e da liquida, è necessario cl1e le due
consonanti formino la stessa sillaba. come avviene nP-lla parola NOTA. - Si ricorùi che il dittongo di prae seguito da vocale,
nelle parole composte, è breve: praeustus, pmealtus, e che la i di
ten~-brac (non così in ob-latum ... ), e che la vocale sin. di natura breve,
Diana è ancipite.
Si ricordi, altreBÌ, che la i ( = j) che sta a principio di parola
l Si ricordi che la u è considerata come consonante dopo q e o e, come tale, ed è seguìta. da vocale, ha. valore di consonante semplice: iugerum
non fa sillaba di per sè: quo-que, san~guis; mentre è vocale negli aggettivi in -uuu• (Cfr. § 12, Nota, e).
e nei perfetti in -gui, nei qu::lrli fa siJlaba di per sè: exigu~us, vigu-i.
21 Cfr. l'antica regola: « (..)uach•iingus rapitur. biiugus coniungitur illi.
• J n quihus i duylli.'X non est, sed consona shnples: •·
8 crr. rantica regola: • Vocalis Ionna est, si consona bina sequantur •· .. 1 Cfr. l'antica rell'ola: • Vocal~m breYiant, alia subeun~t·, Latini
'C!r. l'antica regola: • Coutrahit m·ator, variant in carmine vates,
, si 1nutarn Jiquillamque sirnul brevis una praeiblt ••