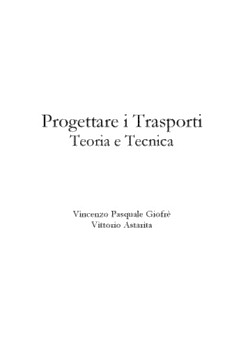Table Of ContentProgettare i Trasporti
Teoria e Tecnica
Vincenzo Pasquale Giofrè
Vittorio Astarita
Copyright © 2019 Vincenzo Pasquale Giofrè e Vittorio Astarita
All rights reserved.
ISBN 10: 1530204488
ISBN-13: 978-1530204489
SOMMARIO
1. PARTE I ......................................................................................................... 1
1.1. LE VARIABILI DEL DEFLUSSO VEICOLARE E LE RELAZIONI CHE LE
LEGANO ............................................................................................................ 1
1.1.1. VARIABILI MICROSCOPICHE E MACROSCOPICHE .......................... 1
1.1.2. LE VARIABILI MACROSCOPICHE ..................................................... 2
1.1.3. RELAZIONI FRA LE VARIABILI MACROSCOPICHE ............................ 4
1.1.4. MISURA DI DENSITÀ, VELOCITÀ E PORTATA PER UN PLOTONE .... 5
1.1.5. MODELLI MICROSCOPICI E MACROSCOPICI .................................. 8
1.1.6. L'ANALOGIA FLUIDODINAMICA ED I MODELLI CONTINUI ............. 9
1.1.7. EQUAZIONE DI CONTINUITÀ.......................................................... 9
1.1.8. STAZIONARIETÀ ED OMOGENEITÀ .............................................. 10
1.1.9. ESEMPI ......................................................................................... 11
1.2. I MODELLI DI DEFLUSSO MACROSCOPICI DESCRITTIVI ....................... 13
1.2.1. MODELLO LINEARE DI GREENSHIELDS ........................................ 15
1.2.2. MODELLO LOGARITMICO DI GREENBERG ................................... 16
1.2.3. MODELLO DI UNDERWOOD ........................................................ 17
1.2.4. MODELLO A CAMPANA DI MAY .................................................. 18
1.2.5. ALTRI MODELLI ............................................................................ 19
1.2.6. IL MODELLO MACROSCOPICO CONTINUO DI LIGHTILL E
WHITHAM .................................................................................................. 20
1.2.7. IL MODELLO "CELL-TRANSMISSION MODEL" DI DAGANZO ........ 35
1.3. I MODELLI MICROSCOPICI E LA TEORIA DEL CAR-FOLLOWING ........... 39
1.3.1. I PRINCIPI ALLA BASE DELLA TEORIA DEL CAR-FOLLOWING ........ 41
1.3.2. FORMULAZIONE GENERALE DELLA TEORIA PARAMETRI
NUMERICI DI COMPORTAMENTO ............................................................. 44
1.3.3. LA STABILITÀ DEL DEFLUSSO VEICOLARE .................................... 45
1.3.4. CORRISPONDENZE FRA LA TEORIA DEL CAR-FOLLOWING E LE
FUNZIONI DI DEFLUSSO CONTINUO .......................................................... 53
Vincenzo Pasquale Giofrè e Vittorio Astarita
1.4. MODELLI MACROSCOPICI E MODELLI CONTINUI DERIVATI DAL CAR-
FOLLOWING ................................................................................................... 62
1.4.1. UN PRIMO MODELLO SEMI-DETERMINISTICO ............................ 63
1.4.2. MODELLI DI EQUILIBRIO DETERMINISTICO ................................. 65
1.4.3. MODELLO DI PAYNE .................................................................... 66
1.4.4. MODELLO DI ROSS ...................................................................... 67
1.4.5. LA TEORIA CINETICA DEL TRAFFICO VEICOLARE ......................... 67
1.5. SOLUZIONE DEI MODELLI CONTINUI CON METODI NUMERICI .......... 70
1.5.1. LA SOLUZIONE DEL MODELLO DI LIGHTILL E WHITHAM CON
METODI NUMERICI .................................................................................... 70
1.5.2. METODO A CORREZIONE DI FLUSSO PER LA SOLUZIONE
NUMERICA DEL MODELLO DI LIGHTILL E WHITHAM ................................ 73
1.6. INTERAZIONE GUIDATORE-VEICOLO-STRADA .................................... 89
1.6.1. IL VEICOLO................................................................................... 89
1.6.2. LA STRADA................................................................................. 101
1.6.3. LA CIRCOLAZIONE...................................................................... 128
2. PARTE II ................................................................................................... 137
2.1. MODELLIZZAZIONE DEL TRAFFICO .................................................... 137
2.1.1. IDENTIFICAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO E DI STUDIO ..... 138
2.1.2. SUDDIVISIONE DELL’AREA DI STUDIO IN ZONE ......................... 139
2.1.3. ANALISI DELL’OFFERTA ............................................................. 139
2.1.4. ANALISI DELLA DOMANDA ........................................................ 141
2.1.5. MODELLI MATEMATICI ............................................................. 159
2.1.6. ESEMPIO – Funzionamento dei modelli di Car Following ......... 178
2.1.7. ESEMPIO – Modellizzazione ...................................................... 182
2.2. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE .................................... 188
2.3. TECNICHE DI CALIBRAZIONE DEI MODELLI ....................................... 207
2.3.1. CALIBRAZIONE CON METODI SEMPLICI PER LA RICERCA DEL
MINIMO ERRORE ..................................................................................... 210
iv
PROGETTARE I TRASPORTI
2.3.2. CALIBRAZIONE CON GLI ALGORITMI GENETICI ......................... 216
2.3.3. CALIBRAZIONE CON IL METODO STATISTICO SPSA ................... 225
2.4. ELEMENTI DI BASE DI TEORIA DELLE CODE ....................................... 229
2.4.1. POISSON E ESPONENZIALE NEGATIVA ....................................... 229
2.4.2. USO DELL'ESPONENZIALE NEGATIVA ........................................ 231
2.4.3. PROCESSI STOCASTICI ................................................................ 239
2.4.4. CLASSIFICAZIONE DI ALCUNI PROCESSI CASUALI ...................... 239
2.4.5. SISTEMA DI CODA AD UN CANALE CON ARRIVI POISSONIANI E
TEMPI DI SERVIZIO ESPONENZIALI ........................................................... 244
2.4.6. CALCOLO DI ALCUNE STATISTICHE PER CODA AD UN CANALE
CON ARRIVI POISSONIANI E TEMPI DI SERVIZIO ESPONENZIALI (M/M/1)
248
2.4.7. CODA AD M CANALI: TEMPI DI SERVIZIO ESPONENZIALI CON
ARRIVI POISSONIANI (M/M/M) ............................................................... 249
2.4.8. (M/M/1/K) CODA AD UN CANALE CON NUMERO DI UTENTI IN
CODA LIMITATO ....................................................................................... 251
2.4.9. M/M/M/M: CODA A M CANALI CON PERDITA DELL'UTENTE DA
PORRE IN ATTESA ..................................................................................... 252
2.4.10. M/M/1//M: CODA AD UN CANALE CON NUMERO FINITO DI
UTENTI 253
2.4.11. ESEMPIO ABITUDINI GUIDATORE ............................................ 254
2.4.12. ESEMPIO ABITUDINI GUIDATORE ............................................ 254
2.4.13. ESEMPIO VENDITORE .............................................................. 255
2.4.14. ESEMPIO RICERCATRICE E DUE OMBRELLI .............................. 257
2.4.15. ESEMPIO RICERCATRICE E TRE OMBRELLI ............................... 259
2.4.16. ESEMPIO RICERCATRICE N-OMBRELLI ..................................... 261
2.4.17. ESEMPI METODO MONTECARLO E SIMULAZIONE .................. 262
2.4.18. ESEMPI SISTEMI DI CODA M/M/1 ........................................... 267
2.4.19. ESEMPI CATENE DI MARKOV CONTINUE................................. 273
2.4.20. ESEMPI CASELLI STRADALI....................................................... 277
v
Vincenzo Pasquale Giofrè e Vittorio Astarita
3. PARTE III .................................................................................................. 281
3.1. LIVELLI DI SERVIZIO ........................................................................... 281
3.1.1. AUTOSTRADE EXTRAURBANE ................................................... 283
3.1.2. STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE ....................................... 288
3.1.3. INTERSEZIONI NON SEMAFORIZZATE ....................................... 295
3.1.4. INTERSEZIONI SEMAFORIZZATE ................................................ 309
3.2. PROGETTAZIONE DI ELEMENTI DEL TRAFFICO ................................. 316
3.2.1. SEMAFORI ................................................................................. 316
3.2.2. LE ROTATORIE ........................................................................... 328
3.2.3. LE ZONE DI SCAMBIO ................................................................ 373
3.2.4. LE RAMPE .................................................................................. 386
4. BIBLIOGRAFIA .......................................................................................... 413
ABOUT THE AUTHOR ........................................................................................ 421
VINCENZO PASQUALE GIOFRÈ ..................................................................... 421
VITTORIO ASTARITA ..................................................................................... 422
vi
1. PARTE I
1.1. LE VARIABILI DEL DEFLUSSO VEICOLARE
E LE RELAZIONI CHE LE LEGANO
Quanto presentato in questo capitolo sebbene rappresenti alcune delle
nozioni di base fondamentali per lo studio del deflusso veicolare non è stato
sempre patrimonio degli ingegneri del traffico e degli studiosi dell'argomento.
L' articolo di Wardrop (1952): Some theoretical aspects of road traffic
research, fondamentale per molti aspetti, ha chiarito molti dei concetti qui
sotto esposti e permesso all' ingegneria del traffico di svilupparsi su delle basi
teoriche più rigorose. In seguito Edie (1963) ha fornito ulteriori
approfondimenti in materia di definizione delle variabili per un plotone di
veicoli nel suo articolo: Discussion of traffic stream measurements and
definitions. Si rimanda inoltre al volume Traffic Flow Theory and Control di
Drew (1968) e al completo Traffic Flow Theory (Gerlough e Huber 1975)
per ulteriori approfondimenti su un argomento che non dovrebbe
sorprenderci con nessun ulteriore avanzamento scientifico. Possiamo
distinguere le variabili del deflusso in microscopiche e macroscopiche.
1.1.1. VARIABILI MICROSCOPICHE E
MACROSCOPICHE
Le variabili microscopiche del deflusso veicolare sono quelle che
caratterizzano il deflusso del singolo veicolo, o meglio della coppia veicolo-
guidatore. Alcune di esse sono dipendenti dal tempo: la posizione, la velocità
l'accelerazione ed inoltre i distanziamenti spaziali e temporali fra i veicoli.
Altre sono costanti nel tempo: la categoria del veicolo e il tipo di utente-
1
Vincenzo Pasquale Giofrè e Vittorio Astarita
guidatore, che influiscono su altre caratteristiche del moto del veicolo quali
la velocità e l'accelerazione massima, il tempo di arresto minimo ecc. Tutte
queste variabili microscopiche del deflusso veicolare contribuiscono nel loro
insieme a formare una portata veicolare. La difficoltà di conoscere e di
operare su un così elevato numero di dati ha portato ad approcci al problema
di tipo macroscopico, basati sostanzialmente su variabili aggregate e mediate.
Caratteristiche del guidatore:
Tempo di percezione
Tempo di reazione
Angoli e distanze visive
Stile di guida (tendenza al sorpasso, velocità media ecc) in
funzione delle caratteristiche Geometrico-ambientali
Caratteristiche del veicolo:
Dimensioni e angoli di sterzata
Potenza, peso, freni, rimorchi
Età e condizioni del veicolo
Caratteristiche geometriche ed ambientali:
Caratteristiche e tipologia del tratto stradale (viadotto, galleria,
strada urbana,ecc)
Pendenza e curvatura
Larghezza corsia
Presenza disturbi (sosta, passi carrabili e pedonali, ecc)
Caratteristiche e condizioni del manto stradale
Periodo dell’anno e condizioni meteorologiche
Paesaggio limitrofo
1.1.2. LE VARIABILI MACROSCOPICHE
Tre sono le principali variabili macroscopiche rappresentative del deflusso
veicolare: Q, ρ e V, rispettivamente portata, densità e velocità. La definizione
di queste variabili macroscopiche non è univoca ed immediata come nel caso
delle variabili microscopiche, ma è possibile avere diverse definizioni,
conseguenza di diversi modi di aggregare e mediare le variabili
microscopiche. In un dominio spazio-tempo X-T si definiscono:
∑𝑁 𝑑𝑥 ∑𝑁 𝑑𝑡 ∑𝑁 𝑑𝑥
𝑖=1 𝑖 𝑖=1 𝑖 𝑖=1 𝑖
𝑉 = ; 𝜌 = ; 𝑄 =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ∑𝑁 𝑑𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑋∗𝑇 𝑋∗𝑇
𝑖=1 𝑖
dove:
dxi = distanza percorsa dal veicolo i nel dominio X-T
dti =tempo di presenza del veicolo i nel dominio X-T
2
PROGETTARE I TRASPORTI
N = numero di veicoli che attraversano il dominio X-T
Il dominio X-T è generalmente un dominio rettangolare che può
degenerare in un rettangolo allungato:
secondo l'asse t nel caso di misurazione in una sezione x,x+dx in un
tempo comunque lungo T. È questo il caso pratico di misura effettuata
puntualmente, per cui di ogni veicolo si registra il passaggio ed il tempo
necessario a percorrere la distanza piccola dx. Si ha, a causa del piccolo valore
di X=dx, che tutti i veicoli percorrono la stessa distanza dx, (vero solo se
all'istante iniziale t1 ed all'istante finale t2 tali che t2-t1=T non è presente
nessun veicolo sul tratto). Lightill e Whitham (1955) hanno fornito una
definizione precisa di portata e concentrazione ad un punto x e ad un tempo
t dando istruzioni su come misurarle si ha:
𝑁∗𝑑𝑥 ∑𝑁 𝑑𝑡 𝑁
𝑖=1 𝑖
𝑉 = ; 𝜌 = ; 𝑄 =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ∑𝑁 𝑑𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑥∗𝑇 𝑇
𝑖=1 𝑖
Domini rettangolari per il calcolo di densità, portata e velocità
La velocità media così ottenuta è la media armonica delle velocità
istantanee puntuali dei veicoli.
Secondo l'asse x nel caso di misurazione su un tratto x,x+X in un tempo
piccolo dt. Dal punto di vista pratico tale misura si può avere con due
fotografie del tratto X prese agli istanti t e t+dt, dalle quali è possibile stabilire
la distanza percorsa da ogni veicolo. Si ha in questo caso a causa del piccolo
valore di T=dt, che tutti i veicoli spendono lo stesso tempo dt nel dominio
X-T, (vero solo se nessun veicolo attraversa le sezioni x e x+X durante il
3
Vincenzo Pasquale Giofrè e Vittorio Astarita
tempo dt), quindi:
∑𝑁 𝑑𝑥 𝑁 ∑𝑁 𝑑𝑥
𝑖=1 𝑖 𝑖=1 𝑖
𝑉 = ; 𝜌 = ; 𝑄 =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑁∗𝑑𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑋 𝑋∗𝑑𝑡
La velocità media così ottenuta è la media aritmetica delle velocità
istantanee puntuali dei veicoli.
1.1.3. RELAZIONI FRA LE VARIABILI
MACROSCOPICHE
Wardrop (Wardrop 1952) è stato il primo ad ottenere la relazione che lega la
media armonica delle velocità (Space mean speed = n/(Σ1/vi)) con la media
aritmetica (Time mean speed = Σv/n). La media aritmetica è una media delle
i
velocità puntuali pesata con un peso per ogni valore v. La media armonica è
i
invece la media delle velocità puntuali pesata con un peso:
1
𝑣
𝑓′ = 𝑖
𝑖 1
∑
𝑣
𝑖
Si ha:
𝑛
𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 = 𝑣̅ = ∑𝑓′∗𝑣
𝑠 𝑖 𝑖
𝑖=1
𝑛
𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 = 𝑣̅ = ∑𝑓 ∗𝑣
𝑡 𝑖 𝑖
𝑖=1
Si può scrivere quindi:
𝑛 𝑛 𝑛
∑𝑛 𝑣 𝑣 𝑣2
𝑖=1 𝑖 𝑖 𝑖
𝑣̅ = ∑𝑓 ∗𝑣 = = ∑ = ∑ =
𝑡 𝑖 𝑖 𝑛 𝑛 𝑣 ∗𝑛
𝑖
𝑖=1 𝑖=1 𝑖=1
𝑣2
𝑛 𝑖
𝑣
= ∑ 𝑖 =
1 𝑛
∑𝑛 ∗
𝑖=1 𝑖=1𝑣 1
𝑖 ∑𝑛
𝑖=1𝑣
𝑖
𝑛 𝑛
𝑣2 [𝑣̅ +(𝑣 −𝑣̅)]2
= ∑𝑓′∗ 𝑖 = ∑𝑓′∗ 𝑠 𝑖 𝑠 =
𝑖 𝑣̅ 𝑖 𝑣̅
𝑠 𝑠
𝑖=1 𝑖=1
𝑛 𝑛
𝑣̅2 (𝑣 −𝑣̅)2 𝜎2
= ∑𝑓′∗ 𝑠 +∑𝑓′∗ 𝑖 𝑠 = 𝑣̅ + 𝑠
𝑖 𝑣̅ 𝑖 𝑣̅ 𝑠 𝑣̅
𝑠 𝑠 𝑠
𝑖=1 𝑖=1
dal momento che:
4