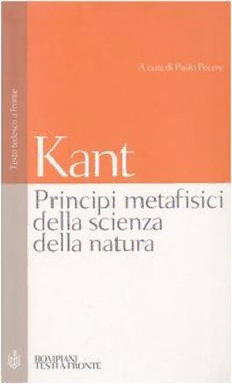Table Of ContentTm manuel Kant
Principi metafisici
della scienza
della natura
Testo tedesco a fronte
lntroduzione, traduzione,
note e apparati di
Paolo Pecere
1JiJ BOMPTANT
~ TESTI AF RONTE
TSBN 88-452-9256-8
© 2003 R.C-5. Libri S.p.A., Milano
I edizione Bompiani Testi a fronte settembre 2003
INTRODUZIONE
§ 1 - L'idea di una nuova metafisica: "metafisica
della natura" e filosofia trascendentale
I Principi metafisici della scienza della natura, com
parsi nel 1786, si inserivano esplicitamente nel disegno
di un sistema della filosofia che Kant aveva tracciato
nella Critica della ragion pura.I Secondo questo piano, la
nuova opera avrebbe dovuto contenere la "fisiologia
immanente", cioè la parte della metafisica che si riferi
sce specificamente agli oggetti della natura conoscibili
empiricamente - articolandosi in fisica razionale e psi
cologia razionale - e che si distingue perciò dall'ontolo
gia (corrispondente alla filosofia trascendentale) e da
cosmologia e teologia razionali, costituendo insieme ad
esse la "metafisica della natura". In realtà, nei Principi
metafisici Kant affronta da capo il problema della strut
tura e della legittimità di questa parte della metafisica,
che era rimasto aperto: ne riduce il contenuto alla sola
"fisica razionale" e la presenta come una scienza non
più autonoma, ma strettamente congiunta con la fisica
matematica. Questa nuova scienza resterà l'unica parte
dell'originaria metafisica della natura che Kant realiz
zerà effettivamente. Per riferirsi invece all'idea di un
compimento sistematico della Critica - organizzato sul
modello dei manuali scolastici su cui teneva lezione -
Kant parlerà semplicemente di una "metafisica", che
del resto non realizzerà mai.
Le premesse di questo cambiamento di impostazione
stavano già nella Critica. Kant, infatti, aveva sostenuto
che la filosofia è <<l'idea di una scienza possibile, mai
6 INTRODUZIONE
data in concreto, a cui si cerca tuttavia di avvicinarsi per
diverse strade», e che in realtà non si può imparare la
filosofia, ma semmai solo a <<filosofare, cioè a esercitare
il talento della ragione mediante l'applicazione dei suoi
·principi universali ad alcuni tentativi dati>> [KrV A 838/
B 866]. Perciò, sebbene affermasse che ad essa, in quan
to propedeutica, doveva seguire la metafisica vera e
propria, la quale avrebbe dovuto contenere una com
piuta analisi dei concetti di cui la Critica indagava solo
le fonti [A XXI], egli, tuttavia - in una parentesi di gran
peso -, definiva "vera o apparente" la conoscenza orga
nizzata in un tale sistema [KrV A 841/B 869]. La metafi
sica, cioè, manteneva idealmente agli occhi di Kant la
struttura propria dell'esposizione scolastica (w olffiana)
- con le sue rigorose analisi concettuali cui Kant attri
buiva un valore conoscitivo non indifferente-, ma la
validità oggettiva dei suoi contenuti era stata neutraliz
zata in gran parte dalla critica. La filosofia trascendenta
le, anzi, con un significativo paradosso, veniva definita
alternativamente come una propedeutica e come una
parte integrante della metafisica stessa, poiché in. realtà,
indagando le condizioni di possibilità. dei suoi giudizi,
ne aveva già sostanzialmente esaurito la trattazione.
Non a caso, dunque, Kant non scrisse mai il promesso
trattato di metafisica, ma - sollecitato dai problemi
interni della Critica e dal dibattito che si aprì dopo la
pubblicazione dell'opera - privilegiò esposizioni della
filosofia trascendentale che aiutassero a metterne a
fuoco le questioru di principio (come quella dei Prolego
meni), piuttosto che dedicarsi alla realizzazione di un'e
sposizione rigorosamente sistematica. Solo negli anni
'90,_ infine, in replica a coloro che si richiamavano alle
sue ripetute affermazioni sulla necessit_à di un compi
mento sistematico della Critica per sostenere l'esigenza
di una nuova metafisica speculativa, sconvolgendo ai
suoi occhi il senso della filosofia critica, Kant sottolineò
INTRODUZIONE 7
con forza quanto aveva già affermato in sostanza fin dal
principio: che cioè la Critica conteneva tutto quanto di
essenziale vi fosse da scrivere sulla metafisica.
2
I Principi metafisici si collocano proprio al termine
della prima fase di ripensamento del criticismo: l'opera
affronta il problema di realizzare la metafisica della
natura come sola metafisica dotata di validità oggettiva
e stabilisce, così facendo, i presupposti per gran parte
delle modifiche della seconda edizione della Critica
(1787). Nonostante il disgregarsi del proposito kantiano
di realizzare un sistema, per comprendere la genesi della
nuova metafisica non va sottovalutato il ruolo svolto
dalla cornice sistematica. In effetti, per Kant, l' organiz
zazione sistematica dei pensieri era nello stesso tempo
un requisito di scientificità e un metodo di lavoro, senza
corrispondere necessariamente all'esposizione di conte
nuti dogmatici) Così, l'architettonica delle conoscenze
razionali tracciata nella Critica, basata sulla distinzione
di principio tra matematica e metafisica, costituisce il
necessario presupposto del tentativo - intrapreso nella
nuova opera - di istituire un passaggio tra filosofia tra
scendentale e fisica matematica. Per introdurre i pro
blemi legati a questi rapporti "architettonici" tra le
diverse parti della conoscenza della natura, è opportuno
dunque menzionare il modo in cui viene presentata per
la prima volta l'idea della metafisica della natura su cui
Kant ritornerà nei Principi metafisici.
·La metafisica o filosofia della natura - scrive Kant
nella Critica [KrV A 845/B 87.3ss.J - si articola in due
parti: la prima è la ''filosofia trascendentale", o "ontolo
gia", che «si limita a studiare l'intelletto e la ragione nel
sistema di tutti i concetti e di tutti i principi concernenti
oggetti in generale, senza assumere oggetti che siano
dati», e questa scienza, sia pure senza la compiutezza del
trattato scolastico, è stata esposta già nella Critica; la
seconda parte «studia la natura, ossia il complesso degli
8 INTRODUZIONE
oggetti dati [. .. ] ed è quindi fisiologia (benché soltanto
rationalis)». Quest'ultima si suddivide a sua volta in due
parti: la "fisiologia immanente", che «si riferisce agli
oggetti dei sensi in quanto ci sono dati, ma soltanto
secondo condizioni a priori sotto le quali ci possono
venire dati in generale»; e la "fisiologia trascendente",
che si compone di cosmologia trascendentale e teologia
trascendentale, le quali si occupano rispettivamente
della totalità degli oggetti dell'esperienza, e del collega
mento dell'intera natura con un ente che la trascende.
La scienza cui Kant si dedicherà nei Principi metafisici -
come si è accennato - è la "fisiologia immanente", che si
articola a sua volta in "metafisica della natura corpo
rea", o "fisica razionale", e "metafisica della natura pen
sante", o "psicologia razionale". L'opera del 1786, in
particolare, conterrà la sola metafisica della natura cor
porea, perché Kant vi sosterrà la sostanziale inconsisten
za della psicologia razionale [vedi infra nota 14]. È degno
di nota, comunque, che la metafisica trattata nella nuova
opera corrisponda all'unica parte del sistema che non
trova corrispondenza nella classificazione wolffiana,
essendo state le altre sostanzialmente dissolte come
scienze apparenti nella Dialettica trascendentale. Kant
stesso ne riconosce l'originalità, che si basa sul fatto di
fornire una «Conoscenza a priori, cioè Una metafisica,
relativa ad oggetti che però ci sono dati a posteriori»
[KrV A 847 /B 875]. Soltanto nei Principi metafisici Kant
risolverà il problema della legittimità di questa nuova
metafisica, e, dunque, della possibilità di una nuova
estensione della conoscenza a priori [vedi infra§ 2].
La "fisica razionale", appartenendo alla metafisica, si
distingue da quella che al tempo veniva più comune
mente chiamata "fisica generale", cioè la fisica matema
tica [KtV A 847/B 875, nota]. La conoscenza filosofica e
quella matematica - come Kant ha lungamente argo
mèntato in precedenza [A 712/B 740ss.J - sono infatti
INTRODUZIONE 9
essenzialmente diverse: la prima si basa su concetti, la
seconda sulla rappresentazione di concetti nell'intuizio
ne pura, o "costruzione". Ora, Kant riconosce che la
matematica è indispensabile alla fisica empirica propria
mente detta - che si basa sulla semplice raccolta di
osservazioni empiriche - e che in confronto ad essa la
metafisica non ha da offrire praticamente nessuna cono
scenza. Egli sostiene, tuttavia, che i matematici, nell' ap
plicare la matematica alla fisica si sono serviti di «certi
concetti comuni, che di fatto sono metafisici>> e, senza
un'indagine critica sulla loro origine e applicazione,
hanno introdotto nella fisica pura delle vere e proprie
ipotesi, in contrasto con il rigore della propria scienza.4
Sarà compito della metafisica della natura mostrare l'ori
gine e la legittimità dell'uso empirico di questi concetti.
Secondo il disegno della Critica, dunque, la nuova
metafisica della natura (come la si chiamerà d'ora in poi)
si colloca tra filosofia trascendentale e fisica empirica e,
nello stesso tempo, intrattiene un rapporto con la fisica
matematica, che fino al 1786 non viene, tuttavia, compiu
tamente esaminato. Alla luce di questi diversi rapporti~
nella Prefazione ai Principi metafisici, Kant individua i due
scopi fondamentali a cui risponde la nuova metafisica.
Il primo di essi riguarda la funzione che la nuova
metafisica svolge nei confronti della filosofia trascen
dentale. Kant premette che l'esposizione separata di
questa parte a priori della scienza della natura risponde
all'esigenza di evitare «l'incertezza che sorge dalla
mescolanza di diverse scienze, allorché non si sa distin
guere a quale di esse siano da ascrivere sia i limiti, sia gli
errori· che possono presentarsi nel !Oro impiego» [MA
473]. Ma, dal punto di vista della filosofia trascendenta
le, esiste una seconda ragione, "esteriore, contingente, e
tuttavia importante", per la trattazione separata della
nuova scienza. Essa non riguarda <<la costituzione del-
1' oggetto e la specifica modalità della sua conoscenza»,
10 INTRODUZIONE
· ma «lo scopo che ci si prefigge con la scienza stessa per
un altro uso» [MA 477, cors. mio]. Infatti, qual è il vero e
proprio scopo della metafisica? Kant non ha dubbi:
La metafisica ha finora occupato così tante teste, e
continuerà a occuparne, non àll9 scopo di estendere le
conoscenze naturali (il che accade con molta più faci
lità e sicurezza mediante l'osservazione, I'e sperimento
e I'a pplicazione della matematica ai fenomeni esterni),
ma per giungere alla conoscenza di ciò che sta del
tutto al di là dei confini dell'esperienza, cioè di Dio,
della libertà e dell'immortalità [MA 477].
Ora, se lo scopo della nuova metafisica non può
sostituirsi a quello della precedente, essa può svolgere
però un compito ad esso imparentato, che Kant descri
ve subito dopo:
È in effetti davvero notevoie (sebbene qui non possa
essere mostrato adeguatamente) che la metafisica
generale, in tutti i casi in cui ha bisogno di esempi
(intuizioni) per procurare significato ai suoi puri con
cetti intellettuali, debba trarli sempre dalla dottrina
generale dei corpi, cioè dalla forma e dai principi del
l'intuizione esterna, e se questi non sono esposti com
piutamente brancoli fra meri concetti senza senso,
incerta ed esitante[. .. ] Ecco perché una distinta meta
fisica della natura corporea reca a quelfa generale un
servizio eccellente e indispensabile, procurando esem
pi (casi in coi;icreto) per realizzare i concetti e i teore
mi di quest'ultima (propriamente, della filosofia tra
scendentale), cioè per procurare senso e significato a
una semplice forma del pensiero [ibidem].
I Principi metafisici, dunque, come verifica della tesi
della Cri#ca sulla possibilità del solo "uso empirico"
dell'intelletto: ecco il primo scopo della nuova opera. In
luogo della metafisica tradizionale, si ha una metafisica
che ne rivela il carattere di "semplice forma del pensie
ro" .5 Può sembrare che da questo punto di vista la