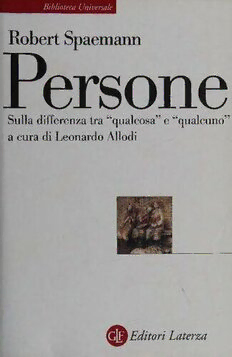Table Of ContentBiblioteca Universale
Robert Spaemann
Persone
Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”
a cura di Leonardo Allodi
© Zdivori Laterza
Biblioteca Universale Laterza
SÙ
Robert Spaemann
Persone
Sulla differenza tra
“qualcosa” e “qualcuno”
a cura di Leonardo Allodi
© EditoriL aterza
Titolo dell'edizione originale
Personen
Versuche îiber den Unterschied zwischen
“etwas” und “jemand”
© J.G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659,
Stuttgart 1996, 1998?
© 2005, Gius. Laterza & Figli
per La trascendenza, «luogo» dell'umano
di Leonardo Allodi
Traduzione di Leonardo Allodi
Prima edizione luglio 2005
7 Edizione
Done gi 10
Proprietà letteraria riservata
Anno Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Questo libro è stampato
su carta amica delle foreste
La traduzione dell’opera è stata
realizzata grazie al contributo del SEPS Stampato da
Arti Grafiche Editoriali Srl - Urbino
per conto della Gius. Laterza & Figli Spa
ISBN 978-88-420-7119-8
Via Val d’Aposa 7 - 40123 Bologna
[email protected] - www.seps.it
www.laterza.it
La trascendenza, «luogo» dell’umano
di Leonardo Allodi
Meno ci si preoccupa di esprimere
l’inesprimibile e più l’inesprimibile
è ineffabilmente contenuto in ciò
che è espresso
Ludwig Wittgenstein
Caratterizzata da un essenziale interesse per le problematiche della
cosiddetta filosofia pratica, la ricerca storico-filosofica di Robert
Spaemann ha assunto nel suo svolgimento complessivo due precise
dimensioni: in primo luogo, considerato il nesso esistente fra sapere
storico ef ilosofia pratica, essa si è concentrata, soprattutto all’inizio,
sullo sviluppo di un autentico approccio gesstesgeschichtliche, nella
convinzione che la prospettiva della Wirkungsgeschichte sia la più
idonea a cogliere la problematica fondamentale del «discorso filo-
sofico della modernità». A questa prima prospettiva appartengono
essenzialmente le opere Der Ursprung der Soziologie aus derma Geist
der Restauration. Studien tiber L'G.A. de Bonald (1959), Reflexion
und Spontanettàt. Studien tiber Fénelon (1963) e il saggio Rousseau.
Birger ohne Vaterland (1980). Gli studi successivi, dedicati ad aspet-
ti più teoretici che storici della questione della modernità, per am-
missione dello stesso Spaemann devono molto a queste prime ope-
re. La seconda prospettiva è quella sviluppata dall’autore nei suoi
scritti speculativi: Die Frage Wozu? (1981, in collaborazione con
Reinhard Low), Moralische Grundbegriffe (1986), Das Nattirliche
und das Verniinftige. Aufsitze zur Anthropologie (1987) e Gliick und
Woblwollen. Versuch iiber Ethik (1989). Personen. Versuche tiber
den Unterschied zwischen “etwas” und “jemand” (1996), a cui è se-
guita la raccolta di saggi Grenzen. Zur ethischen Dimension des Han-
delns (2001), costituisce a tutti gli effetti un lavoro conclusivo, che
rinvia implicitamente alle tesi fondamentali e ai risultati di studi che
si sono sviluppati nell’arco di quasi cinquant'anni, e che restano
orientati da un motivo teoretico decisivo: il rapporto tra natura, es-
sere e persona!. I saggi contenuti in Philosophische Essays (1983), in
particolare Das Ende der Modernitàt? e il fondamentale studio Zur
Kritik der politischen Utopie (1977) si situano, idealmente e anche
cronologicamente, tra questi due momenti?.
L’indagine spaemanniana sulla nozione di persona, anche per
questo retroterra di studi che la precedono, è tale da oltrepassare il
campo specifico della filosofia, e più in particolare della filosofia pra-
tica. È infatti da una precisa interpretazione storico-filosofica della
modernità, intesa come movimento di pensiero che produce una
«inversione della teleologia» e una dialettica insuperabile tra due
culture, naturalismo e spiritualismo — una dialettica che, in quanto
incomponibile, espone la nostra civiltà a una minaccia essenziale —,
che Spaemann deriva un compito: ripensare i concetti di «essere»
(inteso come Selbstsein), «natura» e «ragione» in vista di una rifon-
dazione del concetto di persona. Chiarire che cosa vuol dire perso-
! È in corso di pubblicazione (Edusc, Roma 2005), il più importante e vasto stu-
dio filosofico dedicato proprio a questo asse decisivo del pensiero-spaemanniano:
P. Sabuy, Robert Spaemann e la dialettica di naturalismo e spiritualismo. Natura, ra-
gione e persona.
? Indichiamo di seguito le opere di Spaemann tradotte in lingua italiana: Cox-
cetti morali fondamentali, trad. di A. Tuninetti, intr. di R. Buttiglione, Piemme, Ca-
sale Monferrato 1993; Per la critica dell'utopia politica, trad. e saggio introduttivo
di S. Belardinelli, Angeli, Milano 1994; Felicità e benevolenza, presentazione di F.
Botturi, Vita e Pensiero, Milano 1998; L'origine della sociologia dallo spirito della
Restaurazione. Studi su L.G.A. de Bonald, a cura di C. Galli e L. Allodi, con una
postfazione di L. Allodi titolata Robert Spaemann e la critica della ragione funzio-
nalista, Laterza, Roma-Bari 2003. È in corso di pubblicazione la traduzione italia-
na di Das Nattirliche und das Verniinftige (Edusc, Roma 2005). Per un’analisi dello
sviluppo del pensiero di Spaemann, ci permettiamo di rinviare ai seguenti nostri in-
terventi: Ermeneutica del moderno e tradizione nel pensiero di Robert Spaemann, in
L. Allodi, La modernità controversa. Analisi storico-sociologica e prospettive episte-
mologiche, Studium, Roma 2000, pp. 95-132; Destra e sinistra dopo la modernità, in
L. Allodi, Globalizzazione e relativismo culturale, Studium, Roma 2003.
VI
na, significa andare al cuore di ciò che può significare «umano», in-
dividuandone il luogo originario in quel rapporto tra «natura» e
«persona» che rinvia a un principio di «trascendenza». In tal modo
Spaemann perviene alla stessa conclusione di Max Scheler, quando
ha definito l’uomo come «l’intenzione e il gesto stesso della trascen-
denza, l’essere che prega e cerca Dio». La riflessione di Robert
Spaemann sembra in tal senso costituire una formidabile sfida per
tutte le scienze umane e sociali contemporanee. Nella misura alme-
no in cui la specifica chiarificazione di che cosa sia l’uomo e più in
particolare la persona, sia ancora percepita come elemento intrinse-
co alla scienza sociale, il quale, rappresentando la ricerca della co-
noscenza umana delle cose umane, include, come suo fondamento,
la conoscenza umana di ciò che costituisce l’umanità?.
Per Spaemann l’uomo è immagine e rappresentazione dell’in-
condizionato, in virtù della sua capacità di apertura razionale infini-
ta, di distanziamento dalla propria «natura», di «autotrascendenza».
È soprattutto la nozione di «vita» a costituire il punto di partenza
dell’indagine di Spaemann. Facendo proprio il «vivere viventibus es-
se» di Aristotele, Spaemann precisa come l’essere sia un derivato del-
la vita che implica in pari tempo capacità di riflettere su di essa e
dunque distanziamento da se stessi: con san Tommaso, Spaemann
ripete: «qui non intelligit, non perfecte vivit». Comprendere l’uomo
significa allora mostrare come «qui non vivit, non perfecte existit».
Soltanto integrando queste due dimensioni, natura e ragione, è pos-
sibile comprendere appieno la cifra di ciò che è «umano». Ragione
e vita dunque non sono in conflitto: ragione significa innanzittutto
scoprire la «verità della natura», la sua costituzione «teleologica».
Per questo la ragione, secondo Spaemann, non è altro che «la forma
della vita», e la persona è l’essere vivente «potenzialmente morale».
3 Cfr. M. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos (1928), in Gesammel-
te Schriften, vol. IX (Spàte Schriften), Francke Verlag, Bern 1976; trad. it. a cura di
G. Cusinato, La posizione dell’uomo nel cosmo, Angeli; Milano 2000.
4 Cfr. L. Strauss, Social Science and Humanism (1956), in The Rebirth of Clas-
sical Political Rationalism, Essays and Lectures by Leo Strauss Selected and Intro-
duced by Thomas L. Pangle, The University Press, Chicago-London 1989, pp. 3-
12; trad. it. Scienza sociale e umanesimo, a cura di L. Gattamorta, in «Ideazione»,
1, 2004, pp. 198-208.
5 Cfr. P. Sabuy, Natura, ragione e persona: l'impostazione antropologica di Ro-
bert Spaemann, in «Ideazione», 2, 2003, pp. 204-209.
VII
Da questa premessa deriva un confronto decisivo soprattutto con la
corrente filosofica che definisce la persona sulla base della sola inte-
riorità e la cui origine lontana si trova nella distinzione cartesiana tra
res cogitans e res extensa: Peter Singer, Norbert Hoerster e, soprat-
tutto, Derek Parfit. Quest'ultimo appare come l’interlocutore privi-
legiato di Spaemann, nella misura in cui esprime meglio di tutti gli
altri la posizione che radicalizza maggiormente l'opposizione tra es-
sere umano e persona.
La sfida allo scientismo e alla sua pretesa di dirci che cosa siamo,
cioè parti di quella natura «che noi abbiamo ridotto a pura oggetti-
vità», porta Spaemann a una riflessione sul concetto di «naturale»
che fa emergere tutta l’«ambiguità» del termine. «Naturale», dice
Spaemann, non significa «naturalistico», ma appunto ciò che con-
tiene in sé il ragionevole. In questo senso, afferma, solo l’uomo ra-
gionevole è uomo «naturale», capace di trascendere quella curvazio
in se ipsum che è poi il maggior ostacolo ad ogni forma di benevo-
lenza. Amicizia con se stessi, con gli altri, con il mondo, il cui signi-
ficato non è semplicemente morale: per Spaemann infatti la «bene-
volenza» è condizione stessa per accedere ad ogni esperienza auten-
tica dell'essere. Nel «lasciar essere», nell’abbandono fiducioso, l’uo-
mo non trova soltanto la cifra della propria libertà ma comprende il
proprio «essere» e quello altrui.
Entrando nel vivo della discussione sulla «scommessa della mo-
dernità», quella di un «soggetto assoluto», di un Sé autonomo che si
pretende fondamento sufficiente dell’identità, chiuso dunque nella
propria immanenza e autosufficienza, essenzialmente e costitutiva-
mente «ripiegato» su se stesso, Spaemann ci costringe a riflettere an-
che su quelle premesse epistemologiche delle scienze sociali con-
temporanee, che altro non sono che le premesse della stessa moder-
nità°. La questione della natura del «soggetto umano» e della spie-
gazione del suo agire è infatti anche la questione del rapporto fra
struttura sociale e azione individuale, un problema epistemologico
che resta decisivo per tutta l’epistemologia delle scienze sociali. So-
no qui in gioco il carattere «autonomo» o, viceversa, «eteronomo»
della costituzione del Sé, la possibilità o meno di continuare a par-
lare di un «umano», oggi particolarmente minacciato, secondo Spae-
6 Cfr. A. Seligman, Modernitys Wager, Princeton University Press, 2000; trad.
it. La scommessa della modernità. Sé, autorità e trascendenza, a cura di M. Bortoli-
ni e M. Rosati, Meltemi, Roma 2002.