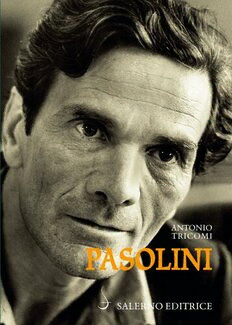Table Of Content«Aveva torto e non avevo ragione». Cosí Fortini in ri-
cordo di un interlocutore la cui grandezza oggi ci si rivela
ancor piú controversa, ma la cui intelligenza delle questioni
e il cui sguardo sulla realtà circostante continuano a offrire
un punto di vista con cui è impossibile non confrontarsi.
In primo luogo perché, sperimentando soluzioni espres-
sive talvolta addirittura estremistiche, Pasolini ha in fondo
sempre cercato il conflitto con l’industria culturale, col senso
comune. E poi perché, non rinunciando mai a presentarsi
anzitutto come intellettuale civile, egli ha scommesso, senza
mai derogarvi, sul valore squisitamente politico della lette-
ratura, dell’arte, della conoscenza.
Scrutato in quest’ottica da Antonio Tricomi, il bulimico
work in progress pasoliniano dimostra di trovare i propri capi-
saldi senz’altro nelle Ceneri di Gramsci e nella Meglio gioventú,
nei corto e mediometraggi degli anni Sessanta, in testi teatrali
come Orgia e Calderón, ma, ancor piú, nei suoi esiti ultimi.
In particolare, nei propri risvolti saggistici (dagli Scritti
corsari alle Lettere luterane e a Descrizioni di descrizioni), in
quell’autentico “incubo” cinematografico che è il Salò o le
120 giornate di Sodoma e, soprattutto, in Petrolio. È in tale,
apocalittico «centone» che urge con ogni probabilità rinve-
nire il capolavoro almeno potenziale di Pasolini.
SESTANTE
COLLANA DIRETTA DA
ANDREA MAZZUCCHI
CONDIRETTORI
ANTONIO GARGANO E MATTEO PALUMBO
45
ANTONIO TRICOMI
PASOLINI
SALERNO EDITRICE
ROMA
Composizione presso Graphic Olisterno, Portici (NA)
Copertina:
Pier Paolo Pasolini (1971). Foto di Binder
(© Ullstein Bild/Archivi Alinari)
Realizzazione tecnica a cura di Grafica Elettronica, Napoli
1a edizione digitale: marzo 2020
ISBN 978-88-6973-508-0
1a edizione cartacea: marzo 2020
ISBN 978-88-6973-399-4
Tutti i diritti riservati - All rights reserved
Copyright © 2020 by Salerno Editrice S.r.l., Roma
premessa
In fondo, li ha pretesi e, in un certo senso, costruiti lui: lettori e spetta-
tori che, scoperta la sua onnivora, bruscamente interrottasi opera di co-
stante interlocuzione col proprio tempo, faticassero poi ad affrancarsi dal
desiderio di interrogarla piú e piú volte. Per estrarne via via significati
nuovi, come si fa con ogni testo che si voglia inconsumabile perché deli-
beratamente oracolare. O per rimettere in questione analisi di essa già
tentate, se le aporie e gli improvvisi cambi di rotta, giocoforza connatura-
ti a un simile work in progress, addirittura richiedono esegeti pronti a torna-
re quasi ossessivamente sulle loro valutazioni per confermarle, corregger-
le, persino ripudiarle.
Da viscerale « dittatore mite » quale in Petrolio si descrive, li ha insomma
presi in ostaggio Pasolini stesso i propri interpreti. Chiedendo loro una
fedeltà alla sua opera da intendersi, però, non già come idolatrica celebra-
zione di essa e del vieppiú disilluso autore civile capace di darle forma, ma
come intenso, disinibito, se necessario finanche livoroso corpo a corpo
con tale sterminata messe di pagine e fotogrammi, di umori e persino di-
pinti: con lui. Perché il solo modo di rispettare i maestri – egli ci ricordava
in Uccellacci e uccellini appropriandosi in totale libertà di una frase di Pasqua-
li – è mangiarseli « in salsa piccante ». Renderne cioè controversa, e appun-
to cosí farne rivivere, la lezione, non certo venerarne con fanatico o remis-
sivo zelo la memoria (che poi vuol dire: omaggiarli giusto in quanto mo-
numenti e, dunque, cadaveri).
E invece, tanto piú se si vuol essere i lettori o gli spettatori auspicati per
sé da Pasolini, tocca impegnarsi periodicamente, anche in conflitto con
pur invincibili tendenze critiche di segno opposto, a smitizzarlo. A saggia-
re la propria effettiva disponibilità a percepirlo come Sciascia – quasi in
apertura di un testo a lui idealmente dedicato, L’affaire Moro – confessava di
averlo sempre sentito: « Fraterno e lontano ».1 E questo non per negare la
testardamente generosa, benché in ultimo umoristicamente disperata, ca-
pacità dei suoi libri, dei suoi film di cogliere la realtà senza tuttavia arren-
1. L. Sciascia, L’affaire Moro, in Id., Opere [1971.1983], a cura di C. Ambroise, Milano,
Bompiani, 2004, p. 468.
7
premessa
dersi ad essa, cioè continuando sempre a pensarla anche solo in minima
parte modificabile. Viceversa, per non condannare le sue opere a quella
paradossale forma di illeggibilità cui le destina chi di fatto si esima dal va-
gliarne i precisi significati accontentandosi di giudicarle profetiche, e non
magari satiricamente utopistiche pur quando esse si dichiarino impotenti.
Perché, oltre a Sciascia, anche La Capria, per esempio, non tardava a
notarlo: diversamente da quanto affermano gli Scritti corsari, negli anni
Settanta le lucciole non erano affatto scomparse, né del resto si sono estin-
te oggi. Solo che « la forza della metafora di Pasolini è rimasta, con tutta la
sua carica rivelatrice », per l’ovvia ragione che essa non voleva risultare la
veridica presa d’atto di un « fatto minimo e apparentemente irrilevante »,
né ambiva a pronosticare chissà quale evento. Piuttosto, intendeva con-
vertire in un’immagine assolutamente lirica la percezione di una catastrofe
storica – l’eclissi del mondo contadino, il tramonto della civiltà umanistica
– per l’autore già consumatasi e, infatti, da lui esplorata maniacalmente
nei propri lavori tutti. E sondata, in ciascuno di essi, traslitterandone poe-
ticamente gli esiti tragici, se compito di un artista è appunto tradurre « nel-
la giusta forma », e rendere in tal modo ineludibili, quelle verità del pre-
sente che i contemporanei, pur avendole sotto gli occhi, si ostinano a mi-
sconoscere.2
Non c’è quindi da giustificarsi se, una volta ancora, si è cercato il dialogo
con un organismo testuale che, piú di recente, Montesano ha definito
« una forma che si decomponeva mentre si generava, e trovava spesso la
voce di un Io ironico che masticava letteratura sputando realtà e vicever-
sa ».3 D’altro canto, lo hanno sempre saputo e tuttora lo accettano i massi-
mi esegeti di Pasolini, da Fortini a Siti: se si sceglie un primo confronto
critico con la sua poetica, al tempo stesso, manieristica e gestuale, con la
sua attitudine, insieme, al falsetto e alla pura performance autoriale, è poi
difficile resistere alla tentazione di prodursi, con lui, in un prolungato,
inesausto, talora persino sfibrante regolamento di conti. Pur sapendo di
esporsi cosí al rischio di doversi infine ammettere vampirizzati dal pro-
prio oggetto di studio.
2. R. La Capria, Il sentimento della letteratura, Milano, Mondadori, 1997, pp. 74-75.
3. G. Montesano, Lettori selvaggi. Dai misteriosi artisti della Preistoria a Saffo a Beethoven a
Borges la vita vera è altrove, Firenze, Giunti, 2016, p. 1577.
8
premessa
E, a dirla tutta, neppure c’è qui da proporre, rispetto a quello abbozzato
in altre occasioni, un qualche canone nuovo interno all’opera di Pasolini.
Che, come poeta, resta anzitutto l’autore delle Ceneri di Gramsci e della
Meglio gioventú. In veste di prosatore, spicca per Ragazzi di vita ma, ancor
piú, per Petrolio. Si dimostra uno straordinario saggista soprattutto con gli
Scritti corsari, le Lettere luterane, Descrizioni di descrizioni. Ci ha offerto testi
teatrali in versi che – specialmente Orgia e, a suo stesso dire, Calderón – piú
passa il tempo, piú confermano il loro valore. Il meglio di sé lo ha dato, al
cinema, con Accattone, con Uccellacci e uccellini, con Salò o le 120 giornate di
Sodoma, con i medio e cortometraggi: in particolare, con La ricotta.
Nel licenziarle, c’è dunque semplicemente da dedicare queste pagine
alla memoria di un’amica carissima, che per anni, e con tanta passione
quanta intelligenza, nella promozione degli studi pasoliniani si è spesa,
letteralmente, anima e corpo. Ecco: se solo Angela Felice avesse fatto in
tempo a discuterne con l’autore il dattiloscritto, questo libro presentereb-
be ora meno forzature, dimenticanze, imprecisioni.
A.T.
9
Tavola delle abbreviazioni
Salvo diversa indicazione, tutte le citazioni da lavori o missive di Paso-
lini provengono dall’edizione completa delle sue opere, in dieci volumi,
diretta da Walter Siti per la collana dei « Meridiani » Mondadori o dall’edi-
zione delle sue lettere, in due tomi, curata per Einaudi da Nico Naldini.
Con la sigla NN si è inteso rimandare alle Note e notizie sui testi che corre-
dano ciascun volume dell’appena ricordata edizione completa delle opere
pasoliniane. Alla quale, cosí come alla succitata edizione delle lettere
dell’autore, ci si è invece riferiti, nel libro, con le seguenti abbreviazioni:
C1 = Per il cinema, a cura di W. Siti e F. Zabagli, Milano, Mondadori, vol. 1
2001.
C2 = Per il cinema, a cura di W. Siti e F. Zabagli, Milano, Mondadori, vol. 2
2001.
L1 = Lettere 1940-1954, a cura di N. Naldini, Torino, Einaudi, 1986.
L2 = Lettere 1955-1975, a cura di N. Naldini, Torino, Einaudi, 1988.
P1 = Tutte le poesie, a cura di W. Siti, Milano, Mondadori, vol. 1 2003.
P2 = Tutte le poesie, a cura di W. Siti, Milano, Mondadori, vol. 2 2003.
R1 = Romanzi e racconti, a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano, Mondadori,
vol. 1 1998.
R2 = Romanzi e racconti, a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano, Mondadori,
vol. 2 1998.
SLA1 = Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano,
Mondadori, vol. 1 1999.
SLA2 = Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano,
Mondadori, vol. 2 1999.
SPS = Saggi sulla politica e sulla società, a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano,
Mondadori, 1999.
T = Teatro, a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano, Mondadori, 2001.
10