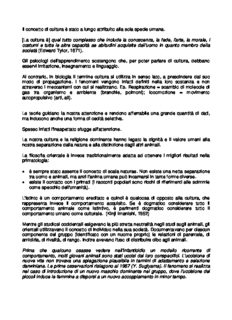Table Of ContentIl concetto di cultura è stato a lungo attribuito alla sola specie umana.
[La cultura è] quel tutto complesso che include la conoscenza, la fede, l'arte, la morale, i
costumi e tutte le altre capacità ae abitudini acquisite dall'uomo in quanto membro della
società (Edward Tylor, 1871).
Gli psicologi dell'apprendimento sostengono che, per poter parlare di cultura, debbano
esservi imitazione, insegnamento e linguaggio.
Al contrario, in biologia il termine cultura si utilizza in senso lato, a prescindere dal suo
modo di propagazione. I fenomeni vengono infatti definiti nella loro sostanza e non
attraverso i meccanismi con cui si realizzano. Es. Respirazione = scambio di molecole di
gas tra organismo e ambiente (branchie, polmoni); locomozione = movimento
autopropulsivo (arti, ali).
Le teorie guidano la nostra attenzione e rendono afferrabile una grande quantità di dati,
ma inducono anche una forma di cecità selettiva.
Spesso infatti l'inaspettato sfugge all'attenzione.
La nostra cultura e la religione dominante hanno legato la dignità e il valore umani alla
nostra separazione dalla natura e alla distinzione dagli altri animali.
La filosofia orientale è invece tradizionalmente adatta ad ottenere i migliori risultati nella
primatologia:
è sempre stato assente il concetto di scala naturae. Non esiste una netta separazione
tra uomo e animali, ma anzi l'anima umana può incarnarsi in tante forme diverse.
esiste il contatto con i primati (i racconti popolari sono ricchi di riferimenti alle scimmie
come specchio dell'umanità).
L'istinto è un comportamento ereditato e quindi è qualcosa di opposto alla cultura, che
rappresenta invece il comportamento acquisito. Se è dogmatico considerare tutto il
comportamento animale come istintivo, è parimenti dogmatico considerare tutto il
comportamento umano come culturale. (Kinji Imanishi, 1952)
Mentre gli studiosi occidentali esigevano la più stretta neutralità negli studi sugli animali, gli
orientali utilizzavano il concetto di individuo nella sua società. Documentavano per ciascun
componente del gruppo (identificato con un nuome proprio) le relazioni di parentela, di
amicizia, di rivalità, di rango. Inoltre avevano l'uso di distribuire cibo agli animali.
Prima che qualcuno osasse vedere nell'infanticidio un modello ricorrente di
comportamento, molti giovani animali sono stati uccisi dai loro conspecifici. L'uccisione di
nuove vite non trovava una spiegazione plausibile in termini di adattamento e selezione
darwiniana. Le prime osservazioni rislagono al 1967 (Y. Sugiyama). Il fenomeno si realizza
nel caso di introduzione di un nuovo maschio dominante nel gruppo, dove l'uccisione dei
piccoli induce le femmine a disporsi a un nuovo accoppiamento in minor tempo.
Verso una definizione di cultura
La cultura è un modo di vivere condiviso dai membri di un gruppo, ma non
necessariamente dai membri di gruppi diversi della stessa specie. Copre la conoscenza,
gli usi, le abilità, incluse le tendenze e le preferenze sottostanti, che derivano da
un'esposizione agli altri e dall'apprendimento dagli altri. Qualsiasi variazione sistematica
nella conoscenza, negli usi e nelle abilità tra gruppi, che non può essere attribuita a fattori
genetici o ecologici, è probabilmente una variazione culturale.
La cultura è la diffusione non genetica di capacità e informazioni.
La cultura deve avere avuto inizi semplici che possono essere trovati al di fuori della
nostra specie.
Gli umani sono i più culturali di tutti gli esseri culturali. Grazie ai simboli, al linguaggio, alle
idee, ai significati, all'istruzione, all'imitazione, l'umanità ha fatto fare alla cultura un passo
che non ha precedenti.
Costruire nuove invenzioni su quelle più vecchie è un processo unicamente umano e porta
ad un'accumulazione dei miglioramenti nel corso della storia (effetto di irreversibilità).
Cultura animale
La cultura intesa come trasmissione sociale di capacità e informazioni è molto diffusa in
natura. Gli animali mancano di simboli e linguaggio; ma non c'è dubbio che essi sviluppino
nuove tecnologie, preferenze per i cibi, gesti comunicativi e altre capacità che i giovani
apprendono dai vecchi (o viceversa).
Imanishi definisce la cultura animale come:
comportamento flessibile trasmesso socialmente, una forma di trasmissione del
comportamento che non poggia su basi genetiche.
Ci vuole un villaggio per allevare un bambino
(proverbio africano)
La domanda del biologo è se i processi culturali siano visibili dal punto di vista della
selezione, se cioè contribuiscano alla sopravvivenza.
L'apprendimento sociale è ampiamente diffuso tra gli animali e presenta enormi vantaggi.
1. L'immagine del predatore (serpente, leopardo, aquila) viene tramandata e affiancata da
uno specifico richiamo di allarme che richiede una specifica risposta comportamentale.
2. Il cibo. Gli animali imparano gli uni dagli altri cosa mangiare e cosa non mangiare.
L'imitazione è un fenomeno molto complesso ed è considerata una delle più raffinate
imprese cognitive.
Ogni imitazione è una combinazione di un'idea generale presa dagli altri e di una pratica
individuale con cui tale abilità viene affinata.
Essa necessita che l'input visivo sia convertito in output motorio.
Gli umani imparano dagli altri con più facilità e precisione di qualsiasi altro animale.
Oltre ad essi, solo le grandi scimmie riescono bene a imitare. Copiano meglio se l'azione
lega due oggetti, così come spesso avviene nell'uso di utensili in natura, piuttosto che se
lega un oggetto con il corpo.
Alcuni scimmiottamenti
segare legna, piantare chiodi, indossare una t-shirt, ripararsi gli occhi dal sole, legare
un'amaca, spaccare noci di cocco;
camminare come altri, strofinare le pietre l'una contro l'altra, bere da una bacinella
immergendovi il braccio e poi leccandolo.
Le scimmie allevate in famiglia sono risultate imitatrici altrettanto brave dei bambini di due
anni. Alcune di queste inseriscono la loro foto tra quelle degli uomini, separandosi dal
resto degli altri animali.
All'interno del proprio gruppo, le scimmie giovani tendono ad imitare gli anziani.
Negli animali in cattività e nella colonia di macachi sull'isola di Koshima nessuna maschio
alfa è stato mai spodestato: il trasferimento del potere è sempre avvenuto dopo la morte
naturale. Nei gruppi in natura, al contrario, i giovani maschi sfidanti provengono
dall'esterno e sono del tutto privi di impedimenti dovuti al rispetto.
L'isola di Koshima
La prima esplorazione dell'isola di Koshima da parte di Imanishi fu nel 1948.
Subito dopo cominciò la distribuzione di grano e patate dolci per abituare i macachi al
contatto.
Furono quindi identificate individualmente le scimmie e descritte le loro connessioni
sociali.
Nel 1953 venne documentato per la prima volta il lavaggio spontaneo delle patate da parte
di Imo, una scimmia di diciotto mesi. Più tardi migliorò la tecnica.
Il lavaggio delle patate si diffuse all'inizio orizzontalmente, da Imo ai suoi compagni di
gioco. Dopo tre mesi, due dei suoi compagni e la madre presentavano il comportamento.
Si estese quindi ad altre scimmie giovani, ai fratelli e alle sorelle maggiori, e alle rispettive
madri. I maschi più vecchi non adottarono mai questo comportamento. La trasmissione
sembrava seguire la quantità di tempo che le scimmie trascorrevano insieme. Anche la
trasmissione lungo le linee di parentela, da giovane a giovane, e da giovane a adulto.
Successivamente le patate vennero lavate nell'acqua e a questo comportamento si
attribuisce il valore di ottenere un 'condimento'.
Nel 1956 Imo imparò a separare il grano dalla sabbia portando una manciata del miscuglio
vicino all'acqua e gettandocela dentro.
Nel 1965 comparve l'articolo dal titolo: Newly-acquired pre-cultural behavior of the natural
troop of Japanese monkeys on Koshima islet (Kawai, 1965; Primates, 6: 1-30).
Le condizioni necessarie per l'imitazione sono state così definite dagli psicologi
sperimentali:
Identificazione
Comprensione dell'obiettivo
Conoscenza di sfondo
Al contrario, secondo Frans de Waal, è dubbio se vi sia la comprensione degli obiettivi e
se i comportamenti imitativi debbano essere finalizzati alla risoluzione di problemi.
BIOL (Bonding- and Identification-based Observational Learning).
Le motivazioni sottostanti l'apprendimento sociale affondano le radici nelle emozioni sociali
e nel conformismo ai desideri più che nell'aspettativa di una ricompensa o nel timore di
una punizione. Gli animali guardano gli altri e copiano il loro comportamento solo per
inserirsi nel gruppo e comportarsi come i loro simili.
Il risultato (vantaggio) finale è la diffusione di tecniche e abitudini all'interno di una
popolazione.
Il desiderio di agire come gli altri e l'abilità di riprodurne i comportamenti si sono evoluti
insieme.
Del resto anche nell'uomo, non esiste un obiettivo preciso per giustificare la tendenza degli
adolescenti a parlare con un gergo simile e non producono un risultato tangibile nemmeno
la moda, la religione, la cucina, l'arte, lo stile sociale.
Le culture degli scimpanzé
Il termine cultura si usa per descrivere alcuni comportamenti
degli animali che vengono trasmessi di generazione in
generazione attraverso l'apprendimento anziché attraverso i
geni. La cultura non riflette un semplice comportamento della
specie, ma esprime tradizioni regionali. Ne sono esempi il
foggiare e utilizzare arnesi, cacciare, mangiare carne, spartire il
cibo, combattere con altre comunità.
Perché si tratti di cultura, l'apprendimento deve avvenire per
imitazione e non per un procedimento di prove ed errori.
Gli esperimenti, in laboratorio e in natura, mostrano che negli
scimpanzé l'apprendimento avviene per imitazione.
1. Gruppi diversi di individui apprendono per imitazione
diverse tecniche per lo stesso scopo.
2. In cattività gli individui mostrano una più vasta gamma di
compoartmenti e attività.
3. In natura esistono numerose varietà di tradizioni locali. Di
recente, nove specialisti di scimpanzé hanno confrontato le
proprie osservazioni sul campo ed hanno elencato 39
comportamenti di origine culturale. La standardizzazione
delle osservazioni prevedeva l'attribuzione di una delle
seguenti qualifiche al comportamento:
comune: presente nella maggior parte degli individui;
abituale: ripetutamente osservato;
presente: osservato, ma non abituale;
assente: mai rilevato
assente (eco): assente per ragioni ecologiche.
Il completo bipedismo si è realizzato oltre 2.5 m.a. fa.
L’encefalizzazione si è invece realizzata gradualmente: è
cominciata circa 1.8 ed è stata seguita da una relativa
stasi fino a 600.000, quando ha cominciato ad aumentare
rapidamente, con un trend proseguito fino a 100-75.000
anni fa.
I resti materiali dell’encefalizzazione sono le innovazioni
culturali e la cultura tecnologica sempre più sofisticate,
grazie alle quali l'uomo ha modificato la propria vita
materiale e sociale, è divenuto capace di adattarsi ad
ambienti molto diversi, ha potuto diventare
progressivamente più efficiente nel procurarsi cibo e nel
difendersi dai predatori, riuscendo a sopravvivere anche
in situazioni estreme, dove le proprie potenzialità
biologiche, da sole, non sarebbero riuscite a sostenerlo.
In questa sua capacità, l'uomo si distingue e si distacca
dalle altre specie animali.
Le prove dell'evoluzione culturale possono essere
individuate in:
1. la creazione e l’uso di strumenti litici
2. sistemi di comunicazione
3. nuovi patterns di sussistenza
4. l’occupazione di nuove aree
Strumenti litici
Anche gli scimpanzé usano strumenti come bastoni o pietre, ma la loro
capacità di progettarli è molto limitata.
E’ verosimile che l’Australopithecus possedesse capacità simili a quelle
delle attuali antropomorfe, ma le prove archeologiche sono molto scarse.
I più antichi ritrovamenti di industria litica coincidono con la comparsa di
Homo habilis.
Fattori che favorirono la lavorazione della pietra:
liberazione dell’arto superiore dalla funzione locomotoria;
diminuzione del volume dei denti e riduzione del prognatismo facciale
totale;
complesse capacità psichiche, quali la capacità di astrazione, di previsione,
e di comunicazione comuni.
Conseguenze dell’uso di utensili litici:
miglioramento delle tecniche di macellazione e scarnificazione delle
carcasse;
aumento della varietà ed efficacia dei sistemi di procacciamento del cibo;
diminuzione del volume e della robustezza dell’apparato masticatorio;
potenziamento di culture più raffinate.
Origine dell'uomo moderno
I primi fossili sono pochi e frammentari.
125 kyr valle dell'Omo, Etiopia: un cranio frammentario di aspetto moderno;
100 Kyr Skhul e Qafzeh, Israele: primi uomini di morfologia moderna (con strumenti di tipo
musteriano).
Sull'origine dell'uomo moderno si contrappongono due teorie:
Origine multiregionale
Viene sostenuta l'evoluzione locale delle popolazioni umane, la cui variabilità dipende dall'adattamento
ad ambienti diversi (Widenreich, anni '40; Wolpoff, anni '80). Si sottolinea il ruolo della deriva (oltre
che della selezione) nel creare le differenze tra gruppi, ed il ruolo del flusso genico nell'appianarle, nel
prevenire la speciazione, e nel favorire un'evoluzione di tipo clinale.
Il modello è quasi del tutto privo di riscontri sperimentali.
Viene citata la continuità morfologica tra H.erectus di Giava e alcuni fossili australiani, oltreché la
continuità osservabile in Cina. Tuttavia tali fossili sono molto variabili e spesso privi di datazioni sicure.
In Europa, dove la documentazione è ampia e approfonditamente studiata, vi sono forti prove contro la
continuità.
Out of Africa
Viene sostenuta l'origine recente africana, e la sostituzione delle specie preesistenti. Esistono
numerose prove: paleontologiche, archeologiche, genetiche.
Prove paleontologiche
L'inizio dell'ultimo interglaciale, circa 125.000 anni fa, avrebbe favorito l'origine dell'uomo moderno. I
reperti scheletrici di aspetto moderno compaiono in Africa tra 130.000 e 50.000 anni fa, quando nel
resto del mondo erano presenti solo i Neandertaliani e i loro contemporanei asiatici. In Africa si ha
anche la migliore testimonianza di evoluzione locale. I primi europei moderni avevano dimensioni
scheletriche proprie di popolazioni africane.
Prove archeologiche
I primi strumenti di tecnologia moderna (lame, punte) e rare testimonianze di attività artistica (gusci di
uovo incisi, perline) compaiono in Africa intorno a 80-100.000 anni fa.
Il Paleolitico superiore, o l'età della Pietra recente (LSA), compare nel Levante circa 40.000 anni fa,
cioè almeno allo stesso momento che in qualsiasi altra regione. Comprende lame, grattatoi e bulini. Oltre
alla pietra sono comuni oggetti in osso, avorio e corno (punte, scalpelli, aghi e ornamenti).
Prove genetiche
L'insieme dei marcatori genetici studiati indica, piuttosto uniformemente, un'epoca di divergenza
compresa tra i 180.000 e i 120.000 anni.
Gli alberi filogenetici ricostruiti sulla base delle somiglianze genetiche tra popolazioni attuali mostrano
un'origine africana.
Lo studio del DNA ha mostrato che sono distinguibili due rami principali: africani sub-sahariani e alcuni
africani con il resto del mondo.
Una sequenza di regione ipervariabile di mtDNA del Neandertal ha mostrato che non esiste una
maggiore somiglianza con il DNA del gruppo europeo, smentendo l'ipotesi di continuità regionale.
Esiste maggiore variabilità genetica nelle popolazioni africane (mtDNA, DNA microsatellite, vari loci
del cromosoma Y).
Description:comportamento animale come istintivo, è parimenti dogmatico considerare tutto il comportamento umano come culturale. (Kinji Imanishi, 1952).