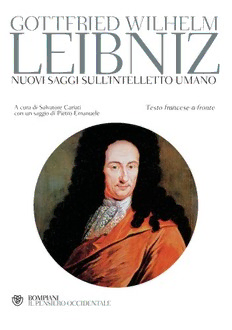Table Of ContentGOTTFRIED WILHELM
LEIBNIZ
NUOVI SAGGI SULL’INTELLETTO UMANO
Testo francese a fronte
A cura di Salvatore Cariati
con un saggio di Pietro Emanuele
BOMPIANI
IL PENSIERO OCCIDENTALE
BOMPIANI
IL PENSIEROOCCIDENTALE
direttore
GIOVANNI REALE
segretari:
Alberto Bellanti
Vincenzo Cicero
Diego Fusaro
Giuseppe Girgenti
Roberto Radice
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ
NUOVI SAGGI SULL’INTELLETTO
UMANO
Testo francese a fronte
A cura di Salvatore Cariati
Con un saggio di Pietro Emanuele
BOMPIANI
IL PENSIEROOCCIDENTALE
ISBN 978-88-58-76185-4
© 2011 R.C.S. Libri S.p.A., Milano
I edizione digitale 2013
da I edizione Bompiani
Il Pensiero Occidentale luglio 2011
Al piccolo Santino
P E
IETRO MANUELE
IL MENTALISMO SPERIMENTALE
NEI NUOVI SAGGI DI LEIBNIZ
1. I Nuovi saggi:motivazione del titoloe struttura
Leibniz può essere considerato l’Aristotele dei tempi
moderni. Ciò sia per la varietà e l’ampiezza delle sue
tematiche sia per il peso culturale delle innovazioni da
lui portate. La sua opera spazia dalla logica alla matema-
tica, dalla metafisica all’etica. Può essere considerato il
ponte tra il mondo culturale seicentesco e le nuove aper-
ture alla modernità. Egli non fu, come Spinoza, vir unius
libri, né fu autore di un opus magnum; la sua produzione
va ricercata in una molteplicità di saggi e di interventi
culturali. Il motivo di questa anomalia fu spiegato da
Russell, che del resto valorizzava di più gli scritti minori
di Leibniz, nella sua esposizione critica della filosofia
leibniziana all’inizio del Novecento1. Questa caratteristi-
1 Cfr. B. Russell, A Critical Exposition of the Philosophy of
Leibniz, Routledge 1993, esordio del cap. I: «Sta nel carattere e nelle
circostanze dell’uomo, non nelle sue teorie, che va trovata la spiega-
zione del suo stile di scrittura. Per tutto quel che ha scritto sembra
aver ricevuto qualche stimolo immediato, qualche pressante incenti-
vo: compiacere un principe, confutare un filosofo rivale, sfuggire
alle censure di un teologo... Poche delle sue opere più note sono
prive di riferimenti a qualche persona, e quasi tutte mirano più a
convincere i lettori che a fornire gli argomenti più validi... Per que-
sta ragione spesso troviamo il miglior fondamento del suo pensiero
in brevi scritti trovati tra le sue carte... In essi si trova, di regola,
molto meno retorica e assai più logica che nelle sue esposizioni pub-
bliche, le quali forniscono una concezione inadeguata della profon-
dità del suo pensiero».
ca, che rispetto all’epoca può apparire anomala, di fatto
anticipa le modalità del pensatore-conferenziere dei
nostri tempi: spesso le sue idee più feconde vanno rin-
tracciate in scritti occasionali, ma non per questo meno
influenti.
Anche i Nuovi saggi, nonostante il loro aspetto siste-
matico, sono sorti in realtà occasionalmente da una con-
trapposizione alle idee che Locke aveva esposto nel suo
Saggio sull’intelletto umano2. Il titolo con cui essa ci è
pervenuta presenta subito una questione: perché il suo
contenuto è indicato al plurale anziché al singolare?
Trattandosi di una critica al Saggio di Locke, ci si sarebbe
attesi l’indicazione di Nuovo saggio, alla maniera in cui
Bacone aveva intitolato la sua celebre opera Nuovo orga-
no per contrapporla all’Orga non aristotelico. Siccome
poi non si tratta di un’opera miscellanea, ma di un tratta-
to unitario, l’unica maniera di spiegare l’aggettivo “nuo -
vi” è ritenere che esso si riferisca globalmente sia all’ope-
ra di Locke che a quella dello stesso Leibniz. Il suo senso
sarebbe quindi quello di mostrare come al momento esi-
stano sulla scena filosofica almeno due diverse maniere
di considerare l’intelletto umano, una, quella empirista
di Locke, l’altra, quella razionalista di Leibniz.
È quindi assente dal titolo ogni intenzione polemica,
perché esso non intende contrapporre esplicitamente
una maniera giusta di trattare l’argomento a una manie-
ra sbagliata, anche se nella sostanza questa contrapposi-
zione esiste. L’opera è la trascrizione vivace di un dibat-
2 Leibniz cominciò a stendere i Nuovi saggi nel 1703 ed erano
quasi terminati nel 1704. Però la morte di Locke gli fece sospendere
l’intenzione di pubblicarli, per cui essi appariranno molto più tardi,
soltanto nel 1765.
tito filosofico del tipo di quelli che si svolgevano spesso
nel mondo illuministico, una discussione di grande tol-
leranza e rispetto dell’avversario. A differenza dei dialo-
ghi platonici, che certamente servirono da modello, il
portatore delle idee contrarie non viene demonizzato o
ridicolizzato, ma posto sullo stesso piano di discussione
dell’esponente delle idee leibniziane. Ciò corrisponde
alla notevole civiltà dei salotti intellettuali illuministi,
dove era d’obbligo il rispetto reciproco dei loro parte -
cipanti.
Questo atteggiamento di tolleranza non impedisce
però che uno dei due dialoganti sia evidentemente ap -
pro vato dall’autore a differenza dell’altro. Così, già alla
fine del primo libro, dedicato alla delicata questione
delle idee innate, Filalete, portavoce di Locke, rende
omaggio all’abilità con cui il suo interlocutore, il leibni-
ziano Teofilo, espone le sue controdeduzioni: «Devo ri -
conoscere che voi rispondete in modo alquanto naturale
alle difficoltà che abbiamo avanzato contro le verità
innate» (I, III, § 24). Anzi in maniera sottile Leibniz im -
piega alcune strategie retoriche per far apparire senz’al-
tro vincenti le tesi di Teofilo su quelle del lockiano
Filalete. Come ha mostrato uno studioso delle sue argo-
mentazioni, Marc Parmentier, Leibniz impiega frequen-
temente quattro strategie retoriche: 1) la tecnica della
“piccola differenza”, cioè il non riportare sempre in
maniera rigorosa la traduzione francese del Coste del
testo di Locke; 2) la tecnica diplomatica, consistente nel-
l’evitare di manifestare un disaccordo lampante o siste-
matico nei confronti dell’avversario; 3) la tecnica della
estrapolazione: attraverso di essa Leibniz sostiene che se
Locke avesse sviluppato con maggior rigore il suo ragio-
namento, sarebbe pervenuto alle sue stesse conclusioni;
4) la tecnica dell’anticipazione, cioè, per così dire, quella
di tagliare l’erba sotto i piedi dell’avversario anticipando
ogni sua possibile replica per poi confutarla3.
Il contrasto dei due contendenti permette una vivace
discussione tra una posizione genericamente sensistica,
quale quella di Locke, e una invece aperta alle istanze
intellettualistiche, quale quella di Leibniz. Questo sot-
tofondo polemico che anima l’intera opera può costituire
una difficoltà per il lettore non specialista che l’affronti
direttamente. Essa presuppone infatti la conoscenza
della posizione di Locke, favorevole a valutare positiva-
mente le idee provenienti dai sensi, contro la quale
Leibniz fa valere la chiarezza e la distinzione delle idee
provenienti dall’intelletto.
Questa contrapposizione è la chiave concettuale per
intendere il contrasto tra i due protagonisti, Filalete e
Teofilo. Da principio può condurre fuori strada la deno-
minazione dei due contendenti, dato che l’esponente
della novità leibniziana porta un nome che odora di teo-
logia, Teofilo, che significa “amante di Dio”, mentre
quello del suo avversario, Filalete, significa “amante della
verità”. In effetti, ciò di cui Teofilo è esponente non è
tanto una realtà religiosa, quanto piuttosto il funziona-
mento congruente del mondo. E per una mentalità logi-
ca, quale quella di Leibniz, tale congruenza esprime il
senso stesso della realtà.
Il dialogo fra i due protagonisti si articola in quattro
parti, che corrispondono ai quattro libri del Saggio di
3 Cfr. lo studio di M. Parmentier, Leibniz lecteur de Locke nel
volume miscellaneo Leibniz selon les “Nouveaux Essais sur l’entende-
ment humain”, a cura di F. Duchesneau e J. Griard, Montréal-Paris
2006, pp. 11-18.