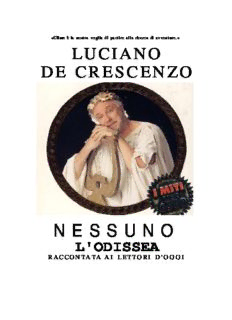Table Of Content«Ulisse è la nostra voglia di partire alla ricerca di avventure.»
L U C I A NO
DE C R E S C E N ZO
N E S S U NO
L'ODISSEA
RACCONTATA AI LETTORI D'OGGI
Luciano De Crescenzo
volumi già pubblicati
in edizione Mondadori
Così parlò Bellavista
Croce e delizia
Oi dialogoi
Il dubbio
Elena, Elena amore mio
I grandi miti greci a fumetti
I miti degli Dei
I miti degli eroi
I miti della guerra di Troia
I miti dell'amore
La Napoli di Bellavista
Ordine e Disordine
Raffaele
Storia della filosofia greca -I
Storia della filosofia greca - II
Il tempo che passa e i battiti del cuore
Panta rei
Socrate
Vita di Luciano De Crescenzo
scritta da lui medesimo
Zio Cardellino
Luciano
De Crescenzo
NESSUNO
Arnoldo
Mondadori
Editore
Nessuno
Caro lettore,
alla fine della mia Odissea, dopo aver ucciso tutti
i Proci, Ulisse lascia Penelope e parte di nuovo. Per
ché lo fa? Perché Ulisse non è un personaggio ma
una mania. Una mania che costringe l'uomo a parti
re. Sempre. Una mania che alcuni hanno e altri no.
Se anche tu ce l'hai, sappi che nel porto c'è una nave
che ti aspetta. Non preoccuparti per la valigia. Non
chiedere il prezzo del biglietto. Non chiedere la de
stinazione. L'importante è partire.
Nessuno
Quando avevo quindici anni la trovata di Odisseo di
dire a Polifemo che si chiamava Nessuno mi entu
siasmò a tal punto che finii col chiedere a mio padre
di cambiarmi nome: volevo anch'io essere chiamato
Nessuno. Lui, però, poco amante dei classici, mi ri
spose alquanto bruscamente: «Pensa piuttosto a di
ventare Qualcuno e non mi scocciare!».
L'Odissea è il primo libro pubblicato in Occiden
te. Come epoca siamo intorno al 530 a.C, grosso
modo sotto Pisistrato, tiranno di Atene, che, con
ogni probabilità, ne fu anche l'editore. Omero, però,
l'aveva raccontata un paio di secoli prima. Protago
nista assoluto del romanzo un eroe chiamato Ulisse,
o, se preferite, Odisseo. Questo dilemma, se chia
marlo Ulisse o Odisseo, mi ha tormentato fin dal
l'inizio. Come appassionato di mitologia greca avrei
dovuto chiamarlo Odisseo, come divulgatore Ulisse.
Il mio portiere Raffaele, tanto per fare un esempio,
se lo chiamo Ulisse mi capisce, se invece lo chiamo
Odisseo non sa nemmeno di chi sto parlando. Altro
dilemma: se intitolare «canti» i vari capitoli, o «li
bri». Ho scelto «canti» e che Dio me la mandi buo-
9
na. D'altra parte l'Odissea è un poema epico, e, che
io sappia, i poemi epici vengono comunemente sud
divisi in canti.
Ultimo dubbio, il secolo in cui si svolgono i fatti:
Il quattordicesimo o il decimo avanti Cristo? Qui,
diciamolo subito, siamo nel caos più assoluto: non
c'è uno storico che sappia con precisione quando
scoppiò la guerra di Troia. Per Duride di Samo era il
1334 avanti Cristo, per Erodoto il 1250, per Erato-
stene il 1184, per Eforo il 1135 e via discendendo fi
no ad arrivare ai contemporanei che parlano del
1000 se non addirittura della prima metà del 900
a.C. C'è infine chi, pur non precisando l'anno, è arci-
sicuro del giorno: l'incendio di Troia, dice, avvenne
il 5 giugno alle 20.30 precise, come dire in «prima
serata». A complicare le cose, poi, ci si è messo an
che il più famoso degli archeologi, quel tale Heinri
ch Schliemann che, a forza di scavare, di Troie (in
tese come città) ne trovò addirittura nove, l'una
sopra l'altra, tutte costruite sulla collina di Hissar-
lik, a due passi dai Dardanelli. Quella nostra dovreb
be essere la settima. Età presumibile il 1200 a.C,
decennio più, decennio meno.
Sui motivi, invece, che scatenarono la guerra non
ci sono dubbi: il rapimento di Elena fu solo un'in
venzione dei poeti. La verità storica parla di tutte al
tre beghe: tra Greci e Troiani esisteva un conflitto
d'interessi relativo ai traffici commerciali tra l'Egeo
e il Mar Nero. I Troiani erano un popolo di camorri
sti che sorvegliavano giorno e notte lo stretto dei
Dardanelli e che imponevano il «pizzo» a chiunque
vedessero passare. Un bel giorno i Greci si stufaro
no e li fecero fuori: tutto qui.
10
Molti si chiedono com'è nata l'Odissea e chi ne sia
stato l'autore. Ora noi, senza addentrarci nella «que
stione omerica», né affrontare il problema se sia
mai esistito un signore chiamato Omero, e se di
Omero ce ne sia stato uno o più d'uno, di una cosa
possiamo essere certi: l'Odissea fu il serial televisivo
dell'epoca. Detto in altre parole, che cosa facevano i
ricchi, la sera, dopo cena, nell'ottavo secolo avanti
Cristo? Niente di eccezionale: ascoltavano un can
tautore, possibilmente cieco, che, in cambio di un
pranzo, o di qualche regalino, raccontava loro una
bella storia a puntate. E chissà che il vero motivo
per cui Ulisse ci mise tanti anni a raggiungere Itaca
non sia dovuto al fatto che, più tappe faceva, più
pranzi rimediava il suo cantastorie.
Ma chi era Ulisse? A mio avviso l'unico vero uo
mo dei poemi omerici. Gli altri, diciamoci la verità,
erano solo dei Rambo, esaltati come eroi più per la
loro prestanza fisica che non per quello che pensa
vano. Gli Achille e gli Aiace, tanto per fare dei nomi,
erano bravi solo a menare mazzate e, in una società
dove le mazzate contavano moltissimo, finivano con
l'essere considerati simili agli Dei. Ulisse, invece,
aveva tutti i pregi e tutti i difetti che un uomo deve
avere: era coraggioso, bugiardo, amante dell'avven
tura, attaccato alla famiglia, e allo stesso tempo tra
ditore, curioso, imbroglione, astuto, farabutto, in
telligente, e, come dicono i milanesi, cacciaballe. Per
definirlo con una sola parola (greca) era un poly-.
Omero, infatti, a seconda delle situazioni, lo defini
sce polytropos (dal multiforme ingegno), polymetis
(dal grande intuito), polyphron (dai molti pensieri),
polymechanos (dalle molte astuzie), polyplanes (dal-
ll
le molte avventure) e via di questo passo. Lui, in
somma, era un «multiplo», qualunque cosa facesse.
Ulisse è la star dell'Odissea, così come Achille lo è
dell'Iliade. Platone, in uno dei suoi dialoghi, l'Ippia
minore, cerca di stabilire chi dei due fosse il miglio
re. A discuterne sono Socrate e un certo Ippia.
«Achille dice sempre la verità» sostiene Ippia «e
se anche, a volte, gli capitasse di dire una bugia, la
direbbe in buonafede. Ulisse, invece, le bugie le dice
per vizio, volontariamente, e sempre per raggiunge
re un suo scopo.»
«Ma allora,» obietta Socrate «chi è il più intelli
gente dei due, e quindi anche il migliore: chi sceglie
tra una verità e una bugia, o chi dice sempre e solo
quello che pensa?»
«Chi sceglie» ammette Ippia.
E così, alla fine, dà ragione a Socrate, anche per
ché, da un certo punto in poi, non ne può più.
«Mi hai convinto, o Socrate,» gli dice «però ades
so lasciami andar via.»
Dovendo parlare, però, sia dell'eroe che dell'im
broglione, ho ritenuto opportuno aggiungere al
l'Odissea un capitoletto finale dedicato all'imbro
glione, dove riporto tutto quello che di denigratorio
sono riuscito a trovare nei suoi confronti. In genere
si tratta di pettegolezzi che comunque, diciamo la
verità, sembrano verosimili.
Per quanto riguarda, invece, l'Odissea, l'ho tradot
ta (si fa per dire) in linguaggio umano, ovvero a uso
dei lettori d'oggi, e di tanto in tanto vi ho aggiunto
qualche riflessione personale. Di versioni italiane
dell'Odissea ne avrò lette una decina, da quella bella,
12
ma oggi quasi illeggibile, di Ippolito Pindemonte
(1753-1829) a quelle in prosa di Giuseppe Tonna
(Garzanti) e di Maria Grazia Ciani (Marsilio) che
peraltro consiglio a chi desiderasse leggere qualcosa
di più aderente al testo omerico. Ovviamente mi è
capitato di copiare, ma, a tale proposito, tengo a
precisare un concetto fondamentale: quando si co
pia da un solo testo si commette un «plagio», ovvero
un reato, quando invece si copia da più testi si fa
della «ricerca», e quindi, alla fine, un'opera merito
ria. Io mi sono molto dedicato alla ricerca. E sem
pre a proposito d'interpreti omerici, anche il Vin
cenzo Monti praticava la ricerca, tant'è vero che il
Foscolo, riferendosi alla sua versione dell'Iliade, lo
definì beffardamente: «il cavaliero, gran traduttor
dei traduttor d'Omero».
13