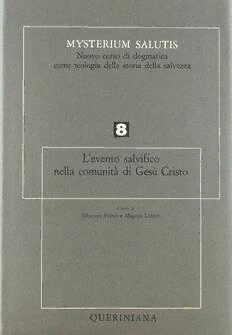Table Of ContentMYSTERIUM SALUTJS
Nuovo corso di dogmatica
come teologia della storia della salvezza
a cura di
J. FEINER e M. LOHRER
edizione italiana ·a cura di
DINO PEZZETTA
QUERINIANA -BRESCIA
L;EVENTO SALVIFICO
NELLA COMUNITA DI GESÙ CRISTO
con la collaborazione di
JOHANNES BETZ · BERNARD DUPUY
JOSEF DUS S-VON WERDT · PETER HUIZING
MAX KELLER · OSKAR KOHLER
RENÉ LAURENTIN · RAPHAEL SCHULT E
ALOIS STENZEL · DIETRICH WIEDERKEHR
FRIEDRICH WULF
parte Il
QUERINIANA -BRESCIA
Titolo originale dell'opera:
MYSTiERIUM SALUTIS
Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik
Benziger Verlag • Einsiedeln 1967
© 1973 by Benziger Verlag • Einsiedeln
© 1975 by Editrice Queriniana · Brescia
Con approvazione ecclesiastica
SOMMARIO
7 Collaboratori
9 Prefazione
11 Componenti parziali dell'istituzione 'Chiesa'
Il servizio divino celebrato dalla comunità cultuale e liturgica adunata in
Cristo (Alois Stenzel) - I singoli sacramenti come articolazione del sacra·
mento radicale (Raphael Schulte) - L'ordinamento della Chiesa (Peter
Huizing).
229 L'eucarestia come mistero centrale (Johannes Betz)
Fondamento biblico-teologico - La storia dei dogmi - Riflessione sistematica.
389 Forme di esistenza e ministeri ecclesiali
Maria come prototipo e modello della Chiesa (René Laurentin) - La Oùesa
come luogo di una multiforme esistenza cristiana (Dietrich Wiederkehr) -
Teologia del laicato (Max Keller) - Teologia del matrimonio. Il carattere sa·
cramentale del matrimonio (Joscf Duss-von Werdt) - Feoomenologia teolo
gica della vita religiosa (Friedrich Wulf) - Teologia dei ministeri ecclesia
stici (Bernard D. Dupuy).
651 La Chiesa come storia (Oskar Kohler)
Il 'tempo' storico-salvifico della Chiesa - Il problema della 'teologia sto
rica' - La storia della storiografia ecclesiastica come storia dell'autocompren
sione della Chiesa - Epoche e 'strutture cronologiche' della storia della Chie
sa - Sull'impossibilità di esporre la storia ecclesiastica come storia della
salvezza,
COLLABORATORI
]OHANNES BE1'Z
Nato nel 1914, dr. teol., docente di dogmatica alla F~co!tà teologica
dell'Università di Wi.irzburg.
BERNARD D. DUPUY, o. p.
Nato nel 192,5, dr. teol., direttore del centro di studi ecumenici Istina,
docente di teologia all'Istituto cattolico di Parigi e alla Facoltà teo·
logica Le Saulchoir .
.TosEF Duss-voN WERDT
Nato nel r932, dr. fil., dr. teol., direttore dell'Istituto per le scienze
matrimoniali e familiari.
PETER HUIZING s. j.
Nato nel 1911, dr. dir. can., dr. dir. civ., lic. fìl., lic. teol., docente di
diritto canonico alla Facoltà teologica dell'Università di Nimega.
MAX KELLER
Nato nel I 939, dr. fil., preside degli studi della Paulus-Akademie.
OsKAR KouLnR
Nato nel 1909, dr. fil., docente di storia universale all'Università di
Friburgo.
REN}: LAURENTIN
Nato nel r9r7, docente di dogmatica alla Facoltà teologica dell'Univer·
sità di Angers.
RAPllAEL Sc11uLT E o. s. b.
Nato nel 1925, dr. teol., docente di dogmatica alla Facoltà teologica
dell'Università di Vienna.
Auns STENZEL s. j.
Nato nel 1917, dr. teol., docente di dogmatica e liturgia al Sankt
Georgen, Scuola superiore di filosofia e teologia, Facoltà teologica S. J.,
Frankfurt a. Main.
DmTRICll WrnDERKEHR o. f. m. Cap.
Nato nel 1933, dr. teol., docente di dogmatica alla Facoltà teologica
dell'Università di Friburgo.
FRIEDRICH WuLF s. j.
Nato nel 1908, dr. tìL redattore capo della rivista Geist und Leben.
Traduttore:
GIOVANNI POLETii
PREFAZIONE
In formato più ampio di quello progettato e-con un po' di ritardo,
vede ora la luce la 2a e 3• parte del vot IV del Mysterium Salutis il
quale, assieme ai capitoli di ecclesiologia tuttora mancanti, contie
ne anche la dottrina concernente l'azione di grazia svolta da Dio.
Sulla sua struttura, sulla sua connessione con l'ecclesiologia e sul
suo inserimento nel quadro generale dell'opera, parleremo nell'intro
n
duzione alla parte 3• del vol. IV. folto numero di collaboratori
chiamati a stilare queste due parti del volume ha aggravato non
poco il lavoro redazionale, tanto più che la consegna dei singoli con
tributi per vari motivi ha continuato a ritardare. Per fortuna, potrà
essere di consolazione al lettore non meno che ai curatori dell'edizio
ne il sapere che si profila ormai all'ori2zonte la fine dell'intera ope
ra, giacché il vol. v dovrà apparire come un tomo unico.
Una introduzione ai capitoli seguenti sull'ecclesiologia sarebbe su
perflua, perché le necessarie avvertenze teoriche e pratiche sono già
state date nella prefazione al volume IV/ r. Con un certo diritto, si
potrebbe chiedersi criticamente se, nell'ambito del Mysterium Sa
lutis l'ecclesiologia non occupi troppo posto. Una sintesi riassuntiva
di questo o quel contributo sarebbe· stata indubbiamente auspicabi
le. Nei limiti del possibile, abbiamo anche stringato qualcuno fra i
manoscritti. Ma per valutare nella maniera più giusta la realtà dei
fatti, bisogna tener presente soprattutto quanto segue: l'ampliamen
to dell'ecclesiologia dipende specialmente dal fatto che una conside
revole parte della dottrina sui sacramenti, un tempo sviluppata in
un diffuso trattato a sé stante, andava necessariamente integrata. E
vi si è giunti anche perché svariati problemi, sinora quasi nemmeno
sfiorati dalla riflessione ecclesiologica (p. es. la presentazione della
Chiesa come sede d'una poliedrica esistenza cristiana, nonché il ca
pitolo sulla Chiesa vista come vicenda storica), andavano pure tassa
tivamente daborati. L'intensificato sforzo proteso a sviluppare i va
ri temi ecclesiologicì è poi senz'altro anche un riflesso della ternati-
IO PREFAZIONE
ca su cui s'è appuntata l'attenzione del Vaticano II. Può benissimo
darsi, per altro, che in seguito la teologia metta di nuovo l'accento
su altri punti. Una dogmatica storico-salvifica deve in ogni caso co
noscere bene il proprio valore e il proprio inquadramento storico.
Può infatti accettare pacificamente 1'a propria relatività storica, pren
dendosi la libertà di affrontare e sviluppare quelle questioni che og
gi si pongono urgentemente sul tappeto, o quanto meno che non
si debbono passar sotto silenzio, qualora si vogliano sviscerare pro
blemi in apparenza ancora più urgenti. La ricezione teologica criti
ca del Vaticano II deve comunque farsi sentire con sempre maggio
re ampiezza nel campo dell'ecclesiofogia.
Cogliamo l'occasione per ringraziare il Dott. P. Odo Lang e il
P. Lucio Simonet di Einsiedeln, per l'aiuto prestatoci nel correggere
le bozze di stampa e nel compilare l'indice analitico dei nomi di
persona.
Zilrich, 1 novembre 197 3
GLI EDITORI