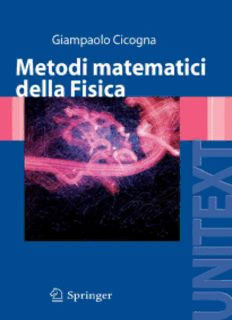Table Of ContentCollana di Fisica e Astronomia
Acura di:
Michele Cini
Stefano Forte
Massimo Inguscio
Guido Montagna
Oreste Nicrosini
Franco Pacini
Luca Peliti
Alberto Rotondi
Giampaolo Cicogna
Metodi Matematici
della Fisica
123
GIAMPAOLOCICOGNA
Dipartimento di Fisica "E. Fermi"
Università degli Studi di Pisa
Springer-Verlag fa parte di Springer Science+Business Media
springer.com
© Springer-Verlag Italia,Milano 2008
ISBN 978-88-470-0833-5
e-ISBN 978-88-470-0834-2
Quest’opera è protetta dalla legge sul diritto d’autore.Tutti i diritti,in particolare quelli relativi alla traduzio-
ne,alla ristampa,all’uso di figure e tabelle,alla citazione orale,alla trasmissione radiofonica o televisiva,alla
riproduzione su microfilm o in database,alladiversa riproduzione in qualsiasi altra forma (stampa o elettro-
nica) rimangono riservati anche nelcaso di utilizzo parziale.Una riproduzione di quest’opera,oppure di parte
di questa,è anche nel caso specifica solo ammessa nei limiti stabiliti dalla legge sul diritto d’autore,ed è sog-
getta all’autorizzazione dell’Editore.La violazione delle norme comporta sanzioni previste dalla legge.
L’utilizzo di denominazioni generiche,nomi commerciali,marchi registrati ecc.,in quest’opera,anche in
assenza di particolare indicazione,non consente di considerare tali denominazioni o marchi liberamente uti-
lizzabili da chiunque ai sensi della legge sul marchio.
Riprodotto da copia camera-ready fornita dall’Autore
Progetto grafico della copertina:Simona Colombo,Milano
Stampa:Grafiche Porpora,Segrate,Milano
Stampato in Italia
Springer-Verlag Italia s.r.l.,Via Decembrio,28 - 20137 Milano
Prefazione
QuestolibrotraelasuaoriginedagliappuntipreparatiperlelezionidiMetodi
Matematici della Fisica tenute al Dipartimento di Fisica dell’Universita` di
Pisa, e via via sistemati, raffinati e aggiornati nel corso dei (molti) anni di
insegnamento. Tuttavia, questi appunti sarebbero rimasti nella loro primitiva
stesura senza l’aiuto di Emilio d’Emilio (a cui desidero rivolgere un caloroso
e amichevole ringraziamento) che ha voluto ricopiare il manoscritto originale,
per conferirgli una veste tipografica presentabile.
Ringrazio anche Mariella Loffredo e mia moglie, che hanno riletto con
grandecural’interotesto.Unringraziamentoinfineatuttiglistudentichemi
hanno segnalato sviste e imprecisioni nelle precedenti versioni.
Per alcuni anni il testo `e stato stampato e distribuito agli studenti di
Pisa dal Servizio Editoriale dell’Universita`; finalmente, grazie anche all’in-
coraggiamento di Giuseppe Gaeta, questo libro, nuovamente riorganizzato e
ulteriormentearricchito,`einfineapprodatoallaCasaEditriceSpringerItalia.
Ringrazio la sig.a Marina Forlizzi per la sua assistenza nella preparazione del
testo in conformita` agli standard di Springer.
La stesura originale di queste lezioni risale al tempo in cui era in vigore il
Vecchio Ordinamento degli studi, in cui il corso di Metodi Matematici della
Fisica era un unico corso “istituzionale” che doveva coprire tutta la mate-
ria. Con l’avvento del Nuovo Ordinamento e la presenza di diversi Moduli di
Metodi Matematici, si `e presentato il problema di come frazionare e adegua-
re la materia. E` stato subito deciso di mantenere sostanzialmente la vecchia
impostazione, preferendo cio`e privilegiare una esposizione completa e senza
interruzioni di ciascun argomento; la divisione del libro in Prima e Seconda
Parte `e semplicemente dovuta a comodit`a di esposizione e non significa n`e
intende suggerire che gli argomenti da svolgere in un Primo Modulo debbano
necessariamente coincidere con la Prima Parte e quelli del Secondo con la
Seconda Parte.
Anzi,unabuonaalternativapuo`esserequelladianticiparelapresentazione
di alcuni argomenti “di base” in modo da renderli immediatamente utilizza-
VI Prefazione
bili, come la serie di Fourier e le prime proprieta` degli operatori negli spazi
di Hilbert, insieme con le nozioni preliminari della trasformata di Fourier (i
primiparagrafidelCapitolo2edelCapitolo4,rispettivamente).Questiargo-
menti possono poi venire opportunamente sviluppati e approfonditi, insieme
con varie altre nozioni e con tecniche matematiche piu` raffinate, in Moduli
successivi.
Un’altra scelta, per esempio, puo` essere quella di anticipare il Capitolo 3,
che`ededicatoallefunzionidiunavariabilecomplessaeche`esostanzialmente
indipendente dai primi due Capitoli.
Per quanto riguarda il contenuto degli altri Capitoli, resta solo da spe-
cificare che il Capitolo 1 `e semplicemente un ripasso “guidato” e finalizzato
agli sviluppi successivi, di nozioni che dovrebbero essere in buona parte gia`
ben note, mentre il Capitolo 5 `e dedicato alla teoria e alle applicazioni delle
distribuzioni (soprattutto le distribuzioni temperate). L’Appendice A infine`e
unapresentazionedelleprimenozioniditeoriadeigruppi,dellealgebrediLie
e delle simmetrie in vista delle loro applicazioni alla fisica.
L’intentogeneralediquestolibro`edifornireunapresentazioneperquanto
possibile semplice e diretta dei metodi matematici basilari e rilevanti per la
Fisica. Anche allo scopo di mantenere questo testo entro i limiti di un ma-
nuale di dimensioni contenute e di agevole consultazione, sono stati spesso
sacrificati i dettagli tecnici delle dimostrazioni matematiche (o anzi le dimo-
strazioni per intero) e anche i formalismi eccessivi, che tendono a nascondere
la vera natura dei problemi e la via piu` adatta per affrontarli. Al contrario,
si `e cercato di evidenziare – per quanto possibile – le “idee sottostanti” ai
diversi procedimenti. Anche le applicazioni proposte sono quelle che meglio
e piu` direttamente illustrano i procedimenti stessi, tralasciando altre appli-
cazioni (Meccanica Quantistica, Elettromagnetismo, Equazioni alle Derivate
Parziali, Funzioni Speciali, tanto per fare qualche esempio) che sconfinano in
differenti discipline. In conclusione, l’obiettivo principale `e quello di mettere
in condizione chi ha letto questi “appunti” di acquisire gli strumenti adatti e
le conoscenze di base che gli permettano di affrontare senza difficolt`a anche
testi ben piu` avanzati e impegnativi.
Pisa, Aprile 2008 Giampaolo Cicogna
Indice
Parte I Strutture vettoriali nella fisica
1 Spazi a dimensione finita .................................. 5
1.1 Primi esempi di strutture vettoriali ........................ 5
1.2 Spazi vettoriali (a dimensione finita) ....................... 7
1.3 Matrici come trasformazioni lineari ........................ 9
1.4 Cambiamenti di base e matrici unitarie..................... 11
1.5 Autovalori e autovettori di una matrice..................... 13
1.6 Diagonalizzazione di una matrice hermitiana ................ 14
1.7 Problemi agli autovalori: applicazioni ...................... 17
1.8 Proiettori e decomposizione spettrale di una matrice ......... 22
1.9 Considerazioni geometriche sulle trasformazioni del piano reale 24
1.10 Gruppi di simmetrie e gruppi di matrici .................... 26
1.11 Strutture vettoriali e principio di sovrapposizione............ 28
2 Spazi di Hilbert ........................................... 29
2.1 Equazione di d’Alembert. Onde stazionarie ................. 29
2.2 Primi problemi concernenti gli spazi a dimensione infinita .... 32
2.3 La serie di Fourier nell’analisi elementare e le sue difficolta`.... 33
2.4 Evoluzione temporale di un’onda elastica ................... 37
2.5 L’equazione del calore.................................... 39
2.6 Prodotto scalare e norma: definizione generale............... 40
2.7 Il concetto di norma come “distanza” ...................... 42
2.8 Alcune osservazioni sulla integrazione delle funzioni.......... 44
2.9 Lo spazio L2(I) ......................................... 46
2.10 Lo spazio di Hilbert: definizione generale ................... 48
2.11 Sistemi indipendenti e ortonormali......................... 49
2.12 Serie di Fourier.......................................... 50
2.13 Sistemi completi......................................... 52
2.14 Spazi separabili e lo spazio (cid:2)2 ............................. 55
2.15 Trasformazioni lineari.................................... 59
VIII Indice
2.16 Continuita` e limitatezza di una trasformazione lineare........ 60
2.17 Una applicazione concernente il problema della corda elastica.. 63
2.18 Operatore aggiunto. Operatori unitari. Proiettori ............ 64
2.19 Autovalori ed autovettori. Spettro di un operatore ........... 68
2.20 Problema di Sturm-Liouville .............................. 71
2.21 L’equazione di d’Alembert in due dimensioni................ 74
2.22 Equazione di Sturm-Liouville con punti singolari.
Alcune funzioni speciali .................................. 75
2.23 Equazione di Laplace e funzioni armoniche.................. 79
2.24 Equazioni alle derivate parziali. Il metodo di d’Alembert ..... 82
2.25 Funzionali. Teorema di Riesz.............................. 84
2.26 Operatore aggiunto ...................................... 85
2.27 Operatori chiusi......................................... 86
2.28 Varie nozioni di convergenza per successioni di vettori e
operatori ............................................... 89
2.29 Operatori compatti ...................................... 91
Parte II Funzioni di variabile complessa.
Trasformate integrali. Distribuzioni
3 Funzioni di una variabile complessa........................ 97
3.1 Prime definizioni. Condizioni di olomorfia................... 97
3.2 Serie di potenze .........................................100
3.3 Integrazione delle funzioni di variabile complessa ............101
3.4 Teoremi di Cauchy. Esistenza di tutte le derivate ............102
3.5 Sviluppi in serie di Taylor-Laurent.........................104
3.6 Zeri di una funzione olomorfa .............................107
3.7 Singolarita` removibili ....................................109
3.8 Punti singolari isolati ....................................110
3.9 Calcolo dei residui.......................................111
3.10 Punto all’infinito ........................................115
3.11 Residuo all’infinito.......................................117
3.12 Punti di diramazione. Tagli ...............................119
3.13 Il lemma di Jordan ......................................123
3.14 Funzioni armoniche e trasformazioni conformi ...............127
4 Trasformate di Fourier e Laplace ..........................133
4.1 Ancora sulle serie di Fourier come “analisi in frequenza”. Il
fenomeno della risonanza .................................133
4.2 Dalla serie di Fourier all’integrale di Fourier ................134
4.3 L’analisi in frequenza e il “principio di indeterminazione”.....136
4.4 La trasformata di Fourier in L1(R) ........................140
4.5 Continuita` della trasformata di Fourier.....................141
4.6 Derivazione e trasformata di Fourier .......................143
Indice IX
4.7 Trasformata di Fourier in L2(R)...........................144
4.8 Inversione della trasformata di Fourier .....................147
4.9 Alcune osservazioni sulla trasformata di Fourier .............149
4.10 L’“impedenza” dei circuiti elettrici e la trasformata di Fourier.151
4.11 Proprieta` della funzione di Green..........................153
4.12 Alcune proprieta` della delta di Dirac.......................155
4.13 Relazioni di dispersione: introduzione ......................157
4.14 Teorema di Titchmarsh. Trasformate di Hilbert .............159
4.15 Relazioni di dispersione di Kramers e Kronig................161
4.16 Presenza di singolarita` nella χ(ω). Mezzi conduttori.........164
4.17 Modello dell’elettrone legato elasticamente..................165
4.18 Trasformata di Laplace: prime proprieta`....................166
4.19 Olomorfia della trasformata di Laplace .....................169
4.20 Inversione della trasformata di Laplace.....................171
4.21 Alcune osservazioni sulla trasformata di Laplace.............172
4.22 La funzione Γ di Eulero ed altre trasformate di Laplace.......175
4.23 Applicazioni alle equazioni alle derivate parziali .............176
5 Elementi di teoria delle distribuzioni.......................179
5.1 Distribuzioni temperate ..................................179
5.2 Convergenza “debole” fra distribuzioni .....................181
5.3 Derivazione delle distribuzioni.............................182
5.4 Trasformata di Fourier per distribuzioni temperate ..........183
5.5 Distribuzioni di Schwartz e distribuzioni a supporto compatto.188
5.6 Proprieta` e applicazioni delle distribuzioni ..................190
5.7 Prodotto e convoluzione fra distribuzioni ...................193
5.8 Funzioni di Green. Il potenziale coulombiano................196
5.9 Funzioni di Green con condizioni al contorno................198
5.10 Funzione di Green per il potenziale nel semipiano............200
A APPENDICE.
Introduzione alla teoria dei gruppi e alle propriet`a di
simmetria .................................................203
A.1 Alcune definizioni generali ................................203
A.2 Omomorfismi tra gruppi. Gruppi quoziente .................204
A.3 Rappresentazioni di un gruppo ............................207
A.4 Rappresentazioni dei gruppi finiti. Caratteri ................209
A.5 Lemma di Schur. Le simmetrie nella fisica ..................212
A.6 Livelli vibrazionali di sistemi con simmetria.................214
A.7 Gruppi di Lie. Definizioni ed esempi generali................216
A.8 Algebre di Lie...........................................218
A.9 Gruppi e algebre di Lie e loro rappresentazioni ..............221
A.10Rappresentazioni differenziali .............................223
A.11Gruppo delle rotazioni ed SU2 ............................225
A.12 Alcune proprieta` generali delle algebre.....................228
X Indice
A.13Rappresentazioni tensoriali e loro decomposizione............229
A.14Qualche conseguenza fisica................................232
A.15Il gruppo di Lorentz .....................................234
Riferimenti bibliografici........................................237
Indice Analitico ...............................................239
Description:Questo testo trae la sua origine da miei vecchi appunti, preparati per il corso di Metodi Matematici della Fisica e via via sistemati, raffinati e aggiornati nel corso di molti anni di insegnamento. L'obiettivo ? stato sempre quello di fornire una presentazione per quanto possibile semplice e diret