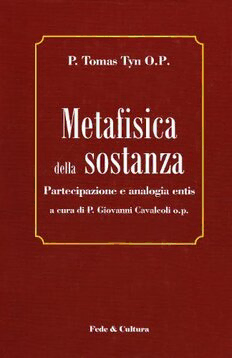Table Of ContentPremessa
U11a settimana ··prima,··· di morire· Padre.· Tòmas··'Tyn O.P. mi
consegnò glf ultimi dischetti 'di ;questo prbfQrtdo e p'odèroso studio di
riì:étafisifa. '.Nell' occasi ohe mi dissè, .· the. gli era·. distato fodlfo: di.eci
arini'di lavoro. - ' .:
In realtà si trattava di dièCianni'.df rifa.gli di tempo, perché Padre
Tomas era un religioso domenicanO, e come ,talè era impegnato in
inolte incombenze • relative alla .·.comunità . e alla: consacta.Zfone
religiosa; era sacerdote; e iri questa veste svolgeva 111.l'ampia opera di
apostolato, soprattutfo di'istruzione e di direzione spirituale; infine,
erà anchè professore dì filù'sofia è 'teolbgia, e questa era la mansione
dii. dedicava grati parte' della sua giorn'a:ta, dato che insegnava per
molte ore· settimanali è scriveva scrupolosamente gli appunti di tutte
lé lezioni. ,. '
Padre Tyn era un prodigio di attività: metodico, intenso e'serèno.
Era innamorato délla filosofia; Soprattutto della tnetafisidi. Se
capitava di avèrlo ' vicino durante i pasti, il discorso -cadeva
inevitabilmente su qualche problema filosofico; Sorretto · da una
straordinaria memoria e da: una: conoscenza' approfondita delle
lingue antiche (ebraico, latino e greco)-e di,alrtieiio quattro lingue
moderrtè/èhe. parlava cofrentemeiite, potevà discutere sulle 'teorie
filosofico-teologiche di moltissimi autori, che spesso citava· nella
lingua: originale. ·· · · - · · -. _
Naturàlmente·:si distingueva: nella: conoscenza della dottrina del
suo maestro, San Tommaso; di .cui nofiisolò portava il 'nom'e;·ma ne
aveva ànche la struttura-mèll.tale, Ia•visione organica e sistematica
dèl sa:père e:soprattutto il culto•appa:ssiOnato·per la Verità.< ·
Padre Tomas era riuscito a penetrare il mistero della Verità che
aveva cercato iiicéssa:Iltemente, che aveva amato come l'unico bene e
che aveva distribuito a piene mani, senza parzialità e ipocrisie, in
modo mite, e pieno di misericordia e di buoni frutti.
Anzi, la sua vita era un segno visibile della Verità che egli
continuava a cercare anche dopo averla trovata, ritenendola più
preziosa della salute, della bellezza e di tutto l'oro del mondo, e che
rendeva· partecipe a tutti invitando senza tregua alla mensa della
sapienza che egli sapeva imbandire con ricche vivande. L'intimo
rapporto, direi la familiarità, che aveva stabilito con la Verità lo
rendeva imperturbabile di fronte agli avvenimenti umani, positivi o
negativi, personali o. comunitan. Quando lo si informava di un fatto
insolito esclamava: «Ah sì?», e la cosa non sembrava impres,sionarlo
più di tanto.
8 Metafisica della sostanza
Rimaneva del suo umore abituale, ovvero gioviale, sorridente,
sempre estremamente rispettoso e" quasi ossequiente di fronte a chi,
a qualunque titolo, gli parlava. Insegnava con passione e non badava
alla cattedra su cui sedeva. Spesso le sue. erano lezioni infor:mali, per
persone semplic~ e non 4ottè, ' e .mm.' di rado accadeva che ' gli
venissero rivolte. obiezioni insipienti. Le accoglieva .con un. sorriso
dolce e rispondeva: «Sì, èvero, lei ha ragione; ma, vede, c'è questo
altro aspetto ... ».'. E lo spiegava con pazieJ.JZfl. . . . .
· Que.l sorriso···.· "clolce" •. che risplendeva :i;iei. suoi occhi. azzurri
gliel'avevo · riyisto à Neckargemiind, 'in. ·Germania, presso la sùa
famiglia, Jn qµell'inconfro avvenlJ.tQ una :settimana prima della, sua
mor,t:e, quando mi.consegnò i dischetti dfquestoHbro. Sapeva che)a
sua malattia era grave' «'e perciò - mi ciisse sorridendo - ho chiesto di
fare la confessione genera~e, perché il: buqn Dio perdoni i miei
peccatacci. Debbo essere pronto se mi.chiama; ho chiesto. anche di
ricevere l'unzione.degli.infermi o, éome si diceva una volta, l'estrema
unzione». ,,
· «I'.a<lre Tomas - gli risposi ~.queste sono cose sante e, certo, noi
dobbiamo ·essere pronti a uniforma,rci alla;volontà di Dio ... ». Ma
prima. che io. potessi pi;oseguire, Padre Tomas mi corresse, sempr~
con il suo . sorriso mite e insieme luminoso: «Uniformarci
perfettame:nte,allà volontà di Dio». , . . . . · · · ... ··· · .. ·,
Caro·Padre Tonias, dopo essere stato, felicemente tuocoI1fratèlio e
indegnam~nte tuo pn~side; mi hai concesso ancheJ'onore di poter
curare, con l'aiuto del P. Roberto Coggi O.P. e del P, AgostinoSelva
O,P., l'edizione di questo tuo primo e ultimo lavoro. In esso si
rispecchialatuaanima.caridida ,che già durante questa vita si .. trovava
al .. terzo .g rado di a,str;izione, proprio .come la metafisica,
completament(! libera da ogni coinvolgimento con la materia. . Grazie.
}'. .V iTJ.cenzo Benetollo O. P.
:.,?
. Pr~f~ione
' 1Leggendo·d'opera: :imponente di Padre Tyn che ho l'onore di
presentare, viene dapprima alla mente l'immagine di una bella oasi
irr> iln · deserto; ' L'oasi: una vigorosa' trattazione di metafisica; il
desertò: ikpensiero·filosofico contemporaneo; .così poco fiducioso
1
nellafotzadella ragfone, così piatto ..· .
. ,.. Questa: impressione, questa immagine debbono in realtà venire
corrette,. ·limate, limitate; anche se non· distrutte. Nel pensiero
odìèrrto pur operano ancora - almeno nel mondo cattolico, ed anche
se hort numerose ...:: voci metafisicamente impegnate.
iMa·anche ilpensiero contemporaneo dialtri orientamenti non è
del tuttò piatto; esso svòlge, con maggiore· o minore efficacia (questo
dipende dal valore dei singoli pensatori e delle singole scuole) un
compito di chiarificazione del linguaggio, di comprensione dei modi
e dei limiti dell'interpretazione, di logica del· discorso scientifico;· esso
- iri misura crescente '-si reinterroga sulle possibilità e sui:limitidel
giudizio niorale, e di conseguenza ·anche sul fondamento di tale
giudizio. < ··
Per i'primi aspetti, il pensiero filosofico - uso le parole auliche-di
uri filosòfo del passatò, Benedetto Croce~ «adempie al suo ufficio»,
anche se non sotto ogni aspetto di tale suo «ùfficio». La riflessione
sulle ·strutture delsapere, .e del linguaggio, prosegue per sempre la
riflessione antica: delfilosofo sulla conoscenza; ·
Per l'ultimo aspetto - quello riguatdan.te la morale - il travaglio
del pensatore contemporaneo;' che si domanda se (e; se sì, in che
modo e per quali vie) abbia un senso un disèorso sulla morale e su
valori ; fotersoggettivamèhte imponenti; si rinvia implicitamente a
questioni che porta:ri-0, ·una volta affrontate adegrtatamente, anche a
reinterrogarsi sul fondainentb assoluto non solo del dovere· morale,
ma anche della rerutàuman~, e della realtàfiriitairi·generale. . '.
Per questa via è sperabile ~he si approdi pòi à: riconsiderare i veti
otniai secolari contro là stessà possibilità logica ·e· gnoseolbgica di
svolgere un dis'còrso meta:fisieo: si tratta di'veti di Òrigine humiana, o
kantiana, '' o' . posithristica, . . oppure . di origine fideistica,
ipersòprannaturalistica. SuquèSti ultimi, tornerò fra tiri momento:
Nel frattempo, vorrei osservare come· il pensiero. dmtemporaneo
dà· l'immagiriè rion df uh deserto, ma di uria superficie a bassa
vegetazione, .con piante da regime atmosferico freddo, ina anche còn
qualche· albero· che tenta.di svettare verso l'alto. Né va dimenticato
che èàppemi'. di ieri ·quell'orientamento' esistenzialistj(:!b che in larga
p'arte 'fifiutò'un'àpettura pOsitiva e costruttiva alla trascendenza, ma
10 Metafisica della sostanza
pur sottolineò - ed efficacemente - l'inevitabile radicazione
ontologica delle scelte umane{ditutte le' scelte umane).
Anche qui: sono stati individuati sentieri - neppure troppo stretti
- i quali si vorrebbe' che non fossero però heideggetianamente
interrotti (Holzwege). . .. , , · ·
A non interromperli .concorrn l'adre. Tyn; 'con la sua possente
opera: ques.ta dunque ·.non si colloca propria.mente .i n .u n deserto,
anche se, certo, non in una foresta <ii piante di alto fusto;J>adre Tyn ~
stato aiutato, nel mantenere;. fede· all'antico jmpegnq del pensiero
metafisico, . dalla tradizioné '.:e.del . suo . grçil).de Ordine, qhlello
domenicano, che no:n·; ha rqai jntermesso , una., viva ,fedeltà
all'insegnamento dei su,oi mae$tri insigni, - primo ~J:i;a tutti )S an
Tommaso d'Aquino:-:- qu:anto a fiducia nella ràgio;ne; :ad· attenzione
costr:uttiva alla metafisica, .. a gusto per .•la.·.• riflessione. filosofica
articolata e sottile. · · · · . · · .
·. . Tutte disposìzioni e qualità che nell'opera di :Padre Tyn .rifulgoiio.
SLbadi; . non si. tratta di obbedienza fideistica; ex:trateoretica
(l'obbe'1ie11za al .suo Ordine), ma.,di .adesione alle esigenze .della
teoresi più rigorosa ~ ,razionale .. È .la fiducia anche• nella .ragione
(oltre che la persuasione profonda di fede) ciò che. porta
manifest1lffiente Pad.re Tyn.. a . ;procedere :come .p rocede, , ed a
condividereJa tradizione del suo Ordine, ,Ques(ultima poi. Io .aiuta e
lo sostiene psicologicamente (inteilectUs humanus luminis siccf ·est;
diceva Leibniz), ma non lo condlziona e rion 10 neèessita/rùtta la: sua
opera, così vigorosamente-impegnata in un lavoro .di ru}alisL e>:Cli
sistemazioni concettuali, ,è .(!d~tante ,e implacabile, e.rappresenta '1a
prova. di un .atteggiarnénto. profondamenJ~ ~a.dieato. nella p~rsoJ.l~ità
originaria di Padre TY:n ...· . ·..... ·.· : . , - · ;, • .. · . .. . ·.· .· · .} .· ·
·.· Il lettore co:ntemporarteo~ r;ion ·più abitji~to ,a: qu,~s.tò rno<io di
procedere, in prima.battuta pot~à essererie anche m1p0', s.conc~rtato;
ma 'io credo che s(tratti .'di unò scdncer;toche .merita di venire
s~perato; per ass~porare l~ ri!'.!ch~zzadel;pellsiero .ch~·ilte~t(). offre'.
Dicevo prima del-rifiµfo di Padretyµ,Jra· gli altri, anche del
«veto»_fideistico. Non è up rifiuto quals.iasi: ·essòconèorrea spiegare
l'uso così paziente'-e sottile delle . dis,tinzioni .e. dei ragfonairienti
complessi fatti costantemente nell'opera; è, ànche qui; qualcosa· che
si
collo.ca nel qùi!dro del grande iiìseg11aµ1erito di Saµ Tommàso,_Ùn
uomo; un fiIOsofò eull, ~antci'che, purfoiiamorato 'della sùa fedé, e
della grazia ,soprannaturale, non volle .l asciar dissòlvere .I a. n_àtura
nèllasopr,annatura. ·. . ·• ·• · . .··• ·•. . , •.• . . . , ·
Ma quiconviene lasciar parlare lo stésso.Padre Tyn,,.il qùale,
nell'introduzione, s_crive .. che «il modo .. divino .• ,dèl' conoscere
i
partècipato aJI'iritèlletto . umano [attraverso fa_ riyeJàzfrnie] .· non
elimiria, ma . suppone il . modo proprlò del conoscere. umano,
PREFAZIONE . .' :' 11
nell'ambito del.quale la,pienezza dell'Essere.divino nonè.ilprimum,
rila .ii:hquàlche; .senso· •addiritfura:Tultirn,um cdgnitum. ·Un certo
fideismo; :oggi di moda, farebbe volentieri a meno dL questo modo
mnaho·.di,conoscenza,Jo reputa ben: poca cosa davanti alla sublimità
dellaJ<rivelaziòne; _a nzh. pensa. che esso 'ostacoli più x che agevoli
rapproccio aldiVinO>);; :
'·Padre-, ·Tyn. ricorda ._,qui Kant, . Lutero, il fideismo
«pseu'c1~soprannaturalistico» (basti pensare - aggiungerei -'. alle
còt'rénti-che"auspicàno -' o auspièàvano ·~ la ·«deellenizzazione del
Cristianesimo»; che 'considerano troppo eurocentrico un filosofare
che sfrutta le categorie elaborate della tradizione, e via dicendo)>
· · -, Contrb':: tale «pséudosoprannaturalismo» egli obbietta: «Per
parlaref·diinqué 'adeguatamente del ·diVino in noi; occorre prima
parlaté dell'umano •in-;noi; e non pensi· di onorare il Creatore e
Redentqre·•chi disprezza; fa' natùra da Lui plasmata- e salvata [ ... ].
Distruggere· la natura non: è esaltare la grazia, ma piuttosto toglierle
.i lsoggetto·di'realizzazione e calpestare la sua sublime dignità di di:mo
gratuito esseniial:in'.ente divino. Se non c'è una natura non ha
nemmeno senso parlare di qualcosa di-soprannaturale. Qui· come
altrove;'.mapiÙ'ancora che altrove, la distinzioneè sorgente di ordine
e di sapienza» .. ,. ·
Fiducia .anéhe nella ragione, dunqùe. E fiducia~ nella ragione
metafisica, in particolare. Che cosa· la ragione metafisica possa e
debba dire, nellàVisione di Padre Tyn, lo si vedrà leggendo il libro. In
questa .sede. rileverò . soltanto che la , sua riflessìòne .si _m uove
all'interno della prospettiva aristotélico~tomistica;-: : con una
partecipazione -propositiva .specifica a quéll'orièntaniento ·;che
sottolinea e sfrutta speculativamente la trascendenza ·dell'essere
rispetto all'essenza di un ente finito, la reale distinzione tra esistenza
ed essenza limitata, e la-dipendenza causale dell'essere particolare
(esistenza) da un principio efficiente esterno.
Padre Tyn svolge uno sforzo - complesso, articolato - di
realizzare una fondazione teorica del nesso tra analogia e
partecipazione, con una particolare attenzione alla diVisione dell'ente
in sostanziale e accidentale.
Si tratta di una strada, e di uno sforzo, che il dibattito metafisico
di orientamento teistico hanno percorso nel nostro secolo in diverse
occasioni, ed al quale Padre Tyn apporta ora un notevole contributo.
Inutile ricordare al lettore che esistono anche altri percorsi a tal
proposito.
Nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, alla cui scuola filosofica
appartengo, in questo secondo dopoguerra si sono battute
soprattutto altre strade, che hanno avuto in Gustavo Bontadini e in
Sofia Vanni Rovighi i loro leader. Ma sono sicuro che entrambi
12 Metafisica della sostanza
questi grandi·Maestri, ·da·poco scomparsi, avrebbero guardato con
interesse l'opera che qui presento.·Sempre.l'Università CattoliCa·di
Milano ha promosso da una decina d'anni un attivo Centro di
Metafisica, che dirigo insieme con Giovanni Reale, e che, soprattutto
grazie all'impulso di quest'ultimo (oltre che a quello di altri valorosi
colleghi), sostiene, favorisce, attua ricerche di metafisica, muoventisi
secondo una pluralità:.di direzioni, ma sempre all'interno di un
orizzonte teistico. .•. .. · . . • . . . ,
Non è un male che ci sianp diverse lineedi approfondimento e di
dibatti te>'_ su di _un ,t ,erreno vitale, difficile e. delicato,. come. quello
metafisico._, . . ....•..... _ " .., ·'" __ , : :. .. ,:_
È anche quest'insieme diricerçhe che concorre a r~ndern .meno
solitarie,. meno situate nel de~erto, op~r~. _come. quella di Padr~. Tyn:
Noto in aggiunta che - con.altro inquadramento,·. con altri:esiti - la
stessadttà di Bologna in cui da u,ltimo (m<:Lper non pochi anni) ha
lavorato Padre Tyn, offr~ ora, attraverso un valoroso coJJega ed
amico dell'Ateneo felsineo Bruno Minozzi, un~altra iml>_onente
trattazione di -metafisica. Anche in altre parti dell'Italia altri studiosi
mostrano interesse per queste tematiche .
.. Padre Tyn non può più, con gli occhi di questa terra, partecipare
al dibattito nella disciplina filosofica a lui più cara. Ma la
Provvidenza ha co11sentito che l'opera fondamentale da lui concepita
arrivasse a compimento, ed ora potesse uscire, ,çurata coli tanto
affetto e jnt~lligenza dai confratelli , d~lle Edi;z;ioni , Studio
Domenicano. Se essa ... ,: come mi auguro ,, susciterà interesse, ed
anche discussioni,.· Padre Tyn<continuerà· a vivere tra noi, ·nella
piccola repubblièa dèi filosofi, e in nostro aiuto, così come già vive
1
ne sono sicuro, nell'eterna luce. · · ,
Adriano Bausdla
.. · · ···. , .. •Presentazione
:.•: .. · ')_.:·
Se Uil() si ffiettesse a cercare nelle librerié delfa:èx-Cecoslovacchia,
paeséd'orlgine ;di TomaÌfTyn, un'opera dì metafisica simile alla sua,
dovr~Bbé dopo· un ·certo témp6 riconoscere· la vanità ·di una tale
impresa. Sul mercato della··1etteratura filòsofica'.della Repubblica
Ceca,non si offrono lavori di questo tipo. Ciò si spiega non solo cmi il
fatto' che la tradizione ' del . pensiero filòsofico ceco-slovacco,
abltuàÌmeÌlte orientata in dfrezione piuttosto pragmatica, risulta
merlo rigogliosa' a paragone ·ai quella italiana, bensì pure con il
fei:ibmeifo, dal quale n6n è rimast(l~risparmiata neanche l'atm'osfera
intellettualé in Italià. Anche qui, come del resfo iri tutto l'Occidente
odi.enio,-1mpera per ben certi motivi lino spirito "postmetà:fisieo". La
nìetafi~icf! non viene più arinoveratà fra le scienze degne di· questo
nÒme''è se mal viene presa hr considerazione Iò si fa o pèr ·criticarla
radi.calmente o· per· còUacarla .i ri' una st6ria .d i ·idee. che .p rescinde
completamente dà termini vahitativi "valido-invalidò;,,·. "vero-falso".
Se
'la situazione. éulturàle in cui viviamo si profila in una: tale
maniera, hon 'possiamo nÒh chiederci se la seconda edizione del libro
di Tomas Tyn non sia già in anticipo votata all'insucesso .
. La
fisposta, che di sicuro ·sarebbe stata anche quella di Tomas Tyn
se ancora fosse vivcffra di'rioi;'non perinetténessutià esitazione, La
filosofia,· almeno quella coltivata dal. nosti:oAutore, non mirà al
s1lccesso, all'applatiso, al' éortseiiso della· maggioranza. Bi 'hiteressa
dellà verità concernente l'intero del reale, e 'qliesta verità; essendo
tr.ascendentaln:iente dispiegata;. norr ha bisogno. di· aggrapparsi su
appoggi esternt Tramite un procedimento auto-critico. gfostifica ·sé
stessa ed è perciò sicura di 'sé malgrado lostilità nella Aual~ si
imbatte, nel inondo d'bggi: Tomas Tyù' sapeva perfettamente tutto
questo elo stile'fèrmo ed audace, con cui stese la sua grande opera,
un
rie è tèstiinone eloquente. ' ' ' ' '
Il titolo dèsignahte il tema principale del 1ibrà nari. è· statà Scelto a
caso. Ahzi, non ne poteva esser preferito uno migliore. Se lo
ponaeHamo C:on·attenzionè, ci rendiamo subito cdI1to che concentra
tuttfi concetti di base attorno .à i quaii Tomas Tyri organizza la sua
ricerca.· dettagliata:· metafisica, sostanza, partecipazione, 'analogià
déll'éhte. Non sono concetti legati da merfràpporti'esterìoTI, ma
cor1cetti intimamente dipendertti;.l illterconnessi da ' un profondo
{eliso coin1.me'.Vediamoli più da vicino; . ·. · .·. . •.. · · . . . ..
, : Che cosa è 'la metafisica per il nostro·filosofo moravo?' Una
disciplina filosb:fiç~ la cui validità, hecèssità e fondamentalità' non
non' a
può essere esplicitamente rtegata se prezzo :di unà' infausta
autocontra:dditorietà di tali negazionL 'La ragione umana tematizza
-.< ,."_ ,,... ·'.
14 Metafisica della sostanza
naturalmente e perciò necessariamente la realtà come intero. La
prova ne è l'incontestabile:oggettività del concetto trascendentale di
"ente" che viene implicito in ogni altro concetto, eccetto quello di
"nie11te", il quale però "ne subisce l'influsso", dato che neppure esso è
formulaqilé a preseindere dal suo opposto. Tomas Tyn esprime
questa verità quando .riflette sull'ente come. su ciò che rappresenta di
diritto l'infOrma.ziorie primaria della ragione umana (ens ut primum
cognitum). ' ' ·, ' ' ' ' • ' ,, ' ' '
Assieme con Aristotele e .Tommaso d'Aquino .c ondivide, .la
èonvinzi0rie .. incontrovertibile secondo la quale l'attacco ·. alla
métafisica porta con sé l'attacco a tutte le scienze. Se la metafisica
non adempie ai criteri. della sdènti:ficità, nesslln'altrascienza risulta
poss!bile: perché tutte le scienze dette "particolari" comprendono nei
loro organismi epistemici elementi di cui, a causa ,della loro
particolari~à, non sono capaci di render conto .. Nessuna scienza
riesce a costituirsi facendo a meno' dei concetti di. teina di 'ricerca,
e
identità, differénza, relaiioné simili. Ma n~ssuna 'scièÒ.za settoriale
possiede la· competell~a di poi;tar fi110 'allà giust~ficazioIÌe .u ltima. i
concetti menzionati,· perché essi si distendono pure su quelle regioni
di realtà che oltrepassano i limiti metodici di sirigòli prospettive
investigative. . . . . .· . ·· . · .·. .· .. ·
Perfar un esempio, la màtematica non tièsce çt fondare la validità
oggettiva dei concetti di identità, differenza,' relazfone, etc. .. , poiché
anchè fuori'del suo campo di indagine e quindi fuori deila sua presa
hìtènziOnalé (competenza) si .danno ,altre realtà caratterizzate da
identità; différènià; relazione. E.ciò vàie.inriiod0 anaiogo per tutte iè
sdenze metodicamente ristrette. Inoltre, la discussa competenza
non:
rl1etafisic1). la si ptiò delegare ad mia scienza elàborante i risultati
di tµ,tte le scienze particolari rivolti allà ricerca del' mondo materiale,
perché fin dal primo approccio alla · realtà niente vieta ahnenq
un'.ipotetiCa appliCabilità · dei . concetti .di identità, · differenz.a,
relazione, etc. .. ; anche fuori del mondo inçtteri.ale. Ergo, bisegria
avere una met3:fisica del tipo .~ristotelico, vàie· à dfre, u~a sciem;a di
un'estensione propriamente ·· trascenderitafo,. .T rascendentale .. nel
a
senso che non esclude priori la possibilità di 'un ente immateriale .. '
tèri.taÌjyo,
In tali circos~an~e non .c'è da meravigliarsi che ogni ~i
chiudere il pensiero umano nell' èrnpiria ·. aieàtoJ::ia, nella ~foria
pµq ·
irripetibile, in una· data condizfone culturale, etc,~.~. 116n ché
failire. Ci vi,lole oggi mqlt0 coraggio per contestare. le ideologie di
questo tipÒ, però ancora di più ci vuole molta intelligenza ·p~r
riuscire .in q~esta (lifesa. del~çt nam,ra della ragi9ne ·umana e qùhidi
dell'uomo stesso~. Chi p0P,:e dei limiti alla' ncistr~ capacit~· .di
0
ràppoi:tar~i interizio,nalmeiite 'alla' realtà nella sua interezzà
propriamente trascei,ide#tal~,'dimentica chii'i limiti dichiarati v~nrio
rivolti prima di tutto a tjùesfa stessa tesi. ·. . · ··