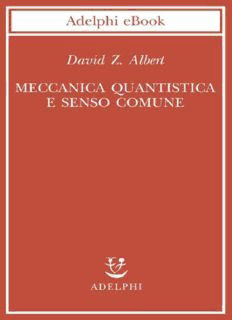Table Of Content«Quella che mi accingo a raccontare è una storia sconcertante. Si tratta forse
della storia più sconcertante che sia mai emersa nell’ambito delle scienze
fisiche dal diciassettesimo secolo in poi. Ed è anche una storia vera»: così
Albert avvia questa sua appassionante indagine. Di fatto, come base di una
tecnologia di uso quotidiano che comprende il laser e il transistor, il «quanto di
energia» è familiare anche ai profani. Tuttavia la meccanica quantistica resta,
nei suoi fondamenti concettuali, un enigma inquietante. Visti da vicino, i
fenomeni quantistici più semplici pongono continue sfide alla logica e al senso
comune, e se la scoperta da parte di Einstein che lo spazio e il tempo sono di
fatto un continuum deformabile colse il mondo di sorpresa, la nuova
meccanica, rivelando un elemento di incertezza e di imprevedibilità al fondo
delle cose, fu un vero e proprio trauma, dal quale la fisica non si è mai del tutto
ripresa: nel microcosmo atomico, benché Einstein disapprovi, «Dio gioca a
dadi». E la via verso il caso è pericolosamente aperta. Un simile stravolgimento
delle categorie della mente richiede di solito, per riuscire accettabile, anni di
iniziazione. Nell’intento di ridurre al minimo questo tirocinio, Albert ci fa
letteralmente toccare con mano, col suo stile inimitabile, i risultati paradossali
in cui sfociano le esperienze fondamentali della meccanica quantistica e il
fallimento di ogni tentativo di conciliare le osservazioni sperimentali con il
senso comune. Dopo un primo capitolo dedicato allo sconcerto del lettore, egli
vince la scommessa di rendere accessibile al profano il frammento di
matematica necessario all’esposizione di fatti fisici quali la sovrapposizione, il
problema della misurazione, il paradosso Einstein-Podolsky-Rosen, la non-
località. E offre uno strumento concreto per partecipare a una delle più
affascinanti avventure della scienza.
Indice
Frontespizio
Colophon
MECCANICA QUANTISTICA E SENSO COMUNE
Prefazione
1. Sovrapposizione
2. Il formalismo matematico e il modo standard di intenderlo
3. Non-località
4. Il problema della misurazione
5. Il collasso della funzione d'onda
6. La dinamica da sola
7. La teoria di Bohm
8. Automisurazione
Appendice - Le interpretazioni di Kochen-Healy-Dieks
Nota all’edizione italiana
Bibliografia
Note
David Z. Albert
Meccanica quantistica
e senso comune
Traduzione di Tullio Cannillo
Adelphi
TITOLO ORIGINALE:
Quantum Mechanics and Experience
Prima edizione digitale 2014
©1992 THE PRESIDENT AND FELLOWS
OF HARVARD COLLEGE
©1993 ADELPHI EDIZIONI S.P.A. MILANO
per il brano di Zbigniew Herbert tratto da
Rapporto dalla Città assediata
©2000 ADELPHI EDIZIONI S.P.A. MILANO
www.adelphi.it
ISBN 978-88-459-7558-5
A mia moglie, Orna
MECCANICA QUANTISTICA
E SENSO COMUNE
l’uccello è uccello
la schiavitù schiavitù
il coltello è coltello
la morte morte
ZBIGNIEW HERBERT,
Il Signor Cogito e l’immaginazione
PREFAZIONE
Questo libro è stato scritto sia come testo elementare sia per tentare di
contribuire a una miglior comprensione, al livello più avanzato oggi possibile,
di ciò che a mio avviso è il problema cruciale dei fondamenti della meccanica
quantistica, il problema della misurazione.
I primi quattro capitoli sono un’introduzione più o meno diretta e lineare al
problema: il capitolo 1 riguarda il concetto di sovrapposizione, che è il
principale elemento di distinzione tra l’immagine quantomeccanica del mondo
e quella classica; è di lì che provengono tutti gli sconcertanti interrogativi posti
dalla meccanica quantistica. Il capitolo 2 sviluppa – in una forma che non
presuppone, o non dovrebbe presupporre, alcuna conoscenza matematica nel
lettore – il formalismo standard della meccanica quantistica e descrive a grandi
linee come esso dovrebbe essere interpretato secondo l’opinione convenzionale
vigente tra i fisici. Il capitolo 3 tratta l’argomentazione di Einstein, Podolsky e
Rosen e il modo in cui, sorprendentemente, essa è stata scalzata da Bell – e qui
si sottolinea, per inciso, che il significato della sua scoperta è stato spesso
frainteso, giacché Bell ha scoperto non soltanto qualcosa a proposito delle
teorie delle variabili nascoste, ma anche a proposito della meccanica quantistica
e a proposito del mondo. Il capitolo 4, infine, affronta esplicitamente il
problema della misurazione.
Il resto del libro (la parte più corposa) è dedicato all’esame delle idee – che
cosa fare per il problema della misurazione – che a parer mio hanno una
qualche possibilità di andare a segno. Il capitolo 5 è un’illustrazione critica del
concetto di collasso della funzione d’onda (con un’analisi approfondita dei
recenti progressi di Ghirardi, Rimini e Weber). Il capitolo 6 verte su un modo,
non poco confuso e nondimeno stimolante, di considerare il problema della
misurazione, che va sotto il nome (fuorviante) di «interpretazione a molti
mondi» della meccanica quantistica. Il capitolo 7 concerne una teoria
alternativa, del tutto deterministica, alla meccanica quantistica, dovuta a de
Broglie, Bohm e Bell. E il capitolo 8, infine, descrive come potrebbero essere le
vite mentali di osservatori senzienti qualora l’una o l’altra delle ipotesi
avanzate nei capitoli 6 e 7 fossero effettivamente fondate.
Molte persone mi hanno aiutato in questo lavoro. Vorrei citarne alcune.
Barry Loewer è colui che per primo ha lanciato l’idea di scrivere questo
libro, e dando prova di un’incredibile disponibilità ha trascorso ore e ore del
suo tempo a discuterne con me: molti degli spunti originali, come il lettore
potrà desumere dalla bibliografia, sono in parte farina del suo sacco. Non fosse
stato per questo, il libro, semplicemente, non avrebbe mai visto la luce.
Sui fondamenti della meccanica quantistica ho imparato molto, nel corso
degli anni, dalle interminabili conversazioni avute con (soprattutto) Yakir
Aharonov, e poi con Hilary Putnam, David Deutsch, Irad Kimchie, Marc Albert,
Gary Feinberg, Lev Vaidman, Sidney Morgenbesser, Isaac Levi, Shaughn Lavine
e Jeff Barrett, nonché con studenti di alcune classi in cui ho insegnato.
Sono molto in debito con Andrea Kantrowitz per il gran lavoro fatto sulle
figure, e sono grato a Lindsay Waters e Alison Kent, e specialmente a Kate
Schmit della Harvard University Press: senza il loro aiuto e la loro
comprensione il risultato finale sarebbe stato assai meno soddisfacente.
E forse dovrei accennare al fatto che questo libro è stato scritto nella
speranza di ottenere finalmente la ragionevole approvazione di mio zio, il fisico
Arthur Kantrowitz, che per primo mi iniziò alla scienza, in merito alla mia
capacità di spiegare tutte queste cose.
1
SOVRAPPOSIZIONE
Quella che mi accingo a raccontare è una storia sconcertante, che ha per
protagonisti gli elettroni. Si tratta forse della storia più sconcertante che sia mai
emersa nell’ambito delle scienze fisiche dal diciassettesimo secolo in poi. Ed è
anche una storia vera: tutti gli esperimenti che descriverò sono stati realmente
eseguiti.1
La vicenda si sviluppa intorno a due particolari proprietà fisiche degli
elettroni, che la tecnologia corrente già permette di misurare con grande
precisione. Possiamo prescindere da una definizione fisica rigorosa di tali
proprietà, che chiameremo semplicemente «colore» e «durezza»
dell’elettrone.2
La proprietà degli elettroni che abbiamo denominato «colore» può
assumere soltanto due valori, e questo è un fatto empirico. Ci siamo finora
imbattuti solo in elettroni neri o in elettroni bianchi; non ne abbiamo mai
trovati di blu o di verdi. Lo stesso vale per la durezza: tutti gli elettroni sono o
teneri o duri; non si è mai osservato per la durezza di un elettrone un valore
diverso.
È possibile costruire ciò che chiameremo una «scatola per il colore», un
dispositivo per misurare il colore degli elettroni, che funziona nel modo
seguente: la scatola ha tre aperture (fig. 1), e gli elettroni vengono immessi
attraverso l’apertura sulla sinistra: se l’elettrone in entrata è nero allora esce
(linea tratteggiata) dall’apertura n («nera»); se è bianco esce dall’apertura b
(«bianca»). Il colore di un elettrone entrante può essere così desunto dalla sua
posizione finale. E possibile costruire anche scatole per la durezza, funzionanti
esattamente nella stessa maniera (fig. 2).
Description:«Quella che mi accingo a raccontare è una storia sconcertante. Si tratta forse della storia più sconcertante che sia mai emersa nell’ambito delle scienze fisiche dal diciassettesimo secolo in poi. Ed è anche una storia vera»: così Albert avvia questa sua appassionante indagine. Di fatto, com