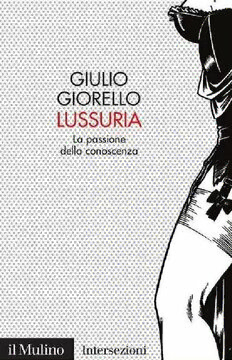Table Of ContentLUSSURIA
«Solo per colpa di cristiani impostori la lussuria è stata classificata
tra i crimini». Così si esprime Sade sul finire del Settecento, quando
i «lumi» della Ragione stanno cedendo il posto alle «lanterne» del
Terrore. Si potrà concordare o meno con il Divin Marchese, ma
la lussuria, più che un peccato, appare una forza debordante della
natura. Sarà anche un vizio, ma sappiamo come da vizi privati
nascano pubbliche virtù. La lussuria non è solo manifestazione di
eros, creatività artistica, piacere della scoperta scientifica. E anche
e soprattutto passione del conoscere, nel senso più ampio della
parola. E per ciò può costituire il nucleo di una società aperta
e libertaria, insofferente di qualsiasi costellazione di dogmi stabiliti.
Così, in queste pagine, come complici della lussuria possono
comparire i tipi più inaspettati: Dante, Shakespeare, Bruno, Mozart,
Bunuel... Ma l'indiscusso protagonista resta sempre lui: Don Giovanni,
che ancora una volta ripropone l'eterno viaggio attraverso la lussuria
come potere, come piacere, come inganno e soprattutto come libertà.
GIULIO GIORELLO
Insegna Filosofia della Scienza all'Università degli Studi di Milano. Tra le sue
pubblicazioni: «Di nessuna chiesa» (Raffaello Cortina, 2005), «Introduzione
alla filosofia della scienza» (Bompiani, 2006), «Libertà. Un manifesto per
credenti e non credenti» (con D. Antiseri, Bompiani, 2008), «Lo scimmione
intelligente» (con E. Boncinelli, Rizzoli, 2009).
€ 15,00
Cover design: Miguel Sai &
In copertina*. © 2009 by Me
_ bv permission; Satanik è ci
I lettori che desiderano informarsi sui libri e sull’insieme delle attività
della Società editrice il Mulino possono consultare il sito Internet:
www.mulino.it
ISBN 978-88-15-13329-8
Copyright © 2010 by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti
sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fo
tocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi
forma o mezzo - elettronico, meccanico, reprografico, digitale - se non
nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d’Autore. Per altre
informazioni si veda il sito www.mulino.it/edizioni/fotocopie
Indice
Prologo p. 9
La «casta» Susannah 9
Eva futurista 10
Buio a mezzogiorno. Lusso, lussuria, lussazione 11
Eunuchi e stalloni 14
Schema di questo libro 16
I. Le dee «false e bugiarde».
Lussuria come (im)potenza 21
«Istar delle stelle» 23
Inanna, l’albero e il tempio 23
Lussuria, morte, conoscenza 27
La pianta dell’irrequietezza 29
Il nudo di Inanna 31
Nata dalla spuma del mare 34
«Questa è Venere per noi» 35
Troppi dei in camera da letto 38
Nudi, a colazione 41
IL Cleopatra e le altre.
Lussuria come (contro)potere 45
Due volte il sole 47
La nube purpurea 49
Nel vento 52
Nebulose del cielo e serpenti d’Egitto 55
Didone abbandonata (e mai presa) 59
La belle Hélène 62
«La natura mi ha donato un corpo di donna» 64
Indice
III. Miseria e splendore delle dame galanti.
Lussuria come piacere (e dolore) p. 69
Macchine e lussuria 71
Il «messale culabriense» 72
Fuoco d’amore 74
Sovrana e puttana 77
Paradosso della «mitezza» cristiana 79
Il copione di Anna Bolena... 81
«Ma le gambe...» 86
IV. Settecento mogli e trecento concubine.
Lussuria come filosofia 93
Il «peccato» di Salomone... 95
... e quello di Giordano 96
Santa e matrigna 99
Vincolo dei vincoli 101
Il volo della farfalla 107
La zampogna di Pan 108
«Dappertutto e in nessun luogo» 110
V. Regine della notte.
Lussuria come inganno 115
E così sino al delitto 117
Desiderio e tradimento 120
Avvelenare l’anima 122
Inganni sivigliani 124
Agonie 127
«La bella religione dell’aritmetica» 133
L’artista e la sua musa 136
VI. Giochi di specchi.
Lussuria come sovversione 141
Il consiglio di Bouvard, ovvero i modi
dell’immaginazione 143
Continuavano a chiamarlo Trinità 146
«Ancora uno sforzo...» 148
Distruggere se stessi 153
Indice
Epilogo p. 159
«Odor di femmina» 159
Cervello e linguaggio 160
Leoni, libertini e libertari 164
Congedo 167
Bibliografia 171
Indice dei nomi 195
Ringraziamenti 199
Crediti iconografici 200
Oh lussuria, nostro rifugio e nostra forza.
James Joyce
Prologo
La «casta» Susannah
Una sera di carnevale, tra belle dame mascherate, il nar
ratore di II convitato delle ultime feste, tratto dai Racconti
crudeli (1883) di Jean-Marie-Mathieu-Philippe-Auguste,
conte di Villiers de l’Isle-Adam, autore del più celebre Èva
futura (1886), è attratto da tale «Annah, o piuttosto Susan
nah Jackson, la Circe scozzese, dai capelli più neri della
notte», che «brilla indolente nel velluto rosso». Come dice
uno dei personaggi, è «venuta al mondo [...] al solo scopo
di ricordarci che la neve brucia». A questo «complimento
lambiccato», formulato al declino della festa, si affianca la
presentazione della «fredda Susannah» da parte del narra
tore:
Quella non incontratela, giovane straniero! E pari alle sabbie
mobili: affossa il sistema nervoso. Distilla il desiderio. Una lunga
crisi morbosa snervante e folle sarebbe la vostra sorte. Annovera
diversi lutti fra i suoi ricordi. Il suo tipo di bellezza, di cui ella è
sicura, provoca nei semplici mortali la febbre fino alla frenesia.
Noi, invece, invitiamo lettrici e lettori ad andare in
contro, su queste pagine, a tale casta personificazione della
lussuria. Non si lascino fuorviare dalle ammonizioni che il
narratore rivolge a giovinetti di corpo non robusto e pen
siero debole.
Per quanto vi supponiate di essere raffinato (in un’età forse
ancora tenera, giovane straniero!), se la vostra cattiva stella per
metterà che vi troviate sul [suo] cammino [...], non ci resterà che
immaginarci un giovanissimo che si è sostentato esclusivamente di
uova e di latte per vent’anni consecutivi, sottomesso d’un tratto,
9
Prologo
senza vari preamboli, a una dieta esasperante (continua!) di spe-
zie extrapiccanti e di condimenti il cui sapore ardente e fine gli
sconvolge il gusto, lo spezza e lo stordisce, per avere il vostro
fedele ritratto di lì a quindici giorni.
Non stiamo propinando un altro vizio sotto la copertina
«Lussuria». La metafora culinaria di Villiers de l’Isle-Adam
cederà il passo, nelle pagine del nostro libro, a una glorifica
zione della potenza femminile di ben diversa caratura. «Non
più donne piovre dei focolai, dai tentacoli che esauriscono
il sangue degli uomini e anemizzano i fanciulli»: saranno
piuttosto femmine «bestialmente amorose, che distruggono
nel desiderio anche la sua forza di rinnovamento».
Èva futurista
Quest’ultima citazione non è più da Villiers de l’Isle-
Adam, bensì è tratta dal Manifesto della Donna futurista,
stampato nel 1912 in volantini a Parigi e a Milano da una
signora che, quanto a nome e cognome, può competere
con l’autore di Èva futura: Anne-Jeanne-Valentine-Marianne
Desglans de Cessiat-Vercell, più nota come Valentine de
Saint-Point. Di illustre ascendenza (lionese, pronipote di
Lamartine) ha al suo attivo una trilogia {Un amour, 1906;
Un inceste, 1907; Une mort, 1910); del suo talento ha dato
prova anche in pittura, al Salon des Indépendants. Non
prendetela per il contraltare femminista di Marinetti (poi
ché sul femminismo del proprio tempo Valentine nutriva
non poche perplessità):
Si lasci da parte il Femminismo. Il Femminismo è un errore
politico. Il Femminismo è un errore cerebrale della donna, un
errore che il suo istinto riconoscerà. No» bisogna dare alla donna
nessuno dei diritti reclamati dal Femminismo. L’accordar loro questi
diritti non produrrebbe alcuno dei disordini augurati dai futuristi,
ma determinerebbe, anzi, un eccesso d'ordine.
Così si legge nel Manifesto. L’errore «cerebrale» è anche
«politico», perché l’esigere dei diritti per le donne equi
10
Prologo
vale a imporre loro dei doveri, e questo significa relegare
ancor più «la femmina» nel ghetto da cui si pretende di
toglierla. Se le parole di Valentine possono funzionare come
rasoio di Occam (o di Un chien andalou di Bunuel e Dall,
1929: pensiamo alla scena in cui una lama affilata incide
l’occhio troppo curioso di una donna) contro il proliferare
di ideologie femministe lasciamo giudicare alle lettrici (e
anche ai lettori). Comunque, l’enfasi di Valentine sui ri
schi dell’eccesso d’ordine evidenzia la sua distanza dalla
«casta Susannah» di Villiers de l’Isle-Adam: in quel caso
l’ordine era spezzato dalla lussuria, ma era l’ordine ciò che
il notturno narratore rimpiangeva; qui è il disordine a essere
«auspicato» dal futurista, a prescindere {pace Marinetti) se
sia di genere maschile o femminile, quasi che si trattasse
di sovversione programmata. La lussuria è forza, proclama
Valentine in un secondo volantino, il Manifesto futurista
della lussuria (1913, sempre Milano e Parigi):
La lussuria è l’espressione di un essere proiettato al di là di
sé stesso; è la gioia dolorosa di una carne compita, il dolore gau
dioso di uno sbocciare; è l’unione carnale, quali si siano i segreti
che uniscono gli esseri; è la sintesi sensoria e sensuale di un essere
per la maggior liberazione del proprio spirito; è la comunione
d’una particella dell’umanità con tutta la sensualità della terra; è
il brivido panico di una particella della terra.
Lungi dall’essere «peccato capitale», la lussuria sarebbe
«virtù incitatrice». Anzi,
solo la morale cristiana, succedendo alla morale pagana, fu por
tata fatalmente a considerare la lussuria come una debolezza. Di
quella gioia sana che è l’esplosione d’una carne possente, essa ha
fatto una vergogna da nascondere, un vizio da rinnegare. L’ha
coperto di ipocrisia, e questo ne ha fatto un peccato.
Buio a mezzogiorno. Lusso, lussuria, lussazione
Questo doppio rovesciamento (la lussuria, trasforma
zione da forza vitale a vizio, e da vizio a peccato), però, per
11