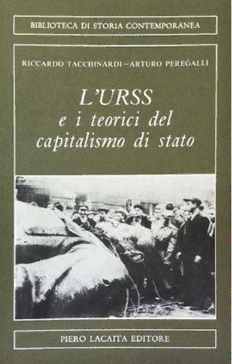Table Of ContentLa Biblioteca di storia contemporanea intende pubblicare volumi
monografici, antologici, di testi e documenti, oltre che contribuiti di
dibattito storico-politico con un criterio della contemporaneità consape
vole dell'origine e delineazione di processi politici, sociali ed economici
anche in fasi che si collocano al di qua del secolo ventesimo.
L’apertura più ampia ad approcci metodologici e orientamenti culturali
diversi risponde alla grande varietà del lavoro storiografico oggi in atto,
oltre che alla tradizione culturale della Casa editrice.
.Volumi pubblicati:
Domenico Sacco, Socialismo riformista c Mezzogiorno. Questione agra
ria, istruzione e sviluppo urbano in Basilicata in età giolittiana.
Antonio Donno, Anna Rlta Guerrieri, Giuliana Iurlano, La
sovranità dell'individuo. Tre saggi sull’anarchismo negli Stati Uniti.
GIANNI C. Donno, Socialismo e modernizzazione. Studi di storia del
movimento operaio e del PSI nel Mezzogiorno.
An tonio Moscato, Chiesa, partito c masse nella crisi polacca (1939-
1981).
IRMA TADDIA, La memoria dell’Impero. Autobiografie d’Africa Orientale.
VALERIO Evangelisti, Gallerie nel presente. Punks, Snuffs, Contras: tre
studi di storia simultanea.
N..‘Badaloni, B. Centi, S. Miccoi.is, A. Meschiari, E. Agazzi, E.
Andreucci, A. Panaccione, S. Barbera, A.M. Iacono, D. Bidussa,
F. ¿BARBERI, D. Al.BER.S, Antonio Labriola nella cultura europea dell’Otto
cento, a cura di F. Sbarberi. Presentazione di ,Eugenio Garin.
Giannt C. DONNO, Scuola e Socialismo nel Mezzogiorno 1895-1915.
Francesco Leoncini, L’opposizione all’Est 1956-1981. Raccolta di testi
con introduzione e bibliografia.
FRANCESCO Leoncini (a cura di), Che cosa fu.la «Primavera di Praga»?
Idee e progetti di una riforma politica e sociale.
SEVERINO Galante, Alla ricerca della potenza perduta. La politica estera
di DC e PCI negli anni ’50.
ANNA Maria Cittadini Cipri', Meridionalismo e Azionismo nel crepu
scolo sabaudo.
Aa.Vv., Storie e Immagini del 1° Maggio, problemi della storiografia
italiana e internazionale, a cura di Gianni C. Donno.
MAURIZIO ANTONIOLI, Azione diretta e organizzazione operaia.
MAURIZIO ANTONIOLI, Borghi e l'unione sindacale italiana.
R. Tacchinardi, A. PereGALLI, L'Urss e i teorici del capitalismo di stato.
Volumi di prossima pubblicazione:
DOMENICO Sacco, Cattolici e Socialisti nel Mezzogiorno. Il caso lucano
1885-1915. '
EDWARD E. Miller, La politica estera italiana nel secondo dopoguerra,
introduzione di Ennio Di Nolfo.
ANTONIO Donno, a cura di, America anarchica (1850-1930).
RICCARDO TACCH [NARDI
ARTURO PEREGALLI
L ’URSS
e i teorici del
capitalismo di stato
Questa ricerca è stata resa possibile anche da un finanziamento della l’.I.
(fondo 40%) diretta sul piano locale dal Prof. Sterfano Merli dell’Univer
sità di Milano e avente come coordinatore centrale il Prof. Salvatore Sechi
dell’Università di Ferrara.
Questo ebook è stato realizzato e condiviso per celebrare il
Centenario della Rivoluzione russa
1917-2017
© Piero Lacaita editore 1990
Mandurìa - Bari - Roma
INTRODUZIONE
Il nuovo corso impresso da Gorbaciov alla società russa,
paradossalmente, non ha riaperto la discussione sulla natura
sociale dell’URSS. Eppure non mancherebbero i fatti per
questo dibattito importante. Sembrano ormai lontani i tempi
iti cui Berlinguer annunciava che la spinta propulsiva della
Rivoluzione d’Ottobre era venuta meno rimettendo sul tappe
to il dibattito, anche se cautamente e con tutte le ambiguità
implicite in questa formula. Ora la nuova spinta gorbaciovia-
na, con tutte le sue «novità», potrebbe essere in grado di
rinverdire i dibattiti passati e che sembrano ormai caduti
nell’oblio.
Il nuovo leader del Cremlino parla infatti ormai aperta
mente di produttività, di profitto, di ristrutturazione e di
licenziamenti come un qualsiasi manager dell’Occidente, come
un qualunque capo di stato abituato ad avere di fronte non il
socialismo del presente e dell’avvenire ma il libro mastro di
una azienda che rivela sempre più i segni della stanchezza. La
nuova «spinta propulsiva» afferma chiaramente di temere i
problemi quotidiani della partita doppia, del deficit di bilan
cio, degli operai che sembrano non aver voglia di aumentare i
ritmi di lavoro.
Ma questo nuovo corso, che in effetti è più che altro la
rincorsa affannosa al profitto, è un fatto nuovo o è solo la
riproposizione in chiave moderna di un problema vecchio per
l’URSS?
Una risposta a tale domanda presuppone però un chiarimen
to preliminare di che cosa sia la sua economia e quali rapporti
sociali esistano alla sua base.
Si può senz’altro affermare che la natura sociale della Russia
è oggetto di indagine e di discussione sin da quando la
rivoluzione del 1917 ha eliminato lo zarismo e ha dato vita ad
uno Stato che non solo si richiama al marxismo ma afferma
anche di aver realizzato una società socialista.
5
Apologeti e detrattori del socialismo russo hanno discusso a
lungo sulla positività o meno di' questa società e sul grado
raggiunto dal suo sviluppo. Una domanda a cui gli apologeti
del socialismo russo però non hanno mai risposto è quale ruolo
giochi, o abbia giocato, la classe operaia all’interno di una
simile società. In fin dei conti: la classe operaia è classe soggetto
o oggetto di potere? Rispondere che essa è la classe che detiene il
potere significa affermare una falsità evidente. Gli operai russi
hanno lo stesso potere che possiedono gli operai occidentali e se
desiderano migliorare le proprie condizioni di vita non possono
farlo che nello stesso modo in cui avviene in Occidente, cioè
mediante la lotta e con degli scioperi, insomma con l’opposizio
ne, aperta o mascherata, nei confronti della controparte.
Sappiamo inoltre che fino a non molti anni fa anche la più
piccola opposizione comportava pericoli enormi, sino alla
deportazione e alla morte. Ma ad onta di ciò, lotte sociali vi
sono sempre state.
Molto spesso però nella pubblicistica corrènte la classificazio
ne della natura dell’URSS è generalmente sottaciuta e preval
gono le analisi empiriche dei fatti. / tentativi in questo senso
sono estremamente sfuggenti rispetto alla necessità di una
definizione scientifica.
Altri invece, non riconoscendo nell’URSS una società socia
lista, hanno sostenuto che si trattava di un fenomeno sociale
nuovo, che fuoriusciva dagli schemi marxisti, con sue leggi
particolari di funzionamento.
Una terza componente, infine, afferma che l’URSS è una
società riconducibile alle leggi di movimento del capitalismo.
Le interpretazioni in questo senso sono molte e si può dire che
abbiano visto la luce con la nascita della Russia post-rivoluzio
naria.
Noi pensiamo che sia fondamentale, per procedere ad un
approccio scientifico del «fenomeno» URSS, caratterizzare
primariamente la sua natura sociale. Pensiamo che le fonda-
menta di quest’opera siano già state gettate nel passato dai
teorici del capitalismo di Stato e che occorra ora riannodare i
fili, depurando le analisi dagli elementi secondari efuorvianti,
dovuti a situazioni particolari o momentanee che hanno a
volte falsato le prospettive di partenza. Crediamo, cioè, che sia
importante ripercorrere e ripresentare i momenti salienti di
interpretazione dèll’URSS in chiave capitalistica come base di
partenza per una analisi successiva ed esaustiva.
6
«Alcuni anni orsono finii di scrivere un
libro sui metodi sovietici di direzione
aziendale, l eggendo i quotidiani industria
li sovietici e le riviste commerciali russe
avevo scoperto un intero mondo eli vita
aziendale, che mi impressionò vivamente
perchè era del tutto diverso dalla struttura
Formale descritta nei manuali sovietici.
Ecco, mi dissi, in queste pubblicazioni
sta la vera storia di un sistema amministra
tivo completamente diverso dai metodi
americani. E in effetti l’immagine clic me
ne ero fatta aveva ben poco in comune con
le generalizzazioni sul mondo degli affari
americani clic avevo letto nei libri ili teoria
economica e sulle tecniche dell’organizza
zione aziendale.
In seguito cominciai a parlare con gente
assai più informata di me sui sistemi in uso
nel mondo degli affati americani. Anche i
miei interlocutori rimasero stupiti di fron
te al mio quadro della direzione aziendale
sovietica. Ma il motivo della loro sorpresa
era esattamente l’opposto del mio. «Ma
guarda, i dirigenti d’azienda russi usano gli
stessi trucchi che usiamo noi!», dicevano. I
russi hanno gli stessi problemi organizzati
vi ed i medesimi metodi per affrontarli. I
loro dirigenti cercano di sfuggire ai regola
menti formali delle loro aziende allo stesso
modo dei nostri. Insomma, a sentir loro
avevo riscoperto l’America».
Granick, Il dirigente sovietico, Comuni
tà, 1962, p. 15.
I. I COMUNISTI RUSSI
Lenin
La storiografia contemporanea ha sempre suddiviso il
processo rivoluzionario russo in due tappe fondamentali: la
rivoluzione di febbraio, intesa come rivoluzione democrati
co-borghese e quella di Ottobre, considerata socialista. A
questo schema si sono attenuti fondamentalmente sia gli
estimatori che i detrattori del grande evento «che sconvolse
il mondo».
L’interpretazione di Lenin dell’andamento e del succeder
si delle tappe della rivoluzione in Russia è un po’ meno
schematica e poggia su tre livelli di lettura che, sebbene siano
fusi in un tutt’uno, possono essere visti separatamente.
Per il rivoluzionario russo è necessario innanzitutto espri
mere un giudizio sulla natura poliica della rivoluzione,
secondariamente analizzare le forze sociali che agiscono nel
processo rivoluzionario e, infine, chiarire i compiti economici
che la rivoluzione è in grado di realizzare.
La lotta che matura con l’assalto al potere nell’Ottobre è
per Lenin un fatto decisamente ed inequivocabilmente socia
lista. A guidare la rivoluzione vi è un partito proletario, il cui
fine è l’unità della classe operaia internazionale e la realizza
zione del socialismo su scala mondiale. Da un punto di vista
delle forze sociali la cosa non è così semplice. Ritornato in
Russia dopo la caduta dello zarismo il dirigente russo scrisse
nelle sue, allora contrastate, Tesi di aprile che si trattava di
passare dalla «prima fase della rivoluzione (...) alla sua
seconda fase» che doveva dare il potere «al proletario e agli
strati pit'i poveri dei contadini» ‘. Si doveva passare cioè dalla 1
1 Lr.NIN, Sui compiti del proletariato nella rivoluzione attuale, in Opere
complete, Roma, Editori Riuniti, voi. 24, 1966, pp. 11-12.
9
prima alla seconda tappa della rivoluzione in atto, ed in
aprile la rivoluzione in atto era innegabilmente borghese.
Lenin lo ribadirà alla fine del 1918 al «rinnegato» Kautsky
affermando: «Sì, la nostra rivoluzione è borghese fino a che
marciamo con i contadini nel loro insieme» 2. Da principio vi
è stata la lotta contro il vecchio regime e le vecchie istituzio
ni economiche condotta assieme ai contadini nel loro com
plesso.
«Il proletariato in Russia, dopo aver portato a termine, insieme
con i contadini in generale, la rivoluziojie democratica borghese, è
passalo definitivamente alla rivoluzione socialista, non appena è
riuscito a scindere le campagne, a unire a se i proletari e 1
semiproletari, a raggrupparli contro i kulaki e la borghesia,
compresa la borghesia contadina» 3.
Quest’ultima fase, spiega Lenin, si è verificata «a un anno
dalla rivoluzione proletaria nelle capitali», e cioè «nell’estate
e nell’autunno del 1918» 4. Quindi da un punto di vista delle
forze sociali l’Ottobre, nel suo complesso, è democratico
borghese e la rivoluzione si trasforma in socialista solamente
l’anno seguente.
Quali sono i compiti economico-sociali che la rivoluzione
russa può invece realizzare? Non certo quelli socialisti,
risponde Lenin. La società socialista non può essere che il
risultato dell’azione del proletariato di molti paesi ed è
assolutamente impensabile in un solo paese, e per di più
arretrato come la Russia 5. L’economia che predomina nella
Russia post-rivoluzionària vede una serie di differenti modi
2 LENIN, La rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky. in Opere
complete, cit., voi. 28, p. 304.
3 Ibidem, p. 308.
4 Ìbidem, p. 306-307.
5 Lenin si riferiva esplicitamente agli scritti di Marx e di Engels nei quali essi
negavano recisamente qualsiasi possibilità di poter «costruire» una società
socialista in un singolo paese. Cfr. ENGELS, ilei in K
Principi comuniSmo,
MARX-F. ENGELS, Opere, voi. VI, Roma, Editori Riuniti, 1973, p. 372.
NeH’Wi'o/ogia tedesca, i due rivoluzionari tedeschi affermavano esplicitamente
che se una qualsiasi rivoluzione fosse rimasta isolata in un singolo paese, «ogni
allargamento delle relazioni» avrebbe soppresso «il comuniSmo locale» e
conseguentemente avrebbe riportato «per forza tutta la vecchia merda)). Cfr.
K. Marx-F. ENGELS, L'Ideologia tedesca, in Opere, ed. cit., voi. V, p. 34.
10