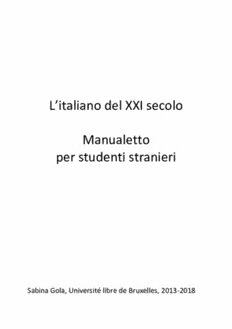Table Of ContentL’italiano del XXI secolo
Manualetto
per studenti stranieri
Sabina Gola, Université libre de Bruxelles, 2013-2018
Table des matières
I. LA LINGUA ITALIANA CONTEMPORANEA .................................................................................... 3
1. INTRODUZIONE ......................................................................................................................... 3
2. LINGUA E DIALETTI ................................................................................................................... 11
2.1. DIALETTISMI E REGIONALISMI ............................................................................................................ 14
2.2. GLOSSARIO .................................................................................................................................... 19
3. IL MODELLO DELLA VARIAZIONE E LA SITUAZIONE SOCIOLINGUISTICA CONTEMPORANEA ............................ 20
4. L’ITALIEN ET LE FRANÇAIS FACE A FACE .......................................................................................... 23
5. CARATTERISTICHE DEL TIPO LINGUISTICO ITALIANO .......................................................................... 26
6. L’ITALIANO OGGI ..................................................................................................................... 27
6.1. TRATTI DELL’ITALIANO IN MOVIMENTO ............................................................................................... 27
7. NOZIONI DI FONETICA .............................................................................................................. 29
7.1. LE VOCALI ...................................................................................................................................... 29
7.2. LE CONSONANTI .............................................................................................................................. 30
7.3. GLOSSARIO DI FONETICA E FONOLOGIA ............................................................................................... 33
8. LE LETTERE STRANIERE .............................................................................................................. 33
9. L’ACCENTO ............................................................................................................................ 35
9.1. GLOSSARIO .................................................................................................................................... 35
9.2. TENDENZA NELL’ITALIANO CONTEMPORANEO ...................................................................................... 35
10. LA STRUTTURA SILLABICA ........................................................................................................ 36
11. LA MORFOLOGIA................................................................................................................... 38
11.1. MORFOLOGIA FLESSIVA ................................................................................................................. 38
11.2. MORFOLOGIA LESSICALE ................................................................................................................ 44
11.3. SUGLI ANGLICISMI ........................................................................................................................ 60
11.4. LETTURE ..................................................................................................................................... 65
11.5. CURIOSITÀ................................................................................................................................... 71
11.6. LA PUNTEGGIATURA ...................................................................................................................... 79
11.7. IL RADDOPPIAMENTO FONOSINTATTICO (CARATTERISTICO DEI DIALETTI TOSCANI E CENTRO-MERIDIONALI) .. 83
11.8. QUESTIONARI .............................................................................................................................. 95
11.9. DOMANDE .................................................................................................................................. 96
12. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 101
II.. LLAA LLIINNGGUUAA IITTAALLIIAANNAA CCOONNTTEEMMPPOORRAANNEEAA
11.. IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE
Quando ci si riferisce a una lingua, si può intendere la lingua scritta o la lingua parlata. Ma che
cosa vuol dire « lingua scritta » ? La lingua di romanzi e poesie, dei regolamenti e
dell’amministrazione, di un manuale per l’uso di un computer o di un saggio scientifico, di
quotidiani o riviste, della pubblicità, della corrispondenza, della lista della spesa, degli SMS … ?
E « lingua parlata » ? Pensiamo, ad esempio, a una conversazione tra amici oppure a una
conversazione più formale con una persona che non conosciamo o a una conversazione
telefonica. In tutti questi casi non parliamo la stessa lingua. E gli italiani ? Quale lingua parlano
e scrivono gli italiani del XXI secolo? È corretto parlare al singolare o sarebbe più giusto
chiedersi quali lingue parlano e scrivono gli italiani?
Per capire meglio le peculiarità della lingua italiana contemporanea scritta e parlata occorre
ritornare indietro nei secoli e ripercorrere a grandi linee la storia della Penisola e dei suoi
occupanti1. Prima che i Romani conquistassero l’intero territorio, esso era occupato da vari
popoli (Carta I) - i Liguri, i Veneti, i Reti, gli Etruschi, gli Umbri, i Piceni, i Sanniti, i Latini, gli
Apuli, i Bruzi, i Greci, i Siculi, i Sardi, per citarne solo alcuni2, ognuno con le proprie usanze e
quindi anche la propria lingua più o meno simile al latino (Carta II).
3
1 Altre notizie si possono trovare a http://www.treccani.it/enciclopedia/popoli-e-culture-dell-italia-preromana-l-italia-e-i-popoli-
italici_%28Il-Mondo-dell%27Archeologia%29/
2 Le cartine si trovano rispettivamente a http://www.supersapiens.it/Archeostoria/italiapreromana.html e http://www.archart.it/italici-
litalia-preromana.html.
3 R. Goscinny – A. Uderzo, Astérix et la Transitalique. Vanves, Les éditions Albert René, 2017, p. 22
Carta I
Carta II
Quando i Romani cominciarono la conquista della Penisola, portarono con sé naturalmente la
loro lingua parlata, il latino parlato dai soldati e dai coloni (“il volgare”), e la loro lingua scritta,
il latino della scuola e della burocrazia. La lingua dei Romani, parlata o scritta, però, non veniva
imposta ai popoli conquistati, ma veniva assorbita attraverso le lingue di sostrato già presenti.
Le varie parlate native subiscono così un processo di “latinizzazione” con differenze anche di
accento4.
La situazione è differente per gli Etruschi che, avendo una lingua così diversa dal latino,
accettano la nuova tradizione senza apportare grandi novità al latino di Roma. Il fiorentino e
gli altri dialetti toscani sono quindi i più vicini al latino (dal punto di vista fonetico, morfologico
e sintattico).
In Italia, dalla sovrapposizione del latino - il latino volgare (cioè la lingua parlata) - e le lingue
dei popoli sottomessi a Roma, nascono i dialetti. Quindi, anche il fiorentino, che poi per ragioni
storiche, letterarie, sociali ed economiche, diventerà la lingua italiana, è inizialmente uno dei
tanti dialetti parlati in Italia. Non tutti i dialetti però sono di origine romanza ; ci sono anche
dialetti tedeschi, sloveni, croati e grichi (derivati dal greco). Infatti, in Italia sono presenti anche
8 comunità allofone: provenzale; franco-provenzale, tedesco, sloveno, serbo-croato,
albanese, greco e catalano.
L’assetto geografico e politico della penisola ha influito sulla diffusione dei dialetti: i dialetti
parlati in zone isolate hanno subito una diversa evoluzione, differenziandosi sempre più
attraverso i secoli. Nell’Italia settentrionale, da ovest verso est, si hanno i dialetti gallo-romanzi
(occitani e francoprovenzali), i dialetti gallo-italici (piemontese, lombardo, ligure, emiliano,
romagnolo), veneti, ladini, friulani, toscani, centro-meridionali (umbro, marchigiano,
abruzzese, molisano, pugliese, campano, lucano, salentino, calabrese, siciliano) e il sardo.
Carta dialetti italiani di Giovan Battista Pellegrini (1921-2007), Carta dei dialetti d’Italia
(1977)5
4 Secondo recenti teorie sembra che alla base di questo processo di latinizzazione non ci sia il latino della romanizzazione, ma il latino parlato
prima di Roma.
5 Maurizio Dardano – Pietro Trifone, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna, Zanichelli, 1995, p. 48.
a) Un esempio : come si chiama questo oggetto?6
Friuli-Venezia Giulia
Alto Friuli (Carnia) : grimal o traviersa
Trieste: traversa o traversetta (dipende dalla dimensione), bavariol
Friuli della Bassa : gurmâl
Friuli: grembiuler
Trentino Alto Adige
Trentino-Vallagarina : grombiàl
Veneto
Belluno : travessa
Bassano : traversa
Castelfranco Veneto asolano : grembial
Treviso : traversa o traveson
Treviso (Vittorio Veneto) : traversa
Venezia: traversa , traverson (se è grande)
Verona : grembial
Rovigo : traverson, o traversa
Lombardia
Varese : scusaa o scusalin, scusàa (la seconda s è sonora, non aspra)
Bergamo : scosal, bigaröla
Brescia : bigaröl
Milano : scossá, scusarin, scussá, scussarin, scusà o scusal
Lodi : maleo
Pavia : scusà
Vigevano (Pavia) : scosalina
Voghera (Pavia) : scosalin
6 Questa lista è il frutto di un’inchiesta proposta al gruppo Facebook La Lingua batte e serve unicamente a titolo di esempio. Non è
sicuramente esaustiva, ma dà un’idea delle differenze dialettali tra le varie zone d’Italia, dovute alle diverse lingue di sostrato.
Cremona: scosàal
Cremona (Pandino) scusàl o scursàl
Cremona (Castelleone) : scussal
Alto Mantovano : bigaröl
Basso Mantovano : gumbiàl
Felonica (Basso Mantovano): grumbial
Piemonte
Piemonte (alto) : scusàl
Novara : scusàl
Monferrino : scusà
Torino : faudal, da fauda ( grembo)
Caluso (comune intorno a Torino) : faudal
Banchette di Ivrea (To) : faudal
Alessandrino : scusa'
Piemonte (nel basso) : faudà (a volte con la l finale) da fauda=grembo
Liguria
Genova : scösâ, da scöso 'grembo' che è d'origine germanica (longobardo skauz)
Genova : scoussà
Emilia-Romagna
Piacenza : scussalein
Castell'Arquato (nel piacentino) scussal
Reggio Emilia
: grembiule (con pettorina)
Modena : grimbiel
Bologna : grembiale, grimbel
Bologna città : gumbrialen
Imola, Bologna : grembiale
Forlì : parananza o grembiale
Rimini : parananza ; zinalòun, ma è più indicato per l'abito 'da casa', il grembiule
abbottonato sul davanti.
Romagna : zinale
Toscana
Massa : grembiulo
Carrara : grimbiale
Versilia : sinale
Prato : grembiule
Mugello : grembiale
Firenze : grembiule
Arezzo: pannuccia
Siena : zinale
Provincia di Siena : grembiule
Follonica (Gr) : grembiule
Massa Marittima : grembio
Maremma : grembio, grembiule, grembiale
Toscana (bassa) : senale, sinale, grembiale
Umbria
Città di Castello (PG) : panuccia
Terni : zinale
Orvieto (Terni) : sinale
Marche
Senigallia : parnanza o zinnal,sinale
Alte marche : sinal o paranansa/parananza,
Ancona : sinale o parnanza
Ancona (provincia) : parnanza o sinale
Jesi (provincia di Ancona) : sinale
Arcevia (Ancona) : parnanza
Civitanova Marche (Macerata) : zinale
Macerata : parannanza
Macerata (nei pressi di): tsinale
Camerino Macerata) : parannanza
Marche (Centro) : parnanza
Tolentino (Macerata) : pannella, parannanza
Montalto delle Marche : parnanza (para +innanzi)
Marche del sud : zinale o parnanza
Abruzzo
Abruzzo meridionale : mantusina
Trasacco: zinal
Capistrello (AQ): zinalo
Abruzzo : znal, mantera
Pesaro : parananza (nel pesarese) o zinale
Aquila : parannanza
Chieti : mantesina, la mandusin'
Teramo : sparone
Lazio
Lazio (Alto) : zinale o parannanzi
Ciociaria : zinale
Ciociaria (bassa) : mantsin
Ciociaria: parannanza
Roma : grembiule, parannanza, sinale
Terracina : parannanza
Anzio (Roma) : parananza
Sora (Frosinone)
: senále, la e è muta.
Ceccano (FR) :
zinnale
Viterbo : sinale
Minturno (LT): zinale, o mantesino
Priverno (LT): zinale
A Vetralla (VT) : sinale
Campania
Alto Casertano : mantesinu [dal tardo latino: mantu(m)+ ante+ sinu(m)→mantesinu(m)].
Napoli : mantsin, mantesino, mantesine (e semimuta), anche con la D :
mandsin..."La derivazione è dal latino “ante sinum” (davanti al seno)
Campania (basso Cilento) : vantisinu
Buccino (SA): sin
Agro nocerino sarnese (Campania) : mantesino
Salerno : vantesino
Molise
Mantazin
Ripalimosani (Campobasso): mendesínə
Calabria
Cosenza : sinalu
Cosentino : sinale (dal latino sinalis, "appartenente al seno")
Calabria : faddali o 'oddali (con la f aspirata a seconda delle zone)
Bagnara Cal : faddali
Marchesato crotonese
(alto) : fadàle
Calabria centrale : mantissinu
Vibo Valentia : faddali
Lamezia Terme (Cosenza) : mantisinu
Puglia
Gargano : znal
Foggia (prov.) : sinal
Bari e provincia : snal ( il sinale), verosimilmente da sinum, cioè seno
Bari : s'nál
Lecce : antile, mantile
Nardò (Lecce) : antile
Salento (centro) : mantile
Salento: mantile, tamantile
Alto Salento: grembiale
Taranto : sunal, parannanza
Manduria (Taranto): mantìli
Galatone (Le) : mantile
Sardegna
Sardegna (Nuoro) : grembiale o franda, siniscola antela
Centro: grembiale (se grande) grembialeddu (se piccolo)
Sardegna (centro) : vranda
Sardegna (centro, Oristano, alto Campidano): grembialli.
In altre zone della Sardegna: pannu de aranti, pann'e'ananti (letteralmente: panno davanti).
Sardegna (sud) : f(v)anteliku
Sardegna (cagliaritano) : pannianànti (pannu de ananti = lett. panno di davanti)
Sardegna : deventagliu (campidano -)
Sicilia
Sicilia: mantali
Sicilia (centro ): fadali
Palermo (provincia) : falari
Modica (Rg, Sicilia sud orientale) : favalari
Catania : mandali, mentali, mantali
Gioia Tauro (RC): faddali
Ragusa : falari, faulare
Agrigento : fallaru, fadali, falletta
Sicilia orientale: fantali
Messina (prov.) : fantali, fadali
Nicosia (Enna) : fadali
Trapani (prov.) : falàri
Palermo : falaru
Sicilia Orientale : vantàli
b) L’Italia è anche questo...
Dalla pagina Facebook “Italiani a Bruxelles”
Dialetti regionali (es.veneto, romanesco)
Ciao a tutti, sto cercando dei prodotti tipici veneti per una cena tradizionale. Posso sempre
puntare sui grandi classici -sarde in saòr (sarde con cipolle agrodolci) e risi e bisi (riso e
piselli)- ma sono alla ricerca di:
- Bastardo del Grappa (formaggio)
- Bussolai (biscotti)
- Pan biscotto
- Carciofo violetto di Sant'Erasmo (isola della laguna veneta)
Ostrega, le sarde in saor! Ghe zè anca i sparzi (Urca le sardine insaporite! Ci sono pure gli
asparagi! *ndt)
Allora se passi per Roma o meglio ancora per i Castelli Romani devi assolutamente fare una
capatina in una " fraschetta " per farti "na fojetta "
Tracce della presenza di minoranze linguistiche
Io sono del Friuli Venezia Giulia e mi manca un po' la cucina della mia terra.
Mi sapreste consigliare posti dove posso trovare: Burek (dolce salato), civapcici (carne tritata
speziata), ajvar (salsa), pleskavice (carne grigliata con cipolle), frico (formaggio, patate, burro),
musetto (insaccato simile al cotechino) o ljubljanske (carne impanata fritta ripiena di
formaggio e prosciutto)?
Prodotti gastronomici tipici di alcune regioni italiane
Ciao a tutti! Il mio fidanzato vive a Bruxelles da qualche mese. Per il suo compleanno voglio
sorprenderlo con cibi tipici della nostra amata Toscana. Dove posso trovare: 1) Cecina 2)
cacciucco 3) trippa 4) fegatini 5) torta con i bischeri. Mi rendo conto delle richieste un po'
assurde ma voi sapete fare miracoli! Grazie
Ciao a tutti!!! La mia amica ed io abbiamo la piadina romagnola e ci servirebbe lo stracchino
(preferibilmente Nonno Nanni). Sapete dove posso trovarlo?
Al Caffelatte Espressobar siamo tutti romagnoli (Riccione, Rimini e Alfonsine) e la piadina,
rigorosamente riminese, ormai la facciamo anche alle 8:30 del mattino! La nostra "classica"
con stracchino rucola e crudo è un best seller...anche se quando la accompagnano con un
cappuccino o con una cioccolata calda muoriamo dentro...
Non è il Natale, caro Grillo, è la romanella che abbiamo bevuto domenica che ancora fa
effetto.
Lingua parlata scritta
Ciao a tutti!
Qualcuno sa mica dove posso portare dei pantaloni a fare l'orlo nel quartiere d'Ixelles?/zona
cimitero? Grazie mille
Se volete un taglio innovativo od un colore da paura ...