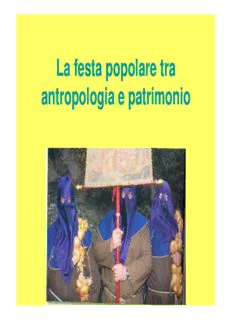Table Of ContentLLaa ffeessttaa ppooppoollaarree ttrraa
aannttrrooppoollooggiiaa ee ppaattrriimmoonniioo
Festa, rito, ciclo festivo
La festa tradizionale è un evento collettivo
complesso che spesso contiene al suo
iinntteerrnnoo ppiiùù mmoommeennttii rriittuuaallii ddiissttiinnttii..
Ecco perché parliamo di “ciclo festivo”.
• La festa popolare/tradizionale: un oggetto
“classico” degli studi demologici.
•• OOggggii èè uunn aammbbiittoo cchhee aappppaarrttiieennee aallllaa ssffeerraa
del “patrimonio culturale immateriale”
(ICH).
DDIIVVEERRSSII AAMMBBIITTII DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII CCHHEE HHAANNNNOO SSTTUUDDIIAATTOO
LLAA FFEESSTTAA EE IILL RRIITTOO
• 1)Studi demologici. La festa popolare (religiosa e non) come
espressione di cultura dei ceti subalterni. ApproccIo
gramsciano o marxista. Influenza di Gramsci e De Martino.
• 2)Studi storico-religiosi. La festa popolare studiata in ottica
ccoommppaarraattiivvaa ccoonn iill mmoonnddoo ccllaassssiiccoo ((PPeettttaazzzzoonnii ee BBrreelliicchh)) oo
attenzione per gli aspetti fenomenologici (Mircea Eliade – studi
sul sacro)
• 3)Approcci recenti; influenza dell’antropologia angloamericana
ed Etnologia dell’Europa.
La festa tradizionale (Europa meridionale) è studiata nei suoi
mutamenti nella modernità in relazione alla revitalizzazione,
all’invenzione delle tradizioni, all’identità locale, alla
patrimonializzazione e al turismo.
Teorie della festa popolare
• Sigmund Freud = La festa come momento di
trasgressione legittima dalle regole
• Scuola Sociologica Francese (Durkheim e Mauss) =
LLaa ffeessttaa ccoommee mmoommeennttoo rriittuuaallee ppeerr rriinnssaallddaarree
periodicamente l’unità sociale all’interno della
società stessa. Festa come momento di
effervescenza collettivo, come momento di
integrazione sociale.
• George Bataille = Festa come momento popolare di
sperpero e di spreco per riconfermare il rango e
l’onore. Lo spreco represso nella società borghese.
Nessuna di queste teorie riassume però tutti i caratteri di
una festa, ma riflettono solo tipologie particolari di feste.
• Le feste possono non contenere una tendenza allo spreco.
• Possono non essere necessariamente trasgressive.
• Non sempre manifestano caos trasgressivo perché manifestano una
organizzazione molto complessa che vede all’opera associazioni,
rreelliiggiioossee ee nnoo,, ccoommee ccoonnffrraatteerrnniittee,, aassssoocciiaazziioonnii llooccaallii ddii qquuaarrttiieerree,,
comitati familiari, manifestando anzi stretti rapporti e articolazioni
organizzative a livello politico, economico, sociale.
• Ma soprattutto negli anni è entrata in crisi l’idea durkheimiana che la
festa ricreasse un senso di solidarietà sociale e di unità di gruppo,
perché molto spesso le feste rimarcano invece differenze sociali o
evidenziano conflitti interni al gruppo.
UUnnaa vviissiioonnee nnoossttaallggiiccaa ddeellllaa ccoommuunniittàà……
Gli antropologi troppo a lungo si sono fatti
sedurre dall’idea un po’ nostalgica che la
ffeessttaa rriiccrreeaassssee llaa ccoommuunniittàà,, ee ppeerr qquueessttoo
per molto tempo non ne hanno visto le
trasformazioni e non sono stati capaci di
comprendere le feste più recenti.
LLAA FFEESSTTAA NNEEGGLLII SSTTUUDDII
FFOOLLKKLLOORRIICCII
• XVIII/XIX secolo. La Chiesa condanna molti comportamenti festivi
popolari come momenti di fanatismo religioso lontani dall’ortodossia
(moralismo cattolico)
• XVIII/XIX secolo = La cultura illuminista condanna la festa come
lluuooggoo ddeellll’’iiggnnoorraannzzaa,, ddeellllaa ppiiggrriizziiaa ee ddeelllloo sspprreeccoo ((vviissiioonnee
intellettualistica e razionalistica).
• XIX secolo = La cultura romantica esalta la festa popolare come
momento di autenticità popolare (visione pittoresca)
• Inizio XX secolo = Giuseppe Pitré. Dedica tre volumi dei suoi studi
sulla Sicilia alle feste siciliane (Feste patronali in Sicilia, Spettacoli e
feste, 1900). Pitré non occulta i comportamenti penitenziali più
violenti dei devoti che comunemente erano taciuti dalla chiesa.
Folklore rituale.
Dopo la guerra l’interesse degli studi demologici
per gli eventi rituali cresce.
Influenza di Ernesto De Martino:
llee ffeessttee iinniizziiaannoo aadd eesssseerree lleettttee eennttrroo uunnaa ccoorrnniiccee
interpretativa che vedeva queste come
espressione dolorosa delle classi subalterne
all’interno di un filone di antropologia
gramsciana che si è sviluppata in Italia a partire
dagli anni Sessanta.
AAnnnnaabbeellllaa RRoossssii ee ““LLee ffeessttee ddeeii
ppoovveerrii”” ((11996699))
Anni Cinquanta (1959) = un’allieva di De
Martino, Annabella Rossi, intraprende per conto
del MNATP; una ricerca e la documentazione di
numerosi pellegrinaggi dell’Italia centro-
mmeerriiddiioonnaallee;;
969: “Le feste dei poveri”.
I comportamenti rituali dei pellegrini sono messi
in relazione alle condizioni di sfruttamento
economico e spirituale, da parte del clero, dei
ceti subalterni.
Description:Festa, rito, ciclo festivo. La festa tradizionale è un evento collettivo complesso che spesso contiene al suo interno più momenti rituali distinti.