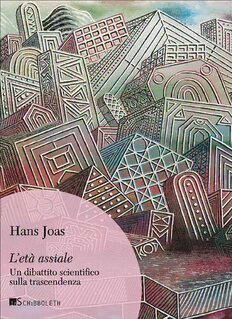Table Of ContentHans Joas
L'età assiale
Un dib atti.t o scientifi
11
su a trascende nza co
115
CHrBBOL ETH
A Robert N. Bellah
(1927-2013)
9
L'età assiale
Un dibattito scienti.fico sulla trascendenza
Uno dei più importanti campi di ricerca attuali
nel terreno delle scienze storico-sociali ruota
attorno alla cosiddetta età assiale1 Con questo
.
concetto si intende, a partire da un'opera di Karl
Jaspers del 1949 che reca il titolo di Origine e
senso della storia, quel periodo temporale attor
no alla 1netà del prin10 1nillennio avanti Cristo
1. Questo contributo costituisce una versione notevolmente
estesa di un testo originariamente apparso in lingua inglese:
H. Joas, The Axial Age Debate as Religious Discourse, in
R.N. Bellah - H. Joas (a cura di), The Axial Age and lts
Consequences, The Belknap Press of Harvard Universiry
Press, Cambridge (MA)-London 2012, pp. 9-29. Alcune
singole formule iniziali nelle quali viene caratte1izzata l'idea
dell'età assiale sono state da me utilizzate anche in altra
sede. Il grande numero di note presenti in questo scritto
si deve al fatto che esso è stato pensato anche come una
piccola guida nella sconfinata letteratura sull'argomento.
10
J
nel quale - così aspers - hanno avuto origine
tutte le grandi religioni del mondo e, oltre a ciò,
anche la filosofia nell'antica Grecia. I rispettivi
processi spirituali, secondo questa idea, avreb
bero avuto luogo conten1poraneamente nelle
diverse grandi culture dell'umanità in maniera
del tutto indipendente; non sono dunque ricon
ducibili all'influenza di una cultura sull'altra.
In tutte loro, inoltre, l'epoca del 1nito sarebbe
giunta al termine e al suo posto sarebbe sorta
un'epoca di riflessione siste1natica sui presup
posti essenziali dell'esistenza un1ana.
Mentre nei tre decenni successivi alla pubbli
J
cazione del libro di aspers questa idea, appena
caratterizzata in modo estreman1ente sintetico
nelle precedenti righe, è stata poco discussa e
ripresa solo sporadicamente, a partire dagli an
ni '70 si è sviluppata una fiorente ricerca rivolta
J
alla valutazione della tesi di aspers. Sullo sfon
do di questa ricerca si trova, in linea con la sua
appartenenza al campo delle scienze sociali, la
domanda sulle ripercussioni che questa nuova
forma di religione (e di filosofia) ha avuto sulla
società. Se in precedenza, nell'epoca n1itica, il
divino era ancora nel mondo e parte di esso, e
dunque non vi era una reale scissione tra reale
e divino e gli spiriti degli avi e delle divinità po-
11
tevano essere influenzati e manipolati proprio
perché parti di questo mondo, oppure perché
il regno delle divinità rappresentava se1nplice
mente un mondo parallelo che non funzionava
molto diversamente dal inondo terreno, con le
nascenti filosofie e religioni della redenzione
dell'età assiale si veniva a creare una notevole
spaccatura tra i due mondi. Il pensiero centrale
è che il divino sarebbe diventato, in quel perio
do, il vero, l'autentico, il c01npletamente altro
di fronte al quale ciò che è terreno non può che
risultare deficitario.
Con questo pensiero non si pone tuttavia una
mera differenza metafisica. Si genera piuttosto
una tensione tra il «mondano» [das Mundane]
(ciò che fa parte del inondo [das Weltliche]) e
il trascendente, una tensione che ha notevo
li ripercussioni sociopolitiche, poiché questo
pensiero non è più con1patibile, per ese1npio,
con alcuna forma di reggenza divina. Se gli dèi
risiedono in un altro luogo, il sovrano non può
più essere simile a un dio. Anzi, a pa1tire da
quel mon1ento, egli potrebbe tendenzialmente
anche essere forzato a giustificarsi di fronte a
certi postulati divini. Il sovrano è di questo mon
do e si deve giustificare di fronte al vero mondo
ultraterreno: si può dunque parlare di una de-
12
sacralizzazione del potere politico. Diviene co
sì possibile una nuova clitica (del potere), che
genera una dinamica con1pletamente nuova nel
processo storico, poiché si ha ora la possibilità
di accusare il sovrano di non rispettare i coman
damenti divini. Allo stesso tempo diviene anche
possibile, in forma più radicale e accanita, di
scutere sulla vera divinità o sulla corretta inter
pretazione dei comandamenti divini, cosa che,
nel breve o nel lungo termine, può condurre a
conflitti o a una differenziazione tra comunità
etniche e religiose. Gli intellettuali ante litte
ram,, i preti, i profeti, ecc. hanno essenzialmente
un ruolo di maggior importanza rispetto apri-
111a dell'età assiale, poiché ora hanno il difficile
compito di inte1pretare l'impenetrabile volontà
di Dio e degli dèi, una volontà che non è più
facilmente afferrabile con le categorie terrene.
Col pensiero della trascendenza si apre, per così
dire, la storia, vale a dire che si aprono terreni
di conflitto completamente nuovi. Formulato in
termini leggermente più astratti: col pensiero
della trascendenza emerge anche il pensiero
della fondan1entale necessità di ricostruzione
dell'ordine mondano. Da lì in poi l'ordine socia
le verrà concepito con1e qualcosa di n1utevole
a seconda delle direttive divine. In questo mo-
13
do vengono desacralizzate anche le strutturali
diseguaglianze sociali. Divengono innanzitutto
pensabili mirati sowertimenti! Attraverso l' ef
fetto diron1pente delle idee che hanno origine
nell'età assiale si manifesta, dunque, una nuova
dinamica sociale.
In questa sede non cercherò di offlire uno sguar
do d'insieme empiricamente orientato sulle ri
cerche riguardanti l'età assiale. Piuttosto voglio
cercare di interpretare il confronto sull'età as
siale che ha luogo tra gli intellettuali, come un
tentativo degli intellettuali stessi di posizionarsi
rispetto al problema della "trascendenza", al suo
ruolo nella storia e alle possibilità conten1pora
nee di articolarla. Preliminannente dedicherò
qualche riflessione all'origine del concetto di
età assiale, all'idea che esso denota e al suo au
tentico significato.
1. L'età assiale: tennine, idea, significato
J
Perché aspers chiama età assiale quella deter
n1inata fase della storia da lui intesa con questo
nome? A tutti i conoscitori dell'opera di Georg
Simmel se1nbrerà ovvio trovare in essa la fonte
14
d'ispirazione per questa denominazione, giac
ché Silnn1el nella sua opera tarda Intuizione
della vita - un'opera che ha influenzato profon
damente il giovane Heidegger - parla di rota
zione assiale [Achsenclrehung] con1e passaggio
decisivo per il sorgere dei valori ideali. L'amo
re, ad esen1pio, per Simn1el può essere scate
nato da un'attrazione corporea, 1na una volta
che il desiderio originario porta alla costruzio
ne di un'intensa relazione interpersonale, que
sta stessa relazione acquisisce una sua propria
qualifica che è scaturigine di nonne e di valori.
Con «rotazione assiale» si intende dunque qui il
sorgere di obiettivazioni culturali che sgorgano
dal flusso della vita e che poi, tuttavia, su di essa
retroagiscono2• Per Simn1el «la rotazione delle
2. G. Simmel, Intuizione della vita. Quattro capitoli meta-
.fisici, tr. it. a cura di G. Antinolfi, Mimesis, Milano-Udine
2021. Per il concetto di Achsendrehung (rotazione as
siale) in Simmel si veda H. Joas, Come nascono i valori,
tr. it. a cura di M. Santarelli, Quodlibet, Macerata 2021,
pp. 147-1.51. Sull'influsso del libro di Simmel sul primo
Heidegger e la sua visione della morte si rimanda invece
a M. GroBheim, Van Georg Simmel zu Martin Heidegger.
Philosophie zwischen Leben und Existenz, Bouvier, Bonn
1991; J.E. Jalbert, Time, Death, and HistonJ in Simmel and
Heidegger, in «Human Studies», n. 26, 2003, pp. 259-283,
15
fonne»3 si realizza massimamente nella religio
ne. Contro questa interpretazione dell'origine
J
della scelta concettuale di asper, per come vie
ne sostenuta dall' e1ninente studioso a1nericano
di Sim1nel Donald Levine4 mi sen1bra parlare
,
e l'introduzione molto istruttiva di D.N. Levine e D. Silver
all'edizione in lingua inglese dell'opera di Simmel Le
bensanschammg: G. Simmel, The View of Life, tr. ingl. a
cura di J.A.Y. Andrews e D.N. Levine, Chicago University
Press, Chicago (IL) 2010, pp. IX-XXXII.
3. G. Simmel, Intuizione della vita, cit., p. 110.
4. D.N. Levine, Note the Concept of an At:ial Turning
011
in Human HistortJ, in S.A. Aijomand - E.A. Tiryakian (a
cura di), Rethinking Civilizational Analysis, SAGE Pub
lications, London 2004, pp. 67-70. Si potrebbe tuttavia
argomentare che Simmel nel suo saggio su Michelange
lo di fatto interpreta il ritorno alla dimensione terrena
nell'arte rinascimentale come "rotazione assiale" di fron
te all'orientamento per la trascendenza del Gotico e in
questa direzione usa concetti quali ascesa e declino della
trascendenza. Egli non parla h1ttavia di questo mutamento
come punto di svolta nella storia del mondo. Vedi G. Sim
mel, Philosophische Kultur, Kiepenheuer, Potsdam 1923,
p. 168. Un precedente tentativo di indagare, piuttosto che
l'influenza di Simmel su J aspers, la possibilità di applica
re il concetto simmeliano di Achsendrelmng al concetto
jaspersiano di Achsenzeit, ossia di vedere neil'Achsenzeit
l'inizio dell'Achsendrehung è presente in: L. Franke, Die
16
il fatto che Jasper con il suo concetto di "asse"
non voleva intendere la relativa auton01nia del
le obiettivazioni culturali, 1na piuttosto un asse
attorno a cui ruota l'intera storia del mondo, il
punto nella storia, dunque, in cui viene vissuta
una dicotomica differenza tra tutto ciò che era
stato e tutto ciò che sarà.
J
Nel passaggio decisivo, oltretutto, aspers non
fa riferimento a Simmel, n1a a Hegel. Egli ve
deva in Hegel l'ulthno grande esponente della
storia del pensiero occidentale, per il quale, a
partire da Sant' Agostino, era divenuto indubbio
che gli atti di rivelazione divina rappresentino
cesure decisive nella storia del inondo. Hegel si
era così espresso: «Tutta la storia tende a Cristo
e da lui viene; l'apparizione del figlio di Dio è
l'asse della sto1ia mondiale»5 Per lo J aspers che
•
scrive dopo la Seconda guerra 1nondiale una
sitnile concezione cristo-centrica o cristiano
centrica non è tuttavia più accettabile. La sua
Achsenzeit als Wendung zur Idee: K. Jaspe1-s wul G. Sim
mel, in «Zeitschrift fiir philosophische Forschung», n. 26,
1972, pp. 83-102.
5. K. Jaspers, Origine e senso della storia, tr. it. a cura di
R. Regni, Mimesis, Milano-Udine 2014, p. 51.