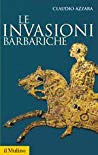Table Of Content«ritengo prezioso il piccolo ma denso libro di Claudio
Azzara. .. un preciso e affidabile vademecum dei fatti
relativi alle migrazioni tra antichità e Alto Medioevo e
dei problemi storici che esse hanno posto e pongono»
FRANCOC ARDINI
A partire dai secoli quarto e qUÙlto si verificò, negli immensi spazi
compresi fra l'Asia e l'Europa, un vasto processo di spostamenti a catena
di popolazioni le quali finirono, dopo un vario e lungo peregrinare, per
stabilirsi in sedi diverse da quelle d'origine, trasformando in profondità
gli assetti del mondo allora noto. Il libro ripercorre le complesse yicende
che portarono alla sostituzione dell'impero romano d'occidente con una
pluralità di regni barbarici assai eterogenei e di disuguale durata, fino
agli estremi fenomeni migratori che investirono lo spazio europeo nei
secoli decimo e undicesimo. Una chiara esposizione che si inserisce in
un filone di indagine storica assai vivace e innovativo.
Claudio Azzara insegna Storia medievale nell'Università di Salerno.
Per il Mulino ha pubblicato anche «L'Italia dei barbari» (2002), «Le civiltà
del Medioevo» (2004), «Il papato nel Medioevo» (2007), «La Chiesa nel
Medioevo» (con A.M. Rapetti, 2009).
€ 12,00
■Cov deers i�glni:gS ua&e!C l ISB9N7 8-88-15-2387(
I1 I1
Società editrice il Mulino
9 78881253 870:
I lettori che desiderano informarsi
sui libri e sull'insieme delle attività della
Società editrice il Mulino
possono consultare il sito Internet:
www.mulino.it
ClauAdzizoa ra
Lei nvasbiaornbia riche
Socieedtiàti rMliu clei no
ISBN9 78-88-15-23870-2
Copy©r i1g9h9bt9yS ocieedtiàti Mrlui lcieBn ool,o Ngunoaev.da i z2i0o0n3e.
Tutidt iir siotnrtoii s eNrveastsipu.an rdati qe u epsutbab lipcuaeòzs isoenree
fotocorpiipartoaad,ro cthtimave,im aotraio,zt zraatsami enqs usaalf soiramsai
om ez-zeol ettmreocnciacrnoei,pc roo,g driagfii-ctsoaen,l o enn e tie rmini
prevdiaslltleiag c ghete u tieDlli ar idt'tAou tPoerarel .ti rnef ormsaiz ioni
vedisali wwwt.om ulino.it/edizioni/fotocopie
INDICE
Introduzione
p. 7
I. Roma e i barbari alla vigilia delle grandi mi-
grazioni 13
Il. Le grandi migrazioni e la nascita dei regni
nell'Occidente 51
Ili. La migrazione dei longobardi in Italia e l'e -
vangelizzazione delle stirpi barbariche 87
IV. Le migrazioni dei popoli slavi e le ultime in-
vasioni contro la cristianità 119
Conclusioni 145
Appendice. Le invasioni barbariche e la fine di
Roma: miti per il mondo contemporaneo 151
Letture consigliate 167
Indice dei nomi e dei luoghi 181
5
INTRODUZIONE
Pochi temi della storia occidentale hanno avuto la ca
pacità di colpire non solo l'interesse degli studiosi ma an
che l'immaginazione popolare con la stessa fortissima ca
rica di suggestione delle migrazioni ( o, dal punto di vista
dei romani, delle invasioni) barbariche, cioè di quel vasto
fenomeno di spostamenti a catena, tra l'Asia e l'Europa,
di popolazioni eterogenee che, a partire dal IV-V secolo
d.C., finirono per stabilirsi in sedi diverse da quelle origi
narie, spesso sul suolo che era già appartenuto all'impero
romano. Basti pensare, per esempio, a come nel lessico i
taliano moderno siano rimasti il nome di un'antica stirpe,
i vandali, e quello di un re unno, Attila, entrambi legati a
vicende risalenti al V secolo, per significare comporta
menti di cieca violenza devastatrice, o anche come gli
stessi termini barbaro, barbarico, barbarie vengano larga
mente applicati a individui o ad atti contraddistinti da
una primitiva e selvaggia rozzezza.
Allo stesso tempo, è altrettanto vero che pochi argo
menti come questo si sono prestati con tanta frequenza a
letture impropriamente attualizzanti, condizionate da ciò
che accadeva nel presente, e a pesanti deformazioni ideo
logiche: rischi non sempre agevoli da evitare, ove si tenga
conto del nesso che tiene legata in modo indissolubile la
vicenda delle invasioni barbariche a un evento epocale
quale fu il crollo dell'impero romano d'Occidente, perce
pito dalla nostra cultura come l'epilogo stesso del mondo
antico. Si è potuta così costituire, tra la fine del secolo
scorso e i primi decenni del nostro, l'interpretazione del
tramonto della civiltà greco-romana, e dei suoi alti e pecu
liari valori, in quanto «uccisa» da un nemico esterno (se
condo la nota formula di André Piganiol) - i barbari, per
l'appunto -, quale sorta di modello, di prefigurazione,
7
delmloard teelm load ecrinvaoi clctiàd eanstsaalses,i nata
da« nuobvair bdairv io»li,tnv a o litdae ntciofiinbc oalti
scevpiicuhtict hoceso tlnoe« masesmee»r goepnptois,t e
aléllesi otceii nia rlrie vedrescilTbiainpllooie.s izeivoini,
dentepmreindvticee o rrestttoerhziazcnapan u,or a ev uto
larfograt usnpiae :na ssliu ccdeius nsl oi bdratoli, t aoslo
saiin diccaotmiievTl or ,a modnetllo' Occ(iDdeUernn te
tergdaeAnsbg e ndldaiOn sdweasSl)pd e ngdleegarln,in i
1918-E1d 9ia2 m2p.si poa hzainogn ood uatnocl heae l
tretitnacnotnos liesttitencun hrtieira avzez eir aalzez,i sta,
chhea npnroe tdeics oon traapu pnto arrridemo p erroo
mancoo rreod tetcoa dleafn rteees ncear dgeillnaeu ove
gengteir maneitcihceai,mn etneetpg eor ret adtisr pieccii
ficvia lgoureir rAi qeurepisr.to op ovsailltpaeoe ,np ar e
cissaurbeci ht-eoc omvee dr-eumnopa r etuensigate àr
maniucnaGa,e rmandeanltcluoemn notpaezciuolèni ia ri,
soltuannmata ol decsotsrtar aut zaivoonelesi engoau tita
travlefoarr szoa ot,nu erlaml iag ldieolirlpeeo tifrelas iin,
tendidmeelntlteaos timdoenlifolanente zic a,hi enr ealtà
les tibraprib afurriocnuhonec rogdiico ullotd uirvee rse
es foir giairnuo nnc ol idmifoa r tiscsoinmtaa minazione
(cnuoifun r onsop eessstor aanncephire e icniflsuirs osi
manèio )l;t reitmuptotsiosm ipbiielcgeoa msreie n oin imi
termgienrim eab naor bdaarmloo ,m encthqoeu eglelra
manifuc sao ulnota r laem olctoem pondeenllt'ie teroge
negaa labsasribaai rnli acrmagi,as ucroam podsagt ean ti
nomapdrio vendiaelsnltteei pd peel l'Eourrioepena t ale
delll'qeAu saielasi,e rciutnpaaer soaninont fleu seunlzlae
stetsrsigebe ùr maniche.
Seim isttio riorgircaoqfirucdsiiao tpsiro ans otp artoi
priinp, a rtidceoplle anrseai,ue troor eia tnatriidoe mocra
tidceol l'edsetsprtoerlmaia at niccihanae, m bimtaor xista
nosno nmoa ncianttee rprpeatlaezsieiomnnefoinn tdea te,
comievl o lreirn trnaeclicldiaeas arolece gi eertmàa anrica
cailc'aa rcdhieu tni«apd oe mocrcaazriaat»td ear izzata
formaes socdiita itcpioovm eu niett eanrdieon zuialmente
gualidtiua n«rali ieb,ge errtmàa niincsao»md,mao a p,p or
rea ll'asasuettotreois tcahriiadove ilslt'adi iRm opmear.o
Idli veartstoe ggaisasmuennnecttiooo n frodnefetli
nomeinnoo g geètr tiofl ecsonis mom edidaatlselczaez la
tsat edseslfoalr em uliem piepgeiarnt dei voi,cdm ouesa ir l
8
è già accennato: se infatti gli storici italiani e francesi, ri
specchiando il sentimento degli abitanti dei territori del
l'impero che videro giungere i barbari, hanno preferito u
sare la locuzione «invasioni barbariche», che implica an
che, di per se stessa, un giudizio di merito circa la supe
riorità della civiltà greco-latina, la cultura tedesca ha inve
ce introdotto il termine «migrazione di popoli» (Volker
wanderung), più neutro e in sostanza più corretto per una
descrizione oggettiva di quanto accadde, ma alla radice
del quale sta l'intento di fondo di «rivalutare» la parte
barbarica, o meglio «germanica». Insomma, questo tema
sconta, come pochi altri, condizionamenti e distorsioni di
giudizio e resta continuamente esposto al pericolo delle
suggestioni dell'oggi: gli stessi fenomeni migratori che ve
dono ai nostri giorni vaste masse umane spostarsi dalle re
gioni meno favorite a quelle economicamente più svilup
pate del pianeta può ben correre il rischio di essere in
qualche misura accostato alle antiche Volkerwanderun
gen, magari da parte di chi, di fronte all'incalzare del cam
biamento, è sempre pronto a paventare la fine dell'ordine
a cui è abituato.
Il periodo storico entro il quale si inserisce la stagione
delle invasioni barbariche, che abbraccia, per usare cate
gorie convenzionali, la tarda antichità e l'alto medioevo, al
meno dal secolo IV fino alle «code» dei secoli X-XI, è at
tualmente oggetto, più di altri, di una particolare attenzio
ne storiografica che sta apportando modifiche sostanziali a
molte delle conoscenze acquisite. Innanzi tutto, la tarda
romanità viene sempre più apprezzata come un'epoca si
gnificativa in sé, dotata di proprie dinamiche interne e di
tratti specifici, anziché essere ridotta -come a lungo è sta
to fatto - al rango di semplice tratto finale della secolare
parabola dell'impero, contraddistinta soltanto da segnali
di inevitabile e irreversibile decadenza; contestualmente, il
processo della transizione dal mondo antico a quello me
dievale viene finalmente colto in tutta la sua complessità e
gradualità, in un complicato gioco di persistenze e di tra
sformazioni, nei singoli settori, piuttosto che essere ridotto
alla rigida contrapposizione di un «prima» e di un «dopo»
divergenti, separati da una secca cesura. In questo senso
muovono molti dei lavori più recenti, ispirati ad attitudini
9