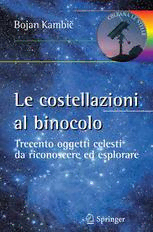Table Of ContentLe Stelle
Collana a cura di Corrado Lamberti
Le costellazioni
al binocolo
Trecento oggetti celesti
da riconoscere ed esplorare
Bojan Kambič
Tradotto dall’edizione inglese:
Viewing the Constellations with Binoculars diBojan Kambič
© 2010, Springer US. Springer US is a part of Springer Science+Business Media
All Rights Reserved
Traduzione di: Corrado Lamberti
ISBN 978-88-470-2708-4 ISBN 978-88-470-2709-1(eBook)
DOI 10.1007/978-88-470-2709-1
© Springer-Verlag Italia 2013
Questo libro è stampato su carta FSC amica delle foreste. Il logo FSC identifica
prodotti che contengono carta proveniente da foreste gestite secondo i rigorosi stan-
dard ambientali, economici e sociali definiti dal Forest Stewardship Council
Quest’opera è protetta dalla legge sul diritto d’autore e la sua riproduzione anche parziale è ammessa esclu-
sivamente nei limiti della stessa. Tutti i diritti, in particolare i diritti di traduzione, ristampa, riutilizzo di il-
lustrazioni, recitazione, trasmissione radiotelevisiva, riproduzione su microfilm o altri supporti, inclusione
in database o software, adattamento elettronico, o con altri mezzi oggi conosciuti o sviluppati in futuro,ri-
mangono riservati. Sono esclusi brevi stralci utilizzati a fini didattici e materiale fornito ad uso esclusivo
dell’acquirente dell’opera per utilizzazione su computer. I permessi di riproduzione devono essere autorizzati
da Springer e possono essere richiesti attraverso RightsLink (Copyright Clearance Center). La violazione
delle norme comporta le sanzioni previste dalla legge.
Le fotocopie per uso personale possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro paga-
mento alla SIAE del compenso previsto dalla legge, mentre quelle per finalità di carattere professionale,
economico o commerciale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da
CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, e-mail autorizzazioni@clea-
redi.org e sito web www.clearedi.org.
L’utilizzo in questa pubblicazione di denominazioni generiche, nomi commerciali, marchi registrati ecc.,
anche se non specificatamente identificati, non implica che tali denominazioni o marchi non siano protetti
dalle relative leggi e regolamenti.
Le informazioni contenute nel libro sono da ritenersi veritiere ed esatte al momento della pubblicazione;
tuttavia, gli autori, i curatori e l’editore declinano ogni responsabilità legale per qualsiasi involontario errore
od omissione. L’editore non può quindi fornire alcuna garanzia circa i contenuti dell’opera.
Foto nel logo: rotazione della volta celeste; l’autore è il romano Danilo Pivato, astrofotografo italiano di
grande tecnica ed esperienza
In copertina: M45, l’ammasso aperto delle Pleiadi
Layout copertina: Simona Colombo, Milano
Impaginazione: Erminio Consonni, Lenno (CO)
Stampa: GECA Industrie Grafiche, Cesano Boscone (MI)
Springer-Verlag Italia S.r.l., Via Decembrio 28, I-20137 Milano
Springer fa parte di Springer Science+Business Media (www.springer.com)
Quali straordinarie scoperte
avrebbe realizzato Galileo
se avesse potuto avere i miei binocoli?
Prefazione all'edizione inglese
Questo libro è un tourguidato attraverso le costellazioni visibili dalle medie latitudini settentrionali.
Volendo trovare una determinata via in una città che non si conosce, si deve disporre di una buona
mappa, altrimenti ci si perde. Questo libro è una vera e propria mappa del cielo. In esso troverete
tutte le vie e gli edifici principali che dovreste visitare, nonché tutti i percorsi e le scorciatoie che
vi porteranno ad essi. Nel testo il lettore troverà informazioni particolareggiate relative a poco
meno di trecento oggetti celesti: stelle doppie e variabili, ammassi stellari, nebulose fino alle ga-
lassie più distanti e ai quasar.
Nella prima parte vengono illustrate alcune nozioni basilari riguardanti l’osservazione astro-
nomica: come scegliere e usare gli strumenti, qualche concetto di astronomia classica, un po’ di
astrofisica e di cosmologia. Gli argomenti trattati sono solamente quelli che ogni astrofilo dovrebbe
conoscere prima di iniziare a esplorare il cielo notturno. Se non si sa nulla dell’oggetto che si sta
osservando, ben presto ci si annoia dietro il binocolo o il telescopio. La conoscenza è alimento per
l’immaginazione!
Nella seconda parte del libro sono riportate le descrizioni di tutte le costellazioni visibili dalle
medie latitudini settentrionali. Si inizia con una semplice cartina celeste per ogni costellazione e
con una breve presentazione delle stelle più brillanti; si continua con la descrizione dettagliata
delle stelle doppie e variabili e degli oggetti del cielo profondo che sono visibili con un binocolo
10×50. Oltre alla descrizione, una mappa celeste indicherà le stelle-guida per individuare la posi-
zione degli oggetti sulla volta celeste. Il libro sembrerebbe indirizzato agli amanti del cielo che
solo ora si stanno avvicinando a questa disciplina, ma in realtà c’è materiale interessante e utile
anche per gli osservatori esperti.
In queste pagine si è scelto di non creare eccessive aspettative nell’astrofilo principiante, che
infatti resta spesso deluso quando vede per la prima volta gli oggetti celesti con i propri occhi, tro-
vandoli così diversi dalle magnificenti fotografie colorate scattate dai telescopi professionali. In
realtà, molti degli oggetti più belli riusciremo a vederli per davvero, con tutti i dettagli, solo quando
avremo accumulato molto esperienza osservativa. Ed è curioso che ciascun osservatore avrà una
reazione del tutto personale a ciò che sta ammirando. Alcuni provano stupore nell’essere in grado
di scorgere galassie lontane milioni e milioni di anni luce, anche se l’occhio non rivela altro che
un debole batuffolo luminoso, privo di strutture, esteso solo pochi primi d’arco. Per altri è eccitante
riuscire a separare le componenti di una stella doppia, che l’occhio nudo vede sovrapposte. Per
altri ancora è affascinante osservare nella direzione del centro della nostra Galassia sapendo cosa
sta avvenendo laggiù, benché le nubi di gas e polveri ci oscurino completamente la vista di quelle
regioni lontane. Ciascun osservatore sceglierà da sé la propria strada.
Non c’è nulla di sconvolgentemente nuovo in questo libro, nulla che non si possa trovare in
altri libri o in Internet. Quel che si spera è che il tutto sia scritto e organizzato in modo divertente
e utile.
Per concludere, mi piace ringraziare il dr. Andreja Gomboc e il dr. Tomaž Zwitter dell’Università
di Lubiana, facoltà di matematica e fisica, per avere esaminato il manoscritto e avermi segnalato
alcuni errori.
L’astronomia è davvero una splendida scienza e l’osservazione celeste è un hobbyfantastico.
Basti pensare a quante cose miracolose abbiamo scoperto sull’Universo da questo piccolo mondo
relegato alla periferia di un’immensa galassia che ruota nello spazio come una trottola.
Quando sfogliamo le pagine di questo libro ci rendiamo conto di quanti, e quanto affascinanti,
siano gli oggetti presenti in cielo. Per osservarli ci basta davvero poco: un binocolo, un po’ di pa-
zienza e il nostro entusiasmo.
BojanKambič
VII
L'autore
BojanKambič è un astrofilo molto impegnato e conosciuto nel suo Paese, la Slovenia. Al pari di
altri eminenti astrofili, ha ricevuto l’onore della dedica di un asteroide (66667 Kambič). In Slovenia
è noto per la sua attività di divulgatore dell’astronomia e come autore di diversi libri: prima di
questo, tradotto in inglese con l’aiuto di Sunčan Stone, ha pubblicato Zvezdni Atlas za Epoho 2000
(Atlante Stellare per l’Epoca 2000). Kambič è anche autore e traduttore di oltre 150 articoli pub-
blicati sulla rivista astronomica slovena SPIKA, da lui fondata nel 1993.
VIII
Sommario
1. Tutto sui binocoli 1
2. Un po' di meccanica celeste 15
3. Tanti Soli lontani 45
4. Oggetti non stellari 91
5. Modelli 117
6. Come prepararsi alle sessioni osservative 129
7. Da Andromeda al Bovaro 139
8. Dal Bulino al Dragone 159
9. Dall'Eridano alla Lira 207
10. Dal Microscopio alla Poppa 233
11. Dalla Freccia alla Volpetta 269
Crediti 321
Indice 323
IX
1
Tutto sui binocoli
La scoperta del telescopio, un tubo ottico dotato di lenti che ingrandi-
scono l’immagine degli oggetti osservati, viene attribuita all’ottico olan-
dese Hans Lippershey (Fig. 1.1), che si pensa abbia realizzato il primo
esemplare nel 1605.
È dell’ottobre 1608 un libro di ottica che descrive per la prima volta
il funzionamento di un telescopio. In quello stesso anno Galileo Galilei
costruì il suo primo telescopio con un ingrandimento di quattro volte
(4×) (Fig. 1.2). Con il suo “occhiale” Galileo guardò la Luna, il Sole, i
pianeti e le stelle, restando sorpreso dal fatto di scoprire oggetti invisibili Figura 1.1. Hans Lip-
all’occhio nudo. pershey (1570-1619).
Gli storici dell’astronomia ancora dibattono se fu davvero Galileo il
primo a decidere di rivolgere il telescopio al cielo notturno. Di sicuro
fu il primo a rendere note le sue scoperte astronomiche attraverso un
libro, il Sidereus Nuncius, pubblicato nel marzo 1610. Quell’anno co-
stituì il punto di svolta decisivo per le osservazioni astronomiche.
Tutti i più importanti astronomi del tempo, da Keplero a Newton a
Huygens (solo per citare i più illustri) cercarono di migliorare il tele-
scopio o di costruirne di tipi diversi, ma questa è un’altra storia, alla
quale si potrebbe dedicare un intero volume.
Già nel 1608, ottici olandesi provarono ad affiancare due tubi ottici
Figura 1.2.Galileo Ga-
identici, realizzando così il primo binocolo. Essi notarono che guar- lilei (1564-1642).
dando con entrambi gli occhi era molto meno
faticoso e assai più naturale che guardare con
uno solo. Oltretutto, il binocolo poteva essere
venduto a un prezzo doppio!
I primi telescopi costavano una fortuna e po-
tevano essere acquistati solo da persone molto
facoltose. Divennero poi disponibili per un
pubblico più vasto solo con lo sviluppo dell’in-
dustria ottica.
Perché il binocolo?
Il binocolo è un rifrattore. L’obbiettivo consiste
di una lente adibita alla raccolta di luce, o meglio
di un certo numero di lenti se il binocolo è di qua-
lità elevata. Su ogni binocolo troviamo riportata
un’informazione del tipo 8×30, 7×40, 10×50,
15×70 ecc. Il primo numero indica gli ingrandi-
menti, mentre il secondo ci dice qual è il diame-
tro dell’obbiettivo, in millimetri. Tanto maggiore
è l’ingrandimento, tanto più vicini sembrano gli
oggetti osservati. Quanto più grande è l’obbiet-
tivo, tanta più è la luce che da esso viene raccolta
e tanto più è luminosa l’immagine; in parole po- Figura 1.2A.Frontespizio del Sidereus Nuncius.
1
Le costellazioni al binocolo
vere, un grosso obbiet-
tivo ci fa vedere oggetti
celesti anche molto de-
boli.
Da tutto ciò pos-
siamo dedurre che i mi-
gliori binocoli sono
quelli con il più forte
ingrandimento e il dia-
metro più generoso.
Tutto vero, ma il prezzo
sale vertiginosamente
al crescere delle dimen-
sioni dell’obbiettivo.
Indicativamente, un binocolo con un diametro di 80 mm costa circa dieci volte più di un binocolo
di 50 mm (a parità di qualità ottica e di costruttore). L’ingrandimento viene di fatto limitato dal tre-
molio dell’immagine quando il binocolo viene sorretto dalle nostre mani. Gli strumenti con più di
dieci ingrandimenti devono essere necessariamente posati su un solido treppiede.
Normalmente, l’immagine che vediamo al binocolo è dritta: è proprio ciò che vedremmo a oc-
chio nudo, ma con un forte ingrandimento. L’immagine viene raddrizzata grazie a due prismi col-
locati tra l’obbiettivo e l’oculare la cui funzione, oltre che di contenere la lunghezza dei tubi ottici,
è anche quella di migliorare la sensazione di tridimensionalità dell’immagine, ciò che è apprezzabile
nelle osservazioni terrestri (a cui i binocoli sono prioritariamente dedicati), ma molto meno in
quelle astronomiche.
Campo di vista
Una caratteristica importante che alcuni costruttori stampigliano sul telaio dello strumento è il
campo di vista, ossia la dimensione angolare della parte di cielo inquadrata dal binocolo. La sua
estensione dipende dall’ingrandimento e dal tipo di oculare. Indicativamente, a 7× il campo è di
7°, a 10× è di 5° e a 20× è di 3°. Se il binocolo è dotato di un oculare migliore, di quelli a grande
campo, l’angolo inquadrato può essere maggiore del 25-30%. Il grande campo di vista rende il bi-
nocolo lo strumento ideale per il principiante; ma anche l’astrofilo navigato si aspetta dallo stru-
mento esattamente questo: quel largo campo visuale che è precluso al telescopio.
L’ampio campo di vista consente al principiante di orientarsi più agevolmente in cielo e di
trovare gli oggetti con maggiore facilità, ma offre anche la possibilità di un’osservazione panora-
mica di oggetti estesi come gruppi stellari e ammassi, oltre che visioni eccitanti delle regioni più
affollate della Via Lattea, ciò che di fatto non si può ottenere guardando con il telescopio. Non è
perciò sorprendente che osservatori navigati abbiano sempre un binocolo affiancato al loro tele-
scopio di 20 o 30 cm. Telescopi e binocoli si integrano fra loro e certamente non si escludono.
Pupilla d’uscita
Una caratteristica importante dei binocoli è la pupilla d’uscita. Vediamo in dettaglio di che
si tratta.
2
1 Tutto sui binocoli
Ogni sistema ottico comprende un obbiettivo e un
oculare (oltre che i nostri occhi). Per ogni strumento si
devono considerare due pupille: quella d’ingresso e
quella d’uscita. La pupilla d’ingresso è l’apertura dello
strumento attraverso la quale entra la luce. Per la gran
parte dei binocoli ciò coincide con il diametro dell’ob-
biettivo. La pupilla d’uscita riguarda invece l’oculare: da
lì emerge la luce raccolta dall’obbiettivo. Possiamo ve-
dere tale pupilla sotto forma di un cerchietto luminoso se
puntiamo il binocolo verso una parete luminosa o verso
il cielo diurno e se guardiamo l’oculare da una trentina
di centimetri di distanza. Questo cerchietto costituisce
l’immagine virtuale dell’apertura del binocolo; se ne può
avere la dimensione se dividiamo il diametro della pu-
pilla d’entrata per l’ingrandimento. Per esempio, in un
binocolo 10×50 è di 2 mm (50 : 10 = 2 mm). La pupilla
d’uscita non può essere misurata con un righello; può
solo essere calcolata (Fig. 1.3).
È regola non scritta il fatto che la dimensione della
pupilla d’uscita dovrebbe essere la stessa o minore di
quella del nostro occhio. Dobbiamo tenere presente que-
sto fatto quando acquistiamo un binocolo o un oculare.
La pupilla umana non ha però sempre le stesse dimen- Figura 1.3.La pupilla d’uscita è il pic-
sioni. Essa si riduce se la luce è intensa e si dilata nel- colo disco luminoso che si può vedere
l’oscurità (Fig. 1.4). Per molti anni, si assunse che la dietro l’oculare. Le sue dimensioni di-
pendono dall’ingrandimento e dal dia-
pupilla umana dilatata al massimo misurasse 7 mm e tale
metro della pupilla d’ingresso.
informazione guidò tutti i costruttori di strumenti ottici che
si convinsero che la pupilla d’uscita idealeper ogni bino-
colo o telescopio dovesse essere di 7 mm. Ora però le idee
sono cambiate, anche per il fatto che ciascuno di noi ha
pupille di dimensioni differenti: c’è chi ha una vista
d’aquila, con la pupilla che può raggiungere addirittura i
9 mm di diametro, mentre altri non riescono a dilatarla per
più di 4 mm anche in luce diurna. In generale, si può dire
che quando si è giovani si ha una pupilla più grande, con
il diametro che si riduce con il passare degli anni. E tutta-
via capita di imbattersi in settantenni con una pupilla più
larga di quella di un ragazzo. Ma allora, perché stiamo di-
scutendo questo punto con tanta insistenza?
In pratica, per osservazioni astronomiche, conviene
acquistare binocoli che non abbiano pupille d’uscita par-
ticolarmente grandi. Il nostro occhio non è un dispositivo
perfetto e la visione è relativamente povera ai bordi.
Chiunque abbia già un briciolo d’esperienza nell’osser- Figura 1.4. Nella luce diurna la pu-
pilla umana è piccola; quando è buio si
vazione telescopica delle stelle ai più bassi ingrandimenti
dilata, in modo che una maggiore
sa bene che, pure con ottiche lavorate perfettamente, le
quantità di luce possa essere raccolta e
stelle non appaiono mai come puntini (come dovrebbe convogliata sulla retina.
3