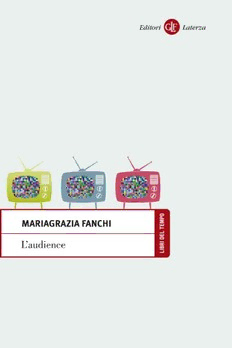Table Of ContentCinque capitoli per esplorare i principali modelli di
audience, tema oggi cruciale delle politiche culturali dei
media. Dalle protoaudience degli anni Trenta – che
restituiscono l’immagine di un fruitore di media passivo e
inconsapevole – all’affermarsi di un’idea di audience
’ostile’, poco collaborativa, che prelude alla definizione
dei modelli di audience resistente degli anni Settanta;
dall’immagine dell’audience come soggetto attivo della
comunicazione, propria del dibattito degli anni Ottanta e
in parte Novanta, fino ai modelli di audience
performativa, responsabile e creativa che caratterizzano la
riflessione e le ricerche degli ultimi anni.
Libri del Tempo Laterza
474
Fanchi.indd 1 27/11/13 11:33
Fanchi.indd 2 27/11/13 11:33
Mariagrazia Fanchi
L’audience
Storia e teorie
Editori Laterza
Fanchi.indd 3 27/11/13 11:33
© 2014, Gius. Laterza & Figli
www.laterza.it
Prima edizione gennaio 2014
Edizione
1 2 3 4 5 6
Anno
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Proprietà letteraria riservata
Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari
Questo libro è stampato
su carta amica delle foreste
Stampato da
Martano editrice srl - Lecce (Italy)
per conto della
Gius. Laterza & Figli Spa
ISBN 978-88-581-0869-7
È vietata la riproduzione, anche
parziale, con qualsiasi mezzo effettuata,
compresa la fotocopia, anche
ad uso interno o didattico.
Per la legge italiana la fotocopia è lecita
solo per uso personale purché
non danneggi l’autore. Quindi ogni
fotocopia che eviti l’acquisto
di un libro è illecita e minaccia
la sopravvivenza di un modo
di trasmettere la conoscenza.
Chi fotocopia un libro, chi mette
a disposizione i mezzi per fotocopiare,
chi comunque favorisce questa pratica
commette un furto e opera
ai danni della cultura.
Fanchi.indd 4 27/11/13 11:33
Introduzione
Per un’archeologia
degli studi sull’audience
Decidere da dove partire è sempre un’operazione complessa. Lo
è di più se il viaggio che ci si appresta a compiere attraversa un
territorio che si distende lungo ambiti disciplinari diversi, ciascuno
con proprie coordinate e mappe. Per questa ragione e con l’intento
di restituire, fin dall’attacco, la complessità e l’articolazione del-
le riflessioni che si sviluppano intorno all’audience, fisseremo tre
inizi, che provano a rispondere ad altrettante domande: che cos’è
l’audience?, ovvero che cosa intendiamo quando parliamo di au-
dience, qual è il portato euristico di questa nozione e quali i suoi
limiti, rispetto ad altri termini (user, per esempio); che cosa sono gli
studi sull’audience?, qual è il perimetro delle ricerche che dobbia-
mo prendere in esame e quale l’arco temporale pertinente; come si
possono ricostruire gli studi sull’audience?, quali sono le prospettive
e quali le logiche impiegate per organizzare il dibattito e quali ap-
procci possono essere oggi più produttivi.
1. “Divide et impera”:
tassonomie e riflessioni sulla nozione di audience
Per chi voglia esaminare il fenomeno delle audience esiste un pri-
mo e sicuro punto di partenza: domandarsi che cosa si intende
per audience.
L’analisi terminologica ed epistemologica della nozione rap-
presenta una base comune a molta parte della riflessione teorica
su questo argomento – e sui media in generale – che si sviluppa
fra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta del secolo scorso.
V
Fanchi.indd 5 27/11/13 11:33
Entrati nella fase matura o di “normalizzazione” dei saperi, gli
audience studies sviluppano una serie di pratiche autoriflessive,
volte a valutare la tenuta delle categorie e dei quadri teorici ela-
borati. L’analisi lessicografica costituisce la prima e la principale
fra queste pratiche; il suo obiettivo è di precisare il significato
dei termini impiegati nel dibattito, a partire dalla nozione di au-
dience, che viene definita in se stessa e in relazione a una serie
di altri vocaboli: pubblico (public), spettatore (spectator), fruitore
(viewer), consumatore (consumer), utente (user) e così via. Riper-
correre questo segmento di riflessione è utile non solo perché
consente di introdurre alcuni primi principi d’ordine negli studi
sull’audience, che possono orientare nell’esplorazione di questo
campo di ricerca, ma anche perché esso dà conto delle differenti
angolature da cui la questione dell’audience è stata affrontata nei
vari contesti disciplinari e culturali1.
1.1. Mercato vs./vel pubblico
Il dibattito intorno alla nozione di audience si struttura intorno a
due principali questioni: quali sono le forme e le manifestazioni
dell’audience – e qual è, quindi, il campo di pertinenza degli studi
omonimi – e quali sono le implicazioni disciplinari e, più in gene-
rale, culturali dell’impiego di tale nozione.
L’operazione di tassonomizzazione dell’audience prende le
mosse da una prima fondamentale distinzione: quella fra audien-
ce stricto sensu e audience come pubblico (Ellis, 1983; McQuail,
1987; Ang, 1991; McQuail, 1997; Gillespie, 2005). Nel primo caso
si pensa ai fruitori come a consumatori di prodotti: sia dei program-
mi e dei contenuti mediali, sia dei “prodotti che sono pubblicizzati
attraverso quei programmi” (McQuail, 1987: 267-268); l’audience,
inoltre, è considerata alla stregua di un prodotto essa stessa, da
misurare, classificare e vendere agli investitori pubblicitari (Ang,
1 Si pensi, per portare l’esempio più eclatante, al distinguo fra pubblico (pu-
blic) e audience (audience), fondamentale nel dibattito angloamericano e nordeu-
ropeo e quasi del tutto assente in quello italiano; indizio, ad un tempo, del diverso
grado di sviluppo della riflessione sull’audience e del differente contesto mediale
e culturale da cui essa origina e che, in un caso, prevede una chiara distinzione fra
servizio pubblico e televisivo e media commerciali, nell’altro no.
VI
Fanchi.indd 6 27/11/13 11:33
1991; McQuail, 1987; McQuail, 1997; Livingstone, Lunt, 2012).
Nel secondo caso, l’audience è intesa come pubblico, insieme di
cittadini “che devono essere orientati, educati, informati, tanto
quanto intrattenuti – in breve ‘serviti’ – presumibilmente per ren-
derli capaci di assolvere al meglio i loro doveri democratici” (Ang,
1991: 75). Sia l’audience come mercato, sia l’audience come pub-
blico sono oggetto di ulteriori classificazioni. Grossberg, Wartella
e Whitney (1998) ce ne offrono un’efficace sintesi. Le audience in
senso stretto sono “identificate” sulla base di quattro principali cri-
teri: il tipo di prodotti preferiti e consumati (market type); il profilo
socio-demografico (demographics); gli orientamenti culturali (taste
culture) e gli stili di vita (life style clusters). L’analisi delle audience
è funzionale a guidare le scelte editoriali delle emittenti e a indiriz-
zare i loro investimenti pubblicitari; essa è dunque strumentale e
sottomessa alle esigenze del mercato.
Allo stesso modo, la nozione di pubblico è stata oggetto di un
puntuale lavoro di analisi. Sempre Grossberg, Wartella e Whit-
ney (1998) individuano quattro declinazioni dell’audience come
“pubblico”: l’individuo, cioè colui che “rende pubblici” i propri
giudizi – per esempio telefonando in redazione, inviando lettere ai
giornali, partecipando alle trasmissioni televisive; l’aggregato, cioè
un insieme di soggetti che condividono consumi e preferenze; il
pubblico in senso stretto, ovvero comunità di fruitori, che cercano
un rapporto dialettico e di confronto con i media e si organizzano
in gruppi di pressione per esercitare un’influenza sulle loro scelte
editoriali e politiche culturali; e infine i cittadini, cioè coloro che
si rivolgono ai media per essere rappresentati o perché essi rap-
presentino “correttamente” la realtà.
Va detto che le classificazioni di audience più recentemente
elaborate tendono a fondere le due aree semantiche dell’audience
in senso stretto e dell’audience come pubblico, sottolineando la
possibilità per un fruitore di essere, a un tempo, consumatore
e cittadino. Sonia Livingstone e Peter Lunt (2012), ad esempio,
considerano l’audience nella sua duplice accezione di “insieme di
individui con preferenze e abitudini di consumo” e “aggregato da
vendere agli investitori pubblicitari”, come una declinazione del
concetto di pubblico.
Il superamento della polarizzazione fra audience e pubblico
permette di arricchire il quadro interpretativo della ricerca, evi-
VII
Fanchi.indd 7 27/11/13 11:33
denziando la necessità, per le ricerche di carattere amministrativo,
di tenere sotto controllo le implicazioni culturali e politiche delle
loro scelte; e l’esigenza, per le ricerche di carattere sociale, di consi-
derare la sostenibilità economica dei progetti (Raboy et al., 2001)2.
Questa operazione si accompagna a un allargamento del peri-
metro della nozione di audience, che include programmaticamen-
te fra le sue accezioni anche quelle elaborate nell’ambito delle teo-
rie degli effetti forti o del dibattito di primo Novecento. Michele
Sorice (2009: 217), per esempio, individua quattro idee correnti
di audience: l’audience come massa manipolabile di individui più
o meno attivi (che fa capo alle teorie della trasmissione e alla Scuo-
la di Francoforte); l’audience come pubblico di cittadini coscienti
dei loro diritti (propria delle teorie degli effetti limitati e degli Usi
e Gratificazioni); l’audience come insieme di mercati con caratte-
ristiche socio-demografiche (impiegata dalle istituzioni mediali e
nelle ricerche amministrative) e l’audience come partner interat-
tivo della comunicazione, capace di esercitare un controllo sui
processi comunicativi, tipica delle teorie della ricezione.
Questo allargamento ai modelli elaborati nell’ambito delle
teorie degli effetti forti si ripercuote evidentemente sugli studi
dell’audience, estendendo il loro campo di pertinenza e il nove-
ro delle questioni con cui essi devono fare i conti (Livingstone,
1998a).
1.2. I limiti dell’audience
La messa in evidenza della pluralità delle accezioni racchiuse nella
nozione di audience e del loro carattere relativo, non esclusivo, né
generalizzabile, corre in parallelo alla riflessione sulle potenzialità
euristiche del concetto e sulla sua capacità di descrivere la varie-
tà e la complessità delle audience “in carne e ossa”. Scrive John
Ellis, all’inizio degli anni Ottanta: “l’‘audience’ è un concetto del
tutto ideologico, che ha ben poco a che vedere con quello che
2 Marc Raboy, Bram Dov Abramson, Serge Proulx e Roxanne Welters (2001)
invitano a considerare le diverse accezioni di audience come facce di una realtà,
poliedrica, ma unica. Mantenere la separazione fra le diverse accezioni di audience
significa depauperare il dibattito, relegando la riflessione sulle implicazioni politi-
che della fruizione mediale alla sola nozione di audience come pubblico.
VIII
Fanchi.indd 8 27/11/13 11:33