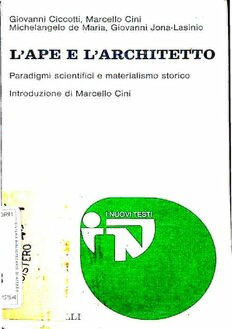Table Of ContentL'APE E L'ARCHITETTO
Paradigmi scientifici e materialismo storico
Introduzione di Marcello Cini
Giovanni Ciccotti
Marcello Cini
Michelangelo de Maria
Giovanni Jona-Lasinio
FELTRINELLI
Prima edizione: febbraio 1976
Copyright by Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano
... l'ape fa vergognare molti architetti con la costruzione
delle sue cellette di cera. Ma ciò che fin da principio
distingue il peggiore architetto dall'ape migliore è il fatto
che egli ha costruito la celletta nella sua testa prima di
costruirla in cera. Alla fine del processo lavorativo emerge
un risultato che era già presente al suo inizio nella idea del
lavoratore, che quindi era già presente idealmente. Non che
egli effettui soltanto un cambiamento di forma
dell'elemento naturale; egli realizza nell'elemento naturale,
allo stesso tempo, il proprio scopo, da lui ben conosciuto,
che determina come legge il modo del suo operare, e al
quale deve subordinare la sua volontà.
K. MARX, Il Capitale, Libro I, Editori Riuniti, Roma 1964, p.
212.
Avvertenza
1
In questo volume sono raccolti alcuni scritti che hanno un
argomento e un fine comune: il tentativo di comprendere
nel suo stadio più evoluto, e perciò anche nel suo sviluppo
storico, la funzione del sistema della ricerca in termini di
quell'attività sociale umana che è l'appropriazione teorico-
pratica della natura, ed entro ciò di comprendere il valore
della scienza. Questo tentativo si avvale degli strumenti
della concezione materialisticostorica marxiana, ma non
pretende di essere, né ambisce a esserlo, una
interpretazione autentica o ortodossa di ciò che Marx
intende per scienza. Vogliamo solo contribuire
all'individuazione delle categorie concettuali adeguate a
una ricostruzione corretta del ruolo e del significato della
scienza nella società capitalistica contemporanea. Tale
ricostruzione secondo noi può essere compiuta soltanto
attraverso un'analisi del mutamento qualitativo che il
sistema della ricerca e i suoi valori hanno subito nel
passaggio dalla fase tecnica del capitalismo industriale alla
fase tecnologica del capitalismo monopolistico. Tale analisi
deve essere tuttavia preceduta da un tentativo di
approfondimento teorico dell'intreccio natura-società, ossia
dell'interazione fra rapporto uomo-natura e rapporti sociali
di produzione, quale esso risulta esplicitamente o
implicitamente dall'opera di Marx, e in particolare dalla sua
concreta costruzione di una scienza della società
caratterizzata da un intreccio oggettività-soggettività che è
al tempo stesso intreccio fra causalità, cioè materialismo, e
finalità, cioè storia.
È appunto ciò che abbiamo tentato di cominciare a fare nei
primi saggi di questa raccolta.
In particolare il saggio sul dibattito epistemologico affronta
nella sua seconda parte alcune questioni generali che sono
state successivamente approfondite e chiarite in quello che
apre la raccolta. Abbiamo tuttavia, per evidenti ragioni di
chiarezza, deciso di non seguire l'ordine cronologico nel
presentarli al lettore. Per quanto eterogenei questi saggi
possano a prima vista apparire, essi sono in realtà legati da
un filo conduttore comune, rappresentato dalla concezione
2
materialistico-storica della scienza che abbiamo tentato di
delineare. Si noterà che a uno di questi scritti ha contribuito
Elisabetta Donini che non condivide con noi la
responsabilità delle tesi sostenute nel libro, anche se in
varia misura ne accetta le idee generali. Vogliamo perciò
ringraziarla non solo per aver acconsentito a includere il suo
articolo in questa raccolta, ma anche per aver contribuito
con discussioni, suggerimenti e critiche al nostro lavoro.
Infine abbiamo cercato di fornire al lettore un ausilio
interpretativo di tutto il materiale presentato, con una
introduzione che cerca di ricostruire, anche attraverso le
memorie dirette di uno di noi, la evoluzione delle idee e
delle concezioni sul ruolo della scienza che si sono
succedute nell'ambito della sinistra italiana negli ultimi
vent'anni. A documentazione di questa ricostruzione
vengono riprodotti in appendice alcuni vecchi articoli che
hanno in qualche modo aperto la strada a quel processo di
elaborazione e di maturazione collettiva che ci ha portato a
formulare le tesi presentate in questo libro. Queste rapide
avvertenze sarebbero incomplete, se non contenessero un
esplicito ringraziamento per i numerosi amici e compagni
che ci hanno ascoltato pazientemente, aiutato
generosamente e criticato acutamente. Fra loro ricordiamo
soprattutto D. Capocaccia e M. Lippi per aver contribuito
attivamente durante la stesura di questi saggi, A. Baracca,
E. Damascelli, A. Gaiano, G. Jacucci, B. Morandi, F. Navach,
A. Rossi, G. Suffritti, T. Tonietti per le critiche e i
suggerimenti, F. Marchetti per aver contribuito alla fase
iniziale di questi lavori.
Infine, più che un ringraziamento un commosso ricordo da
parte del più vecchio di noi. Senza Raniero Panzieri e lo
stimolo della sua lucida e acuta intelligenza i primi articoli
del '65-66 non sarebbero mai stati scritti. Alla sua memoria
di militante rivoluzionario, oltre che di amico fraterno, è
dedicato ciò che ne è risultato negli anni successivi.
Gli Autori
Roma, settembre 1975
3
Introduzione
DI MARCELLO CINI
01
I compiti che vent'anni fa il movimento operaio
organizzato poneva ai ricercatori scientifici della sinistra
italiana erano chiari. In primo luogo favorire tutte quelle
iniziative in grado di raccogliere le forze più aperte e
moderne del mondo della ricerca per rivendicare nei
confronti della classe dirigente un impegno di mezzi e un
potenziamento di strutture e di funzioni a favore delle
istituzioni scientifiche.
Gli interessi di sviluppo dell'economia nazionale nel suo
complesso — si legge a esempio nella risoluzione del
convegno di ricercatori scientifici, economisti, tecnici e
parlamentari comunisti e socialisti tenuto all'Istituto
Gramsci nel settembre 1955 — esigono che [...] lo
sfruttamento della nuova fonte di energia [nucleare, N.d.A.]
e l'applicazione delle nuove tecniche abbia come obiettivo
la riduzione dei costi e il potenziamento dell'intero apparato
produttivo. [...] nel quadro di una politica organica che
coordini l'impiego di tutte le fonti di energia al servizio del
pubblico interesse. [...] D'altra parte la rivoluzione
incipiente nel campo della produzione non è
esclusivamente connessa alla utilizzazione della energia
atomica, bensì all'apertura di molte altre possibilità legate a
tecniche avanzate quali l'impiego dei radioisotopi, della
elettronica e più in generale l'uso sistematico e
consapevole dei servomeccanismi. [...] E oggi più che mai
evidente che l'introduzione e lo sviluppo di siffatte tecniche
ha, come una delle sue necessarie condizioni, una ricerca
scientifica organizzata, e aggiornata in tutti i suoi rami. I
progressi, infatti, della ricerca scientifica odierna nella
maggior parte dei suoi settori non sono più affidati tanto a
studiosi singoli di eccezionale ingegno, dei quali è cosi ricca
da secoli la tradizione scientifica italiana, quanto al
4
concorde lavoro di schiere di ricercatori, all'entità dei mezzi
messi a loro disposizione secondo un organico programma
nazionale, e alla loro persuasione di contribuire al progresso
e al benessere dell'umanità.
In secondo luogo si doveva operare a livello internazionale
per la ricomposizione di una comunità scientifica che, al
disopra di una contingente spaccatura derivante
dall'appartenenza dei suoi membri ai due blocchi, trovasse
nella neutralità e universalità della scienza un terreno di
intesa che fosse garanzia di una comune aspirazione
umanitaria e pacifista.
Né l'uno né l'altro di questi obiettivi apparivano d'altra
parte in contraddizione con una prospettiva politica più
radicale, di trasformazione sociale all'interno e di
rafforzamento del "campo socialista" su scala mondiale.
Anzi ne costituivano tappe intermedie indispensabili per
raggiungere quelle mete.
Per di più, tali obiettivi non scaturivano soltanto
dall'articolazione settoriale di una linea politica contingente,
ma avevano un fondamento teorico in una tradizione
marxista che, anche senza accettare in pieno i pesanti
condizionamenti dello stalinismo, si rifaceva in modo assai
dogmatico all'Engels del Antidühring e della Dialettica della
Natura e al Lenin del Materialismo ed empiriocriticismo. In
quanto ponevano l'accento sul significato gnoseologico
delle scienze della natura, questi scritti, infatti, potevano
ben essere presi a riferimento concettuale per una
concezione del mondo fondata su una netta separazione tra
natura e storia.
Secondo tale concezione, codificata nel "materialismo
dialettico," nella sfera della prima, a una realtà data ed
esterna all'uomo non può che corrispondere, almeno se ci si
limita al piano gnoseologico, una sola scienza possibile:
unica fonte di conoscenza oggettiva in quanto
rispecchiamento di quella realtà e, perciò, al tempo stesso
unico strumento per trasformarla e dominarla. Nella sfera
della seconda, invece, si affrontano le classi sociali
5
all'interno di rapporti che, sia pure attraverso mediazioni e
rotture, sono determinati, in ultima analisi, dal quadro
oggettivo costituito dalle tecniche incorporate nel modo di
produrre, cioè dal livello raggiunto nel controllo della natura
da parte dell'uomo.
Di qui l'impegno prioritario dello scienziato marxista
nell'ambito specifico del proprio campo di ricerca. Impegno
che, fallito il tentativo staliniano di fondare sulle leggi della
"dialettica materialistica" lo sviluppo di una scienza
"socialista" della natura più valida e penetrante di quella
"borghese," non poteva che ridursi — finché questa
dicotomia non fosse stata rimessa in discussione —
all'accettazione incondizionata di quest'ultima, anzi alla sua
giustificazione — apparentemente a posteriori ma in realtà
a priori — nei suoi metodi e nei suoi fini, nelle sue
motivazioni e nei suoi risultati. Tale impegno era per di più
rafforzato dalla convinzione che, cosi facendo, lo scienziato
marxista contribuiva a' far avanzare una visione del mondo
laica e razionale, affermando la superiorità della
metodologia scientifica nei confronti di una cultura
tradizionale, sedicente umanistica, in realtà fatta
soprattutto di oscurantismo e di vacua retorica.
Intendiamoci bene. Nessuno vuole rimpiangere Zdanov. Si
vuole soltanto sottolineare che, se si assume che il processo
di appropriazione della natura da parte dell'uomo sia
indipendente dai rapporti sociali che intercorrono fra gli
uomini, o — in altre parole — se si considera l'evoluzione
delle scienze della natura come una accumulazione di dati
oggettivi che porta a una ricostruzione sempre più
approfondita e fedele di una realtà naturale data, anche se
inesauribile, con la graduale espulsione dal loro corpo di
ogni elemento socialmente determinato, ci sono solo due
possibili scelte. O l'assunzione di uno strumento esterno alla
scienza, le "leggi della dialettica," come chiave per aprire
tutti i forzieri ove sono racchiusi i segreti della natura, o la
santificazione di ogni risultato della scienza come passo
avanti nel cammino dell'umanità "dal regno della necessità
al regno della libertà."
6
La prima scelta non poteva non rivelarsi, come ogni
metafisica, fallace. Né d'altra parte fu mai, in realtà, presa
molto sul serio da noi in Italia. L'allineamento alle tesi del
materialismo dialettico sovietico sulle questioni della
scienza non venne infatti imposto all'interno del Partito
comunista (al tentativo di Sereni di accreditare
ufficialmente il lysenkismo i biologi comunisti espressero un
rifiuto). È anche vero tuttavia che critiche aperte alla
filosofia ufficiale sovietica non trovarono facilmente spazio.
Soltanto dopo il XX Congresso si cominciò a discutere di
questi problemi.
La seconda scelta è una illusione sempre risorgente, e
tutt'oggi vivissima all'interno della sinistra. Per l'appunto
essa risultò rafforzata, per reazione, dal fallimento del
Diamat. Questa reazione traspare chiaramente, a esempio,
nella risposta — peraltro non pubblicata — che ebbi
occasione di scrivere a un questionario inviato nel 1956
dalla rivista "Il Contemporaneo" ad alcuni intellettuali
comunisti. Alla domanda: "In che misura, a tuo avviso, si è
realizzato nel PCI il giusto e necessario rapporto tra l'attività
culturale e la direzione politica?" rispondevo:
Nell'esaminare la questione del rapporto fra direzione
politica e attività culturale in un partito marxista è
necessario tener presente che la prima non può e non deve
predeterminare o circoscrivere a priori i risultati della
seconda, sotto pena di isterilirla e ridurla a una
ripetizione di formule prive di valore conoscitivo. Un
partito marxista trae infatti dall'analisi della struttura
della società attuale, nelle sue contraddizioni e nel suo
sviluppo, lo spunto per la propria azione politica, intesa a
trasformare questa società. Tale azione però sarà destinata
al successo solo se l'indagine, libera da ipoteche
precostituite, avrà rivelato i fatti quali essi sono e non
quali si vorrebbe che fossero.
Per limitarmi a parlare di argomenti più prossimi al mio
campo di attività mi pare necessario che ci ricordiamo quali
gravi danni sono derivati alla scienza sovietica, e
indirettamente alla nostra capacità di affermazione nella
cultura italiana, dalla mancata applicazione dei principi
sopra accennati. Pretendere che un organismo di direzione
politica possa giudicare della validità o meno di una teoria
scientifica in biologia o in fisica o in chimica, sulla base
di princìpi generali comuni a tutte le scienze, è altrettanto
7
metafisico e antiscientifico che costruire un sistema
filosofico per spiegare a priori la realtà alla maniera dei
filosofi idealisti. Non si vuole con questo asserire che i
marxisti non debbano rivolgere la loro critica verso quegli
scienziati — spesso grandissimi scienziati ma cattivi
filosofi — i quali con estrapolazioni arbitrarie dal campo
della fisica o delle scienze naturali arrivano a teorie
inaccettabili sullo sviluppo della società o a concezioni
idealistiche del mondo. È chiaro però che la critica non si
deve fare capovolgendo meccanicamente il procedimento.
Ugualmente meccanicistico è ritenere che il rapporto
struttura/sovrastruttura sia così immediato da determinare
una automatica superiorità della scienza e della cultura
nella società socialista su quelle della società
capitalistica.
Per realizzare un rapporto fra direzione politica e attività
culturale che non conduca a manifestazioni di dogmatismo ma
anzi sia di stimolo alla ricerca, mi sembra indispensabile
non fermarsi alla contrapposizione dei due termini,
identificando le due funzioni in categorie distinte e quasi
antagoniste di comunisti, ma occorre stimolare nel politico
un'attività di produzione culturale e richiedere
all'intellettuale specialista un impegno ad allargare il
proprio orizzonte ai problemi di fondo dello sviluppo della
società.
Né si trattava soltanto degli scienziati della sinistra, che
finalmente potevano sentirsi a loro agio nel loro ambiente,
liberati da una imbarazzante connivenza. L'illusione era
intrinsecamente connessa alla cultura ufficiale del PCI.
Anche la svolta in questo campo rappresentata
dall'immissione di Della Volpe e di altri intellettuali della sua
scuola nella direzione della rivista "Società" ebbe questo
segno. Se da un lato, infatti, essa ebbe un'influenza positiva
— come ricorda Colletti nella sua recente intervista — sulla
formazione di molti giovani intellettuali comunisti, che
vennero indirizzati a ricercare in Marx e in Lenin le fonti di
un marxismo che era stato abbondantemente adulterato,
dall'altro essa ribadì il primato metodologico delle scienze
della natura in quanto riconosceva agli "scienziati," con
l'identificazione di Marx come il "Galilei del mondo morale,"
il possesso dell'unico metodo corretto di conoscenza della
realtà.
Non soltanto tale riconoscimento costituiva dunque una
conferma ideologica per ogni ricercatore comunista della
8
validità del proprio impegno professionale. Esso rafforzava
anche la convinzione che l'intera "corporazione" degli
scienziati fosse intrinsecamente e oggettivamente
progressista, e giustificava la scelta di appoggiare ogni
iniziativa che raccogliesse i suoi esponenti più autorevoli,
indipendentemente dalla loro posizione politica individuale.
La manifestazione culminante di questa linea fu la lotta, alla
quale partecipò in prima fila la sinistra, condotta dai fisici
alla fine del '59 per "ottenere un definitivo assestamento
della organizzazione della ricerca nel campo delle scienze
nucleari." Essa ebbe successo nel senso che assicurò per
qualche anno — fino al "caso Ippolito" nel 1963-64 — una
relativa larghezza di mezzi alla ricerca nucleare, e in
particolare al settore più costoso delle ricerche fisiche
cosiddette fondamentali, quello delle "particelle
elementari." Non a caso questo settore dove era
concentrata la maggioranza dei fisici più dinamici, collegati
a una "corporazione" internazionale particolarmente forte e
prestigiosa, era stato la punta di diamante dell'agitazione. Il
suo successo, tuttavia, frutto anche del consenso e
dell'appoggio di ambienti esterni al mondo della ricerca,
può essere considerato il primo sintomo di un'attenzione
per la scienza da parte di alcuni settori della classe
dirigente che rappresenta una novità di rilievo rispetto agli
anni Cinquanta.
Nel '60 la Confindustria organizza un convegno a Ischia nel
quale si sollecita l'intervento statale a sostegno di una
ricerca scientifica di cui le imprese avrebbero potuto
utilizzare i risultati. Un anno dopo, nel dicembre '61, la DC
tiene un convegno sul tema "Una politica per la ricerca
scientifica" destinato a presentare la piattaforma
programmatica del nascente centro-sinistra in questo
campo e ad assicurare in questo modo al nuovo corso
politico l'adesione della maggior parte degli scienziati
progressisti. Elemento qualificante del nuovo corso è la
programmazione economica: in questa prospettiva la
ricerca scientifica assume, almeno nelle intenzioni, un ruolo
qualitativamente importante. Tra i comunisti comincia a
porsi il problema dell'inadeguatezza delle posizioni
9