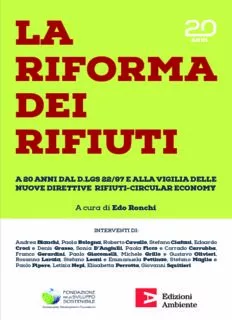Table Of ContentCon il Decreto legislativo 5 febbraio 22 del 1997 in Italia LA
si è realizzata una vasta riforma del sistema della gestione
dei rifiuti, un tema che oggi è in procinto di vivere un importante
ANNI
anno di transizione, grazie all’avvio del nuovo pacchetto
di direttive europee per lo sviluppo dell’economia circolare.
RIFORMA
In un contesto in così significativa mutazione “La riforma dei rifiuti” 7
9
propone una riflessione sui venti anni trascorsi e sulle prospettive /
2
2
future, con il contributo di un qualificato panel di esperti. S
G
L
D. DEI
L
A
D
I
N
N
A
0
2 RIFIUTI
A
-
I
T
U
I
F
I
R
I A 20 ANNI DAL D.LGS 22/97 E ALLA VIGILIA DELLE
E
D NUOVE DIRETTIVE RIFIUTI-CIRCULAR ECONOMY
A
M
R A cura di Edo Ronchi
O
F
I
R
A INTERVENTI DI:
L
Andrea Bianchi, Paola Bologna, Roberto Cavallo, Stefano Ciafani, Edoardo
Croci e Denis Grasso, Sonia D’Angiulli, Paola Ficco e Corrado Carrubba,
Franco Gerardini, Paolo Giacomelli, Michele Grillo e Gustavo Olivieri,
Rosanna Laraia, Stefano Leoni e Emmanuela Pettinao, Stefano Maglia e
I
N Paolo Pipere, Letizia Nepi, Elisabetta Perrotta, Giovanni Squitieri
N
A
20,00 euro
LA RIFORMA
DEI RIFIUTI
A 20 ANNI DAL D.LGS 22/97 E ALLA VIGILIA DELLE
NUOVE DIRETTIVE RIFIUTI-CIRCULAR ECONOMY
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
INDICE
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
INTRODUZIONE
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
Una riflessione sui cardini della riforma dei rifiuti del D.Lgs 22/97,
utili per recepire le nuove Direttive sulla circular economy
Di Edo Ronchi 7
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
CONTRIBUTI E RIFLESSIONI SUI PRINCIPALI TEMI DELLA
RIFORMA DEI RIFIUTI
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
Tentativi e volontà di rischiare del D.Lgs 22/97 possono essere
replicabili con l’attuazione della nuova normativa comunitaria
dell’End of waste?
Di Andrea Bianchi, Confindustria LA RIFORMA DEI RIFIUTI 18
Inquadramento ed evoluzione normativa della pianificazione
dei rifiuti urbani
Di Paola Bologna, Avvocato LA RIFORMA DEI RIFIUTI 28
Il D.Lgs 22/97: un’esperienza della sua applicazione e alcune
indicazioni
Di Roberto Cavallo, ERICA soc. coop. LA RIFORMA DEI RIFIUTI 39
Economia circolare e lotta agli ecoreati, dall’emergenza
all’eccellenza
Di Stefano Ciafani, Legambiente 48
La riforma dei rifiuti: un bilancio venti anni dopo per
affrontare le nuove sfide europee
Di Edoardo Croci e Denis Grasso, IEFE-Università Bocconi 55
End of Waste e prospettive di attuazione con il modello delle
procedure semplificate
Di Sonia D’Angiulli, Avvocato 71
Le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti: contenuti,
estensioni e possibili interpretazioni
Di Paola Ficco, Avvocato e Corrado Carrubba, Avvocato 83
LA RIFORMA DEI RIFIUTI LA RIFORMA DEI RIFIUTI
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
Il processo di modeLrAni zRzIaFzOioRneM dAel DlaE gIe RstIiFonIUe dTeIi rifiuti,
avviato venti anni fa, va ancora completato
Di Franco Gerardini,
Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo 94
20 anni fa l’Italia hLaA a RvvIFiaOtoR uMnA pe DrcEoIr RsoI FchIUe lTaI p one fra le
eccellenze europee in materia di gestione dei rifiuti, anche se
restano questioni importanti da migliorare
Di Paolo Giacomelli, Utilitalia 114
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
La gestione dei rifiuti d’imballaggio in Italia: profili e criticità
concorrenziali
Di Michele Grillo, Università Cattolica del Sacro Cuore
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
e Gustavo Olivieri, LUISS Guido Carli 127
Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22: una riforma attuale
Di Rosanna Laraia, ISPRA 133
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
Evoluzione della pianificazione e del fabbisogno impiantistico
per la gestione dei rifiuti
Di Stefano Leoni e Emmanuela Pettinao,
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
Fondazione per lo sviluppo sostenibile 148
Il punto sulle procedure semplificate di recupero
Di Stefano Maglia e Paolo Pipere, ASS.I.E.A.
(Associazione Italiana Esperti Ambientali) 167
Idee e proposte per il dibattito sulla regolazione della gestione
dei rifiuti
Di Letizia Nepi, FISE UNIRE 192
1997-2017: i cambiamenti realizzati e quelli ancora da fare
nella gestione dei rifiuti
Di Elisabetta Perrotta, FISE ASSOAMBIENTE 202
Il modello italiano di gestione dei rifiuti d’imballaggio: un
successo di portata europea
Di Giovanni Squitieri, Invitalia 213
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
A 20 ANNI DAL D.LGS 22/97 E ALLA VIGILIA DELLE NUOVE DIRETTIVE
RIFIUTI-CIRCULAR ECONOMY
Per la Fondazione per lo sviluppo sostenibile, hanno contribuito:
Alessandra Bailo Modesti, Andrea Barbabella, Delia Milioni,
Raimondo Orsini, Vittoria Elena Papa
© copyright 2017 Fondazione per lo sviluppo sostenibile
Via Garigliano 61 A, 00198 Roma
tel. 06.8414815, fax 06.8414853
[email protected]
www.fondazionesvilupposostenibile.org
@ copyright 2017 Edizioni Ambiente srl
Via Natale Battaglia 10, 20127 Milano
tel. 02.45487277, fax 02.45487333
www.edizioniambiente.it
www.freebookambiente.it
www.reteambiente.it
www.rivistarifiuti.it
www.materiarinnovabile.it
Finito di stampare nel mese di Febbraio 2017
presso Primaprint srl
Via dell’Industria 71, 01100 Viterbo
su carta Cyclus Offset certificata
Stampato in Italia – Printed in Italy
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
INTRODUZIONE
UNA RIFLESSIONE SUI CARDINI DELLA
RIFORMA DEI RIFIUTI DEL D.LGS 22/97,
UTILI PER RECEPIRE LE NUOVE
DIRETTIVE SULLA CIRCULAR ECONOMY
di Edo Ronchi
Il D.Lgs 22/97 è un testo complesso che attua una riforma organica,
recependo, in modo coordinato, tre Direttive europee: sui rifiuti, sui rifiuti
pericolosi e sugli imballaggi. Risponde all’idea di produrre un testo unico
ambientale in materia. In questo Rapporto, a vent’anni da quella riforma,
diversi esperti ne affrontano gli aspetti di maggiore interesse. Non vorrei
riprendere i loro interventi, se non per ringraziarli tutti per aver accettato
di partecipare a questa riflessione. Questo bilancio a 20 anni di quella
riforma dei rifiuti propone una riflessione sui contenuti e sugli effetti
prodotti da quella normativa anche per trarre spunti e indicazioni utili
per il recepimento nell’ordinamento nazionale del pacchetto di Direttive
europee di prossima approvazione in materia di rifiuti-circular economy.
Vorrei partecipare a questo dibattito come testimone di quella riforma,
delle idee e delle intenzioni che l’hanno animata, limitandomi ad alcuni
aspetti e contenuti che furono per me allora prioritari, trascurandone
altri, pure importanti (come la prevenzione o il riutilizzo e altri ancora).
Contando anche sul fatto che in questo Rapporto pubblichiamo diversi
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
e qualificati interventi che forniscono un quadro ampio, e non privo di
differenti valutazioni, che consente una riflessione aperta e articolata sulla
riforma del D.Lgs 22/97 e sul recepimento delle nuove Direttive europee
in materia.
La priorità del riciclo fu un cardine del disegno riformatore del D.Lgs
22: priorità che richiedeva il raggiungimento di livelli elevati di raccolta
differenziata.
Quando fu avviata la riforma, la raccolta differenziata
7 RONCHI
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
ANNI
dei rifiuti urbani era marginale. La gran parte finiva in discarica:
nel 1997 su 26,6 Mton di rifiuti urbani prodotti in Italia solo 2,5
Mton erano raccolti in maniera differenziata - pari al 9,4% - e ben
(dati Ispra). Lo smaltimento in
21,3 Mton - l’80% - finivano in discarica
discarica era la modalità di gestione dei rifiuti ampiamente diffusa perché
appariva il sistema più semplice e - sottovalutando i costi ambientali -
anche il meno oneroso.
Un ricorso massiccio allo smaltimento in discarica, in realtà, comporta:
• un grande spreco di risorse (milioni di tonnellate di materie prime e
materiali riutilizzabili vengono letteralmente buttate via);
• rilevanti impatti ambientali (le discariche occupano, consumano e
inquinano territorio e spesso anche le acque di falda);
• continue emergenze perché le discariche si esauriscono e, data la
difficoltà a localizzarne nuove in un territorio delicato e densamente
popolato come il nostro, se non ci sono alternative si rischia di lasciare
i rifiuti per strada.
Come principale alternativa alla discarica riscuoteva, allora, un notevole
consenso fra i decisori politici l’incenerimento massiccio dei rifiuti.
Piaceva l’idea di un’industrializzazione del ciclo dei rifiuti affidata a pochi
grandi impianti, visti come soluzione del problema. La simpatia per
l’incenerimento di massa era basata anche sulla sottovalutazione delle
possibilità e dei vantaggi del riciclo dei rifiuti e sui pregiudizi diffusi nei
confronti della raccolta differenziata che portavano a ritenerla difficile da
praticare e impossibile da sviluppare con percentuali elevate. La Direttiva
sulla gerarchia dei rifiuti che avrebbe dato priorità al riciclo sarebbe
arrivata molto dopo (con la Direttiva 98 del 2008); il dibattito a livello
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
europeo era stato appena aperto con la Strategia, presentata nel 1996 dalla
Commissione europea, sulla gestione dei rifiuti che dava grande peso al riciclo
e cominciavano ad essere disponibili analisi tecniche che dimostravano la
convenienza non solo ambientale, ma anche economica e occupazionale del
riciclo dei rifiuti. La scelta di anticipare gli indirizzi europei sulla gerarchia
nella gestione dei rifiuti, assegnando una chiara e netta priorità al riciclo,
attribuendo un ruolo esplicitamente secondario al recupero energetico e
residuale allo smaltimento in discarica, anche se poteva contare su riferimenti
RONCHI 8
e basi robuste, non fu né semplice né scontata nel contesto di quegli anni.
Il D.Lgs 22 stabilì che la raccolta differenziata doveva servire a “raccogliere
i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione
umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima”
.
A scanso di equivoci - anticipando la gerarchia nella gestione dei rifiuti
introdotta successivamente a livello europeo - stabilì che “il riutilizzo,
il riciclaggio, e il recupero di materia prima debbono essere considerati
preferibili rispetto alle altre forme di recupero” e che occorreva favorire
“la riduzione dello smaltimento finale”. Ampio dibattito suscitò anche
l’introduzione di obiettivi quantitativi minimi di raccolta differenziata
da raggiungere in tutti gli ambiti ottimali (15%, 25% e poi almeno al
35% a partire dal 6° anno). Perché il 35%? Perché ritenevamo che per
arrivare ad un minimo del 35% servisse, oltre alla raccolta dei vari rifiuti
d’imballaggio, anche quella della frazione organica da avviare al riciclo per
la produzione di compost, di biogas e di biometano. E avviata la raccolta
differenziata di tutte le principali frazioni dei rifiuti urbani sarebbe stato
gradualmente possibile arrivare a percentuali molto più elevate. La
riforma puntò anche a rafforzare e indirizzare le Istituzioni ai vari livelli a
promuovere lo sviluppo delle raccolte differenziate. Allo Stato competeva,
fra l’altro, “l’indicazione di criteri generali per l’organizzazione e l’attuazione
della raccolta differenziata dei rifiuti urbani”; alle Regioni “la regolamentazione
delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata”; e ai
Comuni stabilire “le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del
trasporto dei rifiuti urbani”. Quando si raggiungono buoni livelli di raccolte
differenziate, come oggi nella maggior parte delle città italiane, restano
alcuni problemi che non devono essere trascurati ma che devono ricevere
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
grande attenzione anche in futuro, nel contesto del recepimento delle
nuove direttive: mantenere buoni livelli di raccolta differenziata e non
diminuirli, aumentarli ulteriormente e migliorarne la qualità. Senza mai
abbassare la guardia, migliorando e mantenendo elevato il coinvolgimento
dei cittadini, la motivazione e la preparazione del personale dedicato alle
raccolte, migliorando le modalità di raccolta e l’efficienza dei sistemi di
organizzazione e di gestione.
9 RONCHI
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
ANNI
Una buona raccolta differenziata è indispensabile, ma è la parte iniziale di
un percorso di riciclo. È bene ricordare che i nuovi obiettivi europei sono
fissati come target di avvio al riciclo. Come fare per raggiungere obiettivi
avanzati di riciclo? Oggi come allora non basta il mercato. Nel 1998 il
mercato del recupero assorbiva una raccolta differenziata al 9,4%: 3,3 Mton
di rifiuti di imballaggio, composti da 2,4 Mton di rifiuti di imballaggio
industriali e commerciali (facili da raccogliere essendo già separati) e solo
0,9 Mton di imballaggi presi dai rifiuti urbani.
Era evidente che sarebbe stato molto costoso e praticamente impossibile
far crescere la raccolta differenziata a livelli elevati affidandosi solo al
mercato, senza garantire sempre e dovunque il ritiro e l’avvio al riciclo
di tutti i rifiuti raccolti separatamente e senza assicurare sempre un
ritorno economico certo a chi faceva tale raccolta. Recependo la Direttiva
imballaggi ritenemmo che fosse una priorità garantire che il sistema
Conai-Consorzi di filiera degli imballaggi assicurasse comunque il
ritiro - e prioritariamente l’avvio al riciclo - di tutte le frazioni raccolte
separatamente di carta, vetro, plastiche, legno, alluminio e acciaio, anche
quando il mercato non le assorbiva direttamente, versando ai Comuni,
quando il mercato del recupero non garantiva direttamente un prezzo
migliore, un corrispettivo che coprisse i maggiori oneri sostenuti per la
loro raccolta differenziata. Era consentito ai produttori e utilizzatori di
imballaggi di organizzarsi anche autonomamente o di dare vita in forma
associata ad altri Consorzi, purchè non minassero la struttura di questo
sistema con forme che favorissero l’elusione del contributo ambientale e
non speculassero sulle raccolte più facili e redditizie, ma raccogliessero i
propri rifiuti d’imballaggio sull’intero territorio nazionale, non solo nelle
zone più comode e meno costose. Questo sistema assegnava, per scelta,
LA RIFORMA DEI RIFIUTI
priorità alle frazioni delle raccolte differenziate dei Comuni (più difficili e
costose), strategiche per rendere sostenibile la gestione dei rifiuti urbani.
Gli imballaggi secondari e terziari, di origine commerciale e industriale,
erano già raccolti in buona quantità con meccanismi di mercato, perché
più facili da raccogliere e avviare al recupero. Per questi si ritenne che
non fosse necessario pagare dei corrispettivi, ma che fosse sufficiente che i
Consorzi di filiera sostenessero solo i costi di piattaforme di conferimento,
RONCHI 10
Description:Di Stefano Leoni e Emmanuela Pettinao,. Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Il punto sulle procedure semplificate di recupero. Di Stefano Maglia