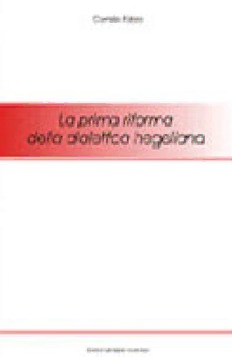Table Of ContentLA PRIMA RIFORMA DELLA DIALETTICA HEGELIANA
Cornelio Fabro
L
A PRIMA RIFORMA
DELLA DIALETTICA HEGELIANA
a cura di Christian Ferraro
Editrice del Verbo Incarnato
Prima edizione 2004
© 2004 – Editrice del Verbo Incarnato
P.zza San Pietro, 2 – 00037 Segni (RM)
PRESENTAZIONE
Non è cosa di ogni giorno presentare un’opera inedita. Se alle volte potrebbe scoraggiare un po’ il dubbio riguardo
all’autenticità del testo, nel nostro caso però è lo stesso Autore a far constatare in maniera chiara ed inequivocabile non
solo l’autenticità dell’origine, ma anche la sua volontà decisa e risoluta di editare l’opera.
Come testimonia il carteggio che accompagnò la faccenda, si tratta del frutto di un lavoro di quindici anni
prospettato in maniera unitaria – sebbene non sistematica –, e Fabro vedeva in esso un messaggio per le «nuove leve del
pensiero». Il Nostro era, inoltre, pienamente consapevole dell’alto livello speculativo in cui si muoveva: alta metafisica.
L’intensità, la densità, la profondità ed acume del discorso raggiungono qui in alcuni momenti dei vertici difficilmente
superabili, degni di un Pensatore Essenziale.
Assistiamo, dunque, ad un dialogo e ad un confronto fra colossi, ad un duello metafisico di tensione massima fra il
più assoluto degli idealisti e il più essenziale dei tomisti. L’assunto è per Fabro una questione di serietà suprema: a
livello teoretico, tutta la serietà della realtà; a livello esistenziale, tutta la serietà della testimonianza della verità – al di
sopra di mode e prudenze umane.
Il nostro più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito perché questo libro veda la luce e alle
persone che ci hanno incoraggiato. In maniera particolare, ai padri stimmatini della provincia del S. Cuore e alla
prof.ssa Anna Giannatiempo, che ci diedero la possibilità di ottenere il dattiloscritto con le correzioni fatte da Fabro
stesso.
A modo di appendice di questa breve presentazione, eliminando ogni riferimento personale, alleghiamo a
continuazione alcune lettere – una, in copia dalla carta manoscritta – inviate da Fabro alla casa editrice e alla persona
intermediaria.
Christian Ferraro
PROLOGO - LA LIBERTÀ COME DIALETTICA DELL’ESISTENZA
Non c’è termine più affascinante per lo spirito umano di quello della libertà: della capacità di scegliere,
di realizzare, ossia di venire a capo del proprio destino nell’Assoluto della scelta stessa. La libertà indica
l’uomo concreto e attivo nel divenire stesso com’egli si è scelto di voler divenire. La libertà perciò non è un
concetto ma un atto: è infatti l’affermazione dell’Io come compito e dovere, come rischio di audacia per
trascendere il dato, come possibilità ed inizio, e realizzare ossia porre in atto l’aspirazione suprema alla
felicità. È un rischio – e quale rischio! Quello anzitutto di spezzare l’indifferenza e attuare la possibilità,
l’indifferenza delle ricorrenti alternative della scelta e la possibilità che sta a fondamento dell’alternativa
stessa. È la possibilità esistenziale originale che rimane sempre aperta all’atto, lo sostenta nel suo muoversi,
ma anche lo può deludere e perfino tradire – nell’urto con la realtà – ad ogni passo. La libertà, infatti, traccia
il cammino dell’Io nella sua avventura terrena ed è perciò estremamente ambigua in qualsiasi scelta: non
soltanto nell’alternativa attiva della sua possibilità in cui l’Io si può insieme costruire e demolire, fin quando
non si decide di sbarazzarsi dalle suggestioni del finito e di aderire con i colpi d’ala dello spirito per
trascendere il finito e l’apparente e fissarsi nella decisione di essere profondo davanti a Dio creatore, cioè al
Principio primo e per il cristiano davanti a Cristo che farà il giudizio della storia.
INTRODUZIONE - L’ESSERE COME INIZIO - (IL PROBLEMA HEGELIANO DEL COMINCIAMENTO)
§ 1. Il cominciare sembra proprio della vita, ch’è attività immediata e non della filosofia ch’è opera di
riflessione. Ma soltanto la filosofia può porre allo spirito il problema del proprio cominciare e quindi della
propria nascita e giustificazione. E come nella vita il cominciare contiene già in atto i principi dell’essere
come fondamento del proprio sviluppo, così anche in filosofia il cominciare non è tanto o soltanto un punto
di partenza ma forma insieme la costituzione e fondazione in atto dell’atto teoretico fondamentale. Il
parallelo fra il processo della vita e quello della riflessione finisce qui, anche se tutto nell’espandersi e
svolgersi della vita può appartenersi e riflettersi dall’una all’altra sfera, dalla sfera biologica a quella della
riflessione e dal mondo all’io, all’affermazione dell’Assoluto in una circolazione infinita che si fissa nel suo
centro.
Il cominciare in filosofia – quand’essa è, come dev’essere, la «riduzione al fondamento»1, ch’è lo
stabilirsi della riflessione stessa nel suo principio – è di conseguenza lo stabilire anzitutto la determinazione
del proprio metodo. Non è quindi semplicemente un cominciare iniziale che lascia alle spalle il proprio
inizio, ma si tratta di un cominciamento costitutivo che fa del proprio inizio l’istanza teoretica la quale è la
garanzia insieme radicale della verità, sempre presente e sempre aperta.
La filosofia, per chi l’ammette e affida ad essa la fondazione del senso ultimo della verità, è la riflessione
essenziale che ha per oggetto la «prima verità» ossia l’illuminazione originaria ch’è la verità dell’essere. Per
questo la filosofia, nell’ambito della ricerca umana, viene per ultima: l’uomo, sospinto dalle istanze
immediate della vita, si diffonde nel lavoro, nella scienza, nelle arti e si pone i problemi della vita etica,
sociale, religiosa, politica nell’orizzonte della propria esistenza. La verità di queste sfere può essere detta, sia
pur in diversi modi, verità di primo grado od anche – con terminologia husserliana – «verità regionale» e –
con terminologia heideggeriana – «verità ontica». La verità essenziale, ch’è propria della filosofia, va detta la
verità dell’essere in quanto essa è e deve mostrare il fondamento e il paradigma di ogni verità: non si tratta
quindi semplicemente di dare una «definizione logica» della verità, a partire dai contenuti di scienza e di
esperienza già noti, quanto di mostrare e soddisfare l’esigenza primordiale del conoscere stesso, rispetto al
reale nel suo fondamento ch’è, per l’appunto, quello di un porsi e di un essere posto. In altre parole – e la
cosa è tanto ovvia che sembra superfluo l’insistervi – si tratta anzitutto e soprattutto di chiedersi e di chiarire
(decidere) qual è e come si pone, in ultima istanza, il rapporto di essere-pensiero: se è l’essere che fonda il
pensiero (realismo) oppure se è il pensiero che produce e fonda l’essere (immanentismo). Tale è il senso del
problema del cominciamento in filosofia.
§ 2. È chiaro che l’alternativa di cui si parla non è di natura puramente logica o terminologica (lessicale),
ma rigorosamente speculativa e costitutiva in senso forte. Si vuol dire che quando e per il fatto che la
filosofia dell’immanenza opta per l’essere di coscienza e pone il pensiero a fondamento dell’essere, non
elimina affatto l’istanza dell’essere e la sua semantica: anzi lo ritrova dappertutto – né più né meno della
filosofia della trascendenza –, soltanto che si tratta sempre di un «essere di coscienza» ovvero ch’esso
scaturisce in atto dalla funzione di coscienza; che sorge, sempre e dovunque non solo mediante la coscienza,
ma come «struttura di coscienza» e come «contenuto di coscienza»2. Parimenti, quando e per il fatto che la
filosofia della trascendenza accetta e pone l’essere a fondamento dell’atto di coscienza e riferisce perciò la
coscienza all’essere subordinando l’attività della coscienza al presentarsi dell’essere alla coscienza stessa,
essa non nega affatto l’attività della coscienza ma piuttosto la sospinge in profondità all’infinito com’è
infinito l’orizzonte dell’essere che di continuo l’attira e la mette in tensione. Se nell’immanentismo la
coscienza può «divagare» a suo piacere, perché è fatta arbitra dell’essere, nel realismo invece la coscienza,
sempre impegnata a fare i conti con l’essere e ad impegnare in esso la sua libertà, se vuole conservarsi in
atto, non può concedersi distorsioni o abbandonarsi a capricci, ma si «protende» per spinta intrinseca verso
l’essere dell’ente al quale rimanda ogni pensare ed ogni discorso: lo,goj li significa entrambi in un plesso
indissolubile.
Il divario quindi, dal punto di vista metodologico, fra immanentismo e realismo, non è tanto nella scelta
casuale dell’immanenza con esclusione della trascendenza o viceversa, ma nella fondazione del rapporto
rispetto all’essere: è questo rapporto che deve anzitutto interessare, se non si vuol lasciare che il pensiero giri
a vuoto e che la filosofia non significhi più nulla. E il rapporto nell’immanentismo moderno significa che il
pensiero dell’essere si rapporta alla coscienza nel senso che esso procede dalla coscienza e secondo il modo
(e i modi) della coscienza, così che «essere» si risolve in un legame («copula») di pensiero e perciò di
coscienza, comunque la coscienza si attui e si volga. Nel realismo il rapporto significa che la coscienza per
attuarsi si rapporta all’essere nel senso ch’essa è svegliata dal presentarsi in atto dell’essere, e che è guidata
dai principi dell’essere, e ch’è attirata e stimolata dalla varietà e complessità inesauribile dell’essere.
Questa formula semplifica molto, l’ammetto, tanto il realismo quanto l’idealismo o diciamo più
propriamente l’immanentismo: essa ora vuole soltanto accentuare la divergenza di fondo fra il pensiero
classico e il pensiero moderno. Noi ci chiediamo infatti se è ancora possibile la filosofia per se stessa, come
atteggiamento fondamentale della coscienza ossia come determinazione della «verità dell’essere» nel senso
di chiarificazione del suo fondamento.
Questa richiesta può ancora avere un fondamento, dopo che il cogito come attività si è dissolto nel puro
volo (attività) e la filosofia è svanita nel prassismo puro (marxismo, attualismo, esistenzialismo, filosofia del
linguaggio e della scienza, semantica, ecc. ecc.), cioè dopo ch’essa è diventata filosofia di tutto purché non
sia la «ricerca del fondamento»?
§ 3. La DIREMTION di realismo e idealismo ossia l’alternativa radicale, che stiamo introducendo, fra la
filosofia classica e la filosofia moderna, ha il suo punto saldo di riferimento nell’antitesi del rapporto di
pensiero ed essere. Quest’antitesi ha avuto il suo punto di partenza, com’è noto, col sorgere stesso della filo-
sofia nel principio di Parmenide: «senza essere non c’è pensiero» (B 8, 34)3 ch’è il motto della filosofia
speculativa. Ma Parmenide ha anche affermato che «l’essere e il pensiero sono la stessa cosa» (B 3)4 e questo
principio che non può evidentemente anticipare di due millenni l’immanentismo moderno affermava, contro
il materialismo democriteo, l’appartenenza intrinseca e scambievole dell’essere al pensiero e del pensiero
all’essere. Ciò suggerisce già che il locus debitus della verità dell’essere non può essere né il realismo
empirico materialistico né il soggettivismo o immanentismo trascendentale ma il superamento della loro
antitesi. Di qui l’importanza che ha in filosofia il «Cominciare» il quale è non tanto il fare il «primo» passo
del cammino, ma un mettersi nel «luogo della verità»: è perciò come un trovare e uno stabilire la luce che
illumina il cammino e lo rende possibile, non solo al primo passo, ma lo sostenta e lo sospinge di tappa in
tappa.
Il cammino della verità deve quindi presentarsi come interiore al pensiero stesso, deve apparire come
essenziale al primo atto e passo del pensare così che ogni pensare seguente non è che uno svolgimento
all’interno di quel primo passo e un’ulteriore soddisfazione di quella prima richiesta. Infatti la filosofia è
anzitutto la giustificazione della verità del pensiero ovvero la fondazione della verità come tale: così essa è, e
dev’essere, il portarsi e riportarsi al momento originario dello stabilirsi della verità in sé, ossia, con parole
più elementari, è il ritrovare e chiarire quell’evidenza primitiva la quale alimenta ogni altra verità della vita e
ogni altra evidenza della scienza. È questa l’evidenza originaria poiché essa dà luce e certezza a ogni verità
ed è da tutte presupposta, ma essa nulla presuppone.
Tale infatti è l’esigenza che anche Hegel, collegandosi più a Parmenide su questo punto che non a
Cartesio o a Kant, ha giustamente rivendicato quando ha attribuito al metodo della filosofia la «mancanza di
presupposti» (Voraussetzungslosigkeit)5. Infatti sotto l’aspetto positivo il cominciare senza presupposti si-
gnifica soprattutto che il modo di cominciare della filosofia deve essere proprio alla filosofia e non
mendicato da altre sfere della coscienza e conoscenza sia empirica come scientifica, tecnica, morale,
religiosa… Sotto l’aspetto negativo, invece, e di conseguenza, il cominciare senza presupposti diffida ogni
altro atto e modo di cominciamento che contrasta l’apertura della riflessione radicale: esclude perciò ogni
«cominciare di presunzione» cioè sia l’intuizione assoluta sia la deduzione dimostrativa, sia il sentimento
puro (la fede) sia l’azione pura ed ogni «salto» nell’irrazionale. Sarebbe questo un cedere via via alla
disperazione o alla hybris, invece di interrogare per primo il logos della ragione: il cominciamento
diventerebbe un atto di sopraffazione, una violenza contro il pensiero. Ma il pensiero, cioè lo spirito, non può
patire violenza: perciò quel cominciare di presunzione non è affatto un cominciare ma soltanto un
allontanarsi ed un vagolare impotente. Legittima perciò può sembrare l’esigenza di Hegel al redde rationem
della filosofia col problema del cominciamento: ma proprio nel suo fallimento essa ci mostra ove sia da
cercare la vera vis theoretica del problema stesso. Il «Cominciamento» (Anfang) è l’esigenza del pensare
essenziale.
La filosofia comincia assolutamente in quanto nel suo cominciamento fa l’esperienza della sua essenza
di riflessione radicale sul fondamento. Quindi «cominciamento puro» (senza presupposti) è nel pensiero
moderno la riflessione essenziale o «riflessione assoluta», come è stata anche chiamata6: essa intende
distinguersi dalla «riflessione ingenua» (naive), immediata e acritica. Questa crede di portarsi direttamente
all’Essere del mondo come al proprio oggetto e fondamento e di riposare in esso. Il pensiero moderno, in-
vece, soprattutto da Cartesio ad Hegel, si è ripiegato sulla soggettività dell’Io così che la «verità della
coscienza è l’autocoscienza». La riflessione radicale è perciò autoriflessione. Questa diventa assoluta in
senso radicale quando colloca la fondazione della verità per riferimento all’Assoluto come p. es. nel razio-
nalismo (lasciando fuori il finito, l’empirico) o con un riferimento assoluto (dell’empirico, del finito…)
all’Assoluto come p. es. in Hegel. Due generi di riflessione assoluta antitetici, poiché divergono proprio nella
struttura del «riflettersi della riflessione» ossia del rapporto fra la riflessione empirica e la riflessione
assoluta, un rapporto ch’è ermeticamente chiuso nel razionalismo e aperto al processo infinito nell’idealismo.
L’apertura, com’è noto, è venuta da Kant il quale, benché abbia liberato la soggettività dalla dipendenza dal
dato empirico, ha mantenuto all’esperienza sensibile il carattere di presupposto (materia) accanto all’Io
trascendentale7 ch’è a sua volta il presupposto dell’intelligibilità (forma) dell’esperienza stessa. Questo Io
puro trascendentale, che in Kant è principio supremo funzionale ossia è un Io come principio e termine di
riferimento della necessità e verità del sapere, è elevato da Fichte e Schelling a Io assoluto ossia metafisico,
vale a dire, a cominciamento unico (ch’è insieme il termine) della filosofia. Hegel, che raccoglie e
approfondisce quest’esigenza della riflessione essenziale come circolarità, identifica il movimento del
pensiero col movimento dell’essere. Ma conservando accanto all’Io il fenomeno (l’immediatezza empirica),
come momento dialettico, l’idealismo metafisico manteneva due cominciamenti che si condizionavano a
vicenda (come la materia e la forma in Kant): l’immediatezza empirica senza l’Io assoluto si dissolve nel
nulla, perché priva di «unità espressiva», l’immediatezza riflessa dell’Io assoluto senza l’immediatezza
empirica si dissolve parimenti nel nulla perché priva per suo conto di «realtà espressa» o da esprimere.
Sembra perciò che la «riflessione radicale», di cui abbisogna la filosofia, non possa, nel predominio di un
momento (mondo, Io) sull’altro, appoggiarsi né al puro oggetto né al puro soggetto, né soltanto al mondo né
soltanto all’Io…, ma piuttosto ch’essa sia da cercare nella determinazione di un rapporto che li comprenda e
connetta entrambi. L’esigenza della fondazione assoluta del pensiero ossia della «riflessione essenziale» ci
sembra un punto fermo nella coscienza filosofica moderna: ammesso – come si deve ammettere – che
l’uomo nella ricerca del fondamento è impegnato come soggetto e oggetto ad un tempo. Vale a dire, nella
riflessione essenziale non si può trattare dell’Essere senza l’uomo o dell’uomo (coscienza) senza l’Essere. È
stato questo l’errore di fondo della filosofia posthegeliana (specialmente della sinistra, decisamente
antimetafisica) per la quale l’uomo (coscienza) si definisce come «rapporto al mondo». Poiché questa
filosofia si assume di criticare la metafisica idealistica ma conserva insieme il principio d’immanenza, essa
trasferisce l’Essere – che quell’idealismo attribuiva come possesso all’Assoluto – a siffatto «rapporto al
mondo» di cui l’Io e il mondo figurano come i due poli in tensione infinita.
Ma così non si risolve ancora nulla: non si sa infatti non solo «donde» (Woher, per dirla con Kant)8
venga l’Io, ma cosa esso sia in sé e cosa possa9. Altrettanto e più ancora dicasi del mondo: il pensiero
moderno può certo dire che qualsiasi essere senza l’Io, senza il riferimento all’Io non è nulla (per la
coscienza), ma anche la coscienza senza il riferimento all’Essere (del mondo) non è ancora nulla per se
stessa. L’attuarsi del rapporto, per dirla con Kierkegaard, è il suo rapportarsi ch’è pertanto il «rapportarsi del
rapporto»10 e così all’infinito (eivj a;peiron). Di qui l’eliminazione nella filosofia posthegeliana e
specialmente nella contemporanea del problema del «cominciamento» ossia della «riflessione essenziale», e
la fine con esso della filosofia come determinazione del rapporto essere-conoscere: la fine della filosofia,
tanto dell’essere come del conoscere. Può questo significare che la «riflessione essenziale» è in se stessa
impossibile e contraddittoria? Quest’interrogazione non può essere lasciata senza risposta. La risposta di
Hegel fu affermativa fino all’ultimo e su questo punto pochi pensieri sono stati esemplari come il suo. A suo
avviso la «riflessione essenziale» che si attua nel cominciamento puro, è il portarsi al fondamento
dell’attività immanente del pensiero liberando le (sue) forme dalla materia e attingendo così la «libertà» ch’è
l’essenza dello spirito e l’oggetto proprio della filosofia. Non a caso Hegel, in quello ch’è forse l’ultimo suo
scritto, collega espressamente questa sua aspirazione alla libertà costitutiva, da attuare nell’atto filosofico
fondamentale, all’ideale filosofico prospettato da Platone e Aristotele: «In primo luogo è da riguardare come
un progresso infinito (ein unendlicher Fortschritt) che le forme del pensiero siano state liberate dalla materia
in cui esse sono immerse nell’intuire e rappresentare autocosciente, come nel bramare e volere del
rappresentare (e non c’è nessun bramare o volere senza rappresentare), che queste universalità siano fatte
risaltare per sé»11. «Universalità, astrazione, libertà»… sono per Hegel sinonimi ed hanno nel puro concetto
la propria autentica espressione: esso è il fondamento in ultima istanza.
Hegel ha dell’atto filosofico un’idea di assoluta autonomia così che quanto lo precede ossia l’intera sfera
della coscienza immediata empirica, anzi l’uso spontaneo delle categorie nella stessa «logica naturale»…
(die natürliche Logik) egli qualifica per vita istintiva e attività inconscia che non attinge la razionalità12. Il
testo è categorico e illuminante per afferrare il prodromo della dissoluzione post-hegeliana ed è confermato
di lì a poco in modo da fugare ogni dubbio sul «trauma logico» che Hegel intende affermare per fare il
proprio cominciamento nel «medio» del pensiero puro. Il concetto puro, il concetto ch’è in se stesso, non è
rappresentato sensibilmente. Perciò il concetto come tale è uno ed è soltanto oggetto, prodotto e contenuto
del pensiero, è la cosa che è in sé e per sé, il Logos, la Ragione di ciò che è, la Verità di ciò che porta il nome
della cosa; tanto meno il Logos è ciò che dev’essere lasciato fuori della logica. Senza (e fuori del concetto) le
determinazioni di pensiero, le quali sono soltanto forme esteriori, considerate veramente in se stesse non
lasciano trapelare che la loro finitezza e la non-verità del loro dovere-essere-per-sé e, come loro verità, il
concetto. Quindi sembra di capire, che da quella non-verità delle determinazioni della logica naturale sorge
la verità ch’è il concetto. Hegel infatti aggiunge subito che la scienza logica, mentre tratta quelle de-
terminazioni di pensiero, che in generale attraversano il nostro spirito in modo istintivo e inconscio e che
anche, mentre esse entrano nel linguaggio, rimangono senza oggetto e inosservate, sarà la ricostruzione di
quelle che sono state rilevate nella riflessione e da essa fissate come forme soggettive esterne alla materia e
al contenuto.
Hegel denunzia a questo punto, quasi prevedendo la burrasca scatenatasi dopo la sua morte,
l’inquietudine e dissipazione della coscienza moderna, specialmente dei giovani che si mostrano privi di
plasticità e criticano a vanvera: un’incoscienza o «mancanza di coscienza» (Bewusstlosigkeit) che attinge
vertici incredibili e che costituisce il fraintendimento fondamentale (Grund-Missverständnis). Non si può
ormai con gente siffatta istituire un dialogo al modo platonico13.
Fra le nozioni più bistrattate, confessa il vecchio Hegel, sono proprio le fondamentali, quelle di Essere-
Nulla e quella di Divenire che li contiene entrambi. In esse consiste tuttavia l’unico cominciamento vero
della scienza. La fondamentalità (Grundlichkeit) sembra esigere – egli scrive, quasi raccogliendo tutta
l’energia della sua riforma del cogito cartesiano – di cercare anzitutto il cominciamento come il fondamento,
su cui tutto sia costruito, anzi di non andare più avanti fino a che esso non si sia mostrato valido: al contrario,
invece, quando questo non si fa, tocca rigettare tutto il resto. Ed ecco la diffida a non procedere troppo alla
svelta: questa fondamentalità ha insieme il vantaggio di garantire la massima facilitazione per l’attività del
pensiero, essa ha l’intero sviluppo incluso in quest’uno davanti a sé e si crede di aver soddisfatto a tutto
quando se l’è sbrigata con questo ch’è la cosa più facile da fare, poiché è la cosa più semplice, la semplicità
stessa. Prima tocca occuparsi del Principio, e poi del resto, cioè delle altre categorie se non si vuol lasciar
libero il passo ad altri presupposti e pregiudizi quali sarebbero che l’Infinito sia diverso dal finito, il
contenuto qualcosa d’altro dalla forma, l’interno qualcosa d’altro dall’esterno e che la mediazione non sia
altrettanto l’immediatezza… come se un che di finito fosse qualcosa di vero senza l’Infinito, come se una
siffatta infinità astratta, come se un contenuto senza forma ed una forma senza contenuto, fosse un che
d’interno per sé che non ha nessuna manifestazione, [come se] un’esteriorità senza interiorità ecc. sia
qualcosa di vero, anzi qualcosa di reale14.
Hegel concepisce quindi la priorità del cominciamento (Anfang) mediante l’astrazione totale della logica
speculativa dalla logica naturale: questo significa il suo situarsi nel «concetto del concetto» ch’è anzitutto
l’Essere vuoto. Hegel è convinto che il primo speculativo o logico non può coincidere col primo pragmatico
o psicologico, perciò afferma l’astrazione totale. D’altra parte egli non può annientare la vita anteacta e le
esigenze della realtà quotidiana: non è in potere di nessuno di negare la vita con la vita ossia di sopprimere la
coscienza con la auto-coscienza e il pensiero con il pensiero. Poiché è ben vita umana anche quella prima
immediatezza, ed è anche e soprattutto coscienza e pensiero in senso proprio anche se non ancora riflesso
esplicitamente nel suo fondamento. Hegel ha torto – cioè ha svelato la crepa che si allargherà fino a sfasciare
l’intero sistema – quando ha relegato la vita immediata e la logica naturale che la guida nel caos del-
l’incoscienza ciò ch’è, del resto, un’operazione impossibile e che nessuno è mai riuscito né mai riuscirà a
fare. All’inizio di questa Prefazione Hegel si è espresso con una formula più cauta affermando che il suo
compito è di esporre «il regno del pensiero» (das Reich des Gedankens) in modo puramente filosofico cioè
nella sua propria attività immanente ossia nel suo sviluppo necessario e che questo costituisce un’impresa
nuova così che tocca cominciare da capo, egli aggiunge che tuttavia quel materiale acquisito, cioè quanto
riguarda le forme già note del pensiero, è da considerare come una presentazione quanto mai importante,
anzi una condizione necessaria e un presupposto da riconoscere con gratitudine15. È vero che Hegel spiega
subito che si tratta di «fili aridi» ossia di «ossa inanimate di uno scheletro» buttate con disordine alla rinfusa,
comunque, ciò è sempre «qualcosa» e non un Nulla. Non si vede come da questa situazione di una
«condizione necessaria e di un presupposto», che l’ultimo Hegel riconosce per la riflessione essenziale del
pensiero, si possa poi dichiarare che alla filosofia compete la più completa e totale «mancanza di
presupposti» (Voraussetzungslosikgeit), come esige il concetto puro di Hegel (come il cogito di Cartesio) di
fare da sé e in se stesso il cominciamento.
L’esigenza fondamentale è, per Hegel, che tocca al pensiero come riflessione essenziale, ch’è la
filosofia, fondare la verità del pensare e per nulla quella di dichiarare che l’unica forma (vera) di pensare è la
filosofia, che l’unica logica è quella speculativa… fino a proclamare che la sfera della vita della logica
naturale si svolge al di qua della coscienza (bewusstlos). Come mai può valere in senso definitivo il piano
dell’autocoscienza riflessa (Selbstbewusstsein) se non vale quello della coscienza (Bewusstsein)? È vero che
la filosofia prende il volo, come l’uccello di Minerva, al calar della notte16, ma sempre per riflettere sulle
cose del giorno e ridurle al fondamento: altrimenti sarà inghiottita dalle tenebre avanzanti. Sta bene
l’esigenza radicale del cominciamento assoluto, quella che veramente si tratta di «cominciare da capo» (von
vorne anfangen). Per far questo non si può però tagliare il cordone ombelicale dell’esperienza e della vita
immediata. Alla filosofia tocca invece ripiegarsi nella riflessione totale che abbraccia l’intero cammino dello
spirito facendo emergere il plesso originario della verità nel suo presentarsi ch’era già implicito in ogni
presentarsi e che diventa esplicito nell’opera di riflessione del filosofo. Questo, e nient’altro, Hegel può
esigere e proporsi nella sua riduzione fondamentale.
§ 4. L’esigenza del pensiero classico – od almeno l’indirizzo ch’è divenuto prevalente – era che il
cominciamento si facesse con l’universale più universale ossia col «principio» (avrch,): Hegel rimprovera ai
primi filosofi greci la «materialità» ch’essi attribuivano al «principio», ma approva in pieno la necessità di
partire con la posizione del principio ovvero col porsi nel principio. Hegel prospetta il cominciamento con un
preciso suggerimento storico: «La filosofia comincia là dove l’essenza delle cose viene alla coscienza nella
pura forma del pensiero e questo è il caso del pensiero greco». Presentarsi nella pura forma del pensiero è
appunto il porsi senza presupposti. L’esigenza è categorica: «Essa (filosofia) comincia là dove il pensiero si
presenta puro, dove esso è universale, e dove questo [elemento] puro, questo [elemento] universale è lo
[elemento] essenziale, quello verace, assoluto, l’essenza del Tutto»17. Resta saldo quindi che non si tratta di
un prius puramente psicologico, ma teoretico costitutivo come esige la riflessione del fondamento.
Procedendo nella sua indagine Hegel precisa il senso del primo passo ossia il carattere del suo contenuto
ch’è di essere, come presto vedremo, del tutto senza contenuto: «Il primo passo è necessariamente il
[momento] più astratto; è il più semplice, il più povero, al quale è contrapposto il concreto»18. La
determinazione seguente è di concepire il cominciamento in ciò ch’è in sé universale, nell’[elemento] infinito
ossia nell’Essere (Sein). Hegel ha così trovato nell’essere vuoto (leeres Sein) come indicare il contenuto di
ciò che non deve avere alcun contenuto: il primo universale, egli spiega, è l’universale immediato cioè
l’essere, il cui contenuto ovvero oggetto è quindi il pensiero oggettivo, il pensiero che è. È pensiero puro: è
questa la chiave per seguire Hegel nella sua colossale, anche se vana, fatica speculativa. Questo pensiero
puro, egli spiega, è un Dio zelante che esprime solo se stesso come lo [elemento] essenziale e non può
sopportare nient’altro accanto a sé. Egli poi precisa, per via di contrasti, i caratteri del pensiero puro con cui
si fa il cominciamento ossia il contenuto dell’Essere. Ossia questo contenuto come cominciante è
indeterminato ed il progresso è anzitutto lo sviluppo delle determinazioni che sono in sé – ma queste ora non
c’interessano. Quel che importa è invece che il pensiero oggettivo, che l’Universale è il fondamento, la
sostanza che sta nel fondo e vi permane, non si muta ma soltanto va in sé, che si approfondisce in sé e si
manifesta; infatti pensare è un andare in sé. Manifestarsi è l’essere dello Spirito. Si noti la formula finale:
anzitutto (pensare) quindi è questo suolo nella determinazione dell’inizio, cioè la sua determinazione è
l’immediatezza, l’indeterminatezza19. Hegel, com’è noto, intende far corrispondere il primo momento
teoretico con il primo momento storico della filosofia qual è dato dalla filosofia greca che ha scoperto il
pensiero puro. Poi verrà la concretezza, la scoperta dello Spirito.
Rileviamo intanto i caratteri che per Hegel deve avere il cominciamento del pensiero, ossia di essere: 1)
l’immediato, 2) l’universale, e 3) l’indeterminato, vale a dire, il sapere puro che è il più semplice e il più
povero; e questo è il puro Essere. Ma il suo carattere fondamentale è di essere il più astratto e il più povero
così che il compito della riflessione è il passaggio dall’astratto al concreto e la filosofia altro non è che
l’attuarsi storico di tale passaggio. Ma l’attuarsi compiuto di questo passaggio è la filosofia hegeliana nella
sua logica speculativa che così prende il posto dell’antica metafisica: Hegel esprime il passaggio come il
cammino dello spirito dalla prima immediatezza (astratta) alla seconda immediatezza (concreta). Questa
esigenza metodologica di Hegel è giusta nei suoi momenti fondamentali: 1) che tocca alla filosofia dare e
indicare il fondamento della verità ossia fare il cominciamento, 2) che il cominciamento della filosofia
dev’essere nella forma assoluta del pensiero ossia senza presupposti e 3) che tale cominciamento puro
teoretico è l’Essere ossia il riferirsi all’Essere e il riportare tutto all’Essere.
§ 5. Cominciamento e immediatezza. Vediamo ora uno per uno i caratteri del cominciamento20. Esso è
anzitutto l’immediato. Hegel ci avverte che «la semplice immediatezza è essa stessa un’espressione di
riflessione», che è puro sapere e perciò puro Essere. Ma questo «perciò» non risulta molto soddisfacente.
Immediato, è Hegel che fa l’osservazione (se ci fosse bisogno!), si contrappone a mediato o, com’egli dice, si
riferisce alla differenza dal mediato. In realtà termini come immediato e mediato, diretto e indiretto,
universale e particolare, astratto e concreto… ed ogni coppia di contrari in filosofia si pone in tensione
dialettica e da sola non può avere alcuna via di uscita. Non è dall’«analisi formale» di siffatti termini, in cui
sembra indugiare Hegel, che si può dare al pensiero il suo effettivo fondamento e nessuno sembra più
convinto di lui. Difatti è proprio Hegel, come già si è accennato e si dirà presto in modo esplicito, a
introdurre due tipi o momenti d’immediatezza, l’immediatezza prima che è detta semplice o astratta e
l’immediatezza seconda detta anche riflessa o concreta: la prima precede la mediazione ed è espressa dall’Es-
sere puro o vuoto ossia assolutamente indeterminato, la seconda segue alla mediazione ed è espressa
dall’«Essere pieno» (erfülltes Sein) che è in sostanza l’Assoluto stesso. È ciò che Hegel onestamente
confessa quando afferma che a questo modo il filosofare è un «circolo» e un circolo di circoli nel senso che il
Cominciamento è conosciuto come Cominciamento solo alla fine del suo sviluppo: questo, perché ciò che in
esso all’inizio vi è contenuto come ciò che non è ancora sviluppato e ch’è privo di contenuto, non è nel