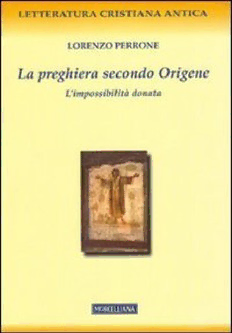Table Of ContentLETTERATURA CRISTIANA ANTICA
collana diretta da Enrico Norelli
Nuova serie
24
Strumenti
AA0000__PPaaggiinnee ddiirriittttii..iinndddd 11 0099//0055//1111 1100..3333
AA0000__PPaaggiinnee ddiirriittttii..iinndddd 22 0099//0055//1111 1100..3333
LORENZO PERRONE
La preghiera secondo Origene
L’impossibilità donata
MORCELLIANA
AA0000__PPaaggiinnee ddiirriittttii..iinndddd 33 0099//0055//1111 1100..3333
© 2011 Editrice Morcelliana
Via Gabriele Rosa 71 - 25121 Brescia
Prima edizione: maggio 2011
In copertina:
Figura di orante, V sec., San Pietro in Gallicantu, Gerusalemme
www.morcelliana.com
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo
(compresi i microfi lm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi. Fotocopie per uso personale del lettore possono
essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma
4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dell’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS, SLSI e CNA, CONFARTIGIANATO,
CASARTIGIANI, CLAAI e LEGACOOP il 17 novembre 2005. Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potran-
no avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifi ca autorizzazione
rilasciata da AIDRO, via delle Erbe n. 2, 20121 Milano, telefax 02.809506, e-mail [email protected]
ISBN 978-88-372-2494-3
Tipografia La Grafica s.n.c. - Vago di Lavagno (Vr)
AA0000__PPaaggiinnee ddiirriittttii..iinndddd 44 0099//0055//1111 1100..3333
INTRODUZIONE
«La preghiera è uno degli argomenti più diffi-
cili sia per il filosofo che per il fedele»
(Emmanuel Levinas)*
1. L’«offerta più grande»
«Quale offerta più grande di una parola beneodorante di preghiera
può innalzare a Dio l’essere razionale, allorché essa è presentata da una
coscienza priva del cattivo odore che viene dal peccato?»1. Nel denso
––––––––––––––––––
* Difficile liberté. Essais sur le judaïsme. Troisième éd. revue et corrigée, Paris 1983,
p. 345.
1 Orat II, 2 (300, 13-15): poi'on ga;r qew '/dw'ron ajpo; tou' logikou' mei'zon ajnapevmpe-
sqai duvnatai eujwvdou" lovgou eujch'", prosferomevnh" ajpo; suneidovto" mh; e[conto" dusw'-
de" ajpo; th'" aJmartiva"… CMtS 18 (33, 24-25) considera la preghiera, insieme a elemosina e
digiuno, come una delle possibili «offerte votive» sull’altare del cuore, visto di per sé come
l’elemento di maggior valore: «Ideo non potest honorabilius esse votum quam cor homi-
nis, ex quo transmittitur votum». Messa in relazione all’intermediazione degli angeli, l’of-
ferta di una preghiera diviene una liturgia celeste (cfr. Orat XI, 1 [321, 19-20]: ÔRafah;l
me;n prosfevronto" peri; Twbh;t kai; SavrjrJa" logikh;n iJerourgivan tw'/ qew'/). Solo in Orat
X, 2 (320, 20) l’immagine della preghiera come «offerta» è espressa con il termine prosfo-
rav: ajrciereu;" ga;r tw'n prosforw'n hJmw'n (sulla sua valenza eucaristica secondo Dial 4,
cfr. nota 781). Il riconoscimento della preghiera come «offerta» si fonda, in particolare, su
Ap 5, 8 (nota 2). Tuttavia, il tema dell’«offerta a Dio» può presentarsi in termini più gene-
rali, come ad esempio in HEx XIII, 2 (272, 10-11): «Omnia ergo haec offerantur Deo; et
sensus offeratur Deo et sermo et vox» (cfr. anche HNm XXII, 1; XXVI, 2-3: l’offerta degna
di Dio sono le opere e le virtù). Oppure può richiamare l’immagine dell’anima razionale
come «santuario» nel quale si compiono sacrifici mortificando le passioni, come in FrLam
49 (257, 7-9): yuch'" de; qusiasthvrion to; ejn hJmi'n logikovn, di∆ ou|per iJerourgei'tai ta;
pavqh nekrouvmena. Per HLv I, 2 l’offerta del genere umano, che non ha nulla di proprio da
presentare a Dio, è quella mandata dal cielo nel sacrificio di Cristo: «et quid tam accep-
tum (cfr. Lv 1, 3) quam hostia Christi, qui se ipsum obtulit Deo (Eb 9, 14)?». Secondo
HLv III, 5 l’intero regime dei sacrifici si compendia nell’unica offerta di Cristo (cfr. anche
HLv IV, 8; V, 2). Rafforzano questa prospettiva HNm XII, 3; XXIII, 1 (211, 12-14): «Nemo
suum aliquid offert Deo, sed quod offert, Domini est et non tam sua quis offert quam ipsi
quae sua sunt reddit»; e XXIV, 2 (230, 4-5): «Quid ergo magnum faciet homo, si semet
ipsum offerat Deo, cui ipse se prior obtulit (cfr. Eb 9, 14) Deus?». Si veda inoltre CIo X,
13, 76, dove «il Signore chiama doni suoi le offerte fatte a lui» (p. 398). Anche CRm II, 10
(14) (187, 224-230) sottolinea come ogni offerta dell’uomo sia un dono di Dio: «cogitavi
et quaesivi apud me ipsum quid pro hoc quod mihi Dominus praestitit scientiam veritatis
6 Introduzione
quanto vertiginoso prologo del Perì euchês (= Orat), mentre si sforza
preliminarmente di distinguere le «parole» (oiJ lovgoi) dall’«atteggiamen-
to» (hJ katavstasi") dell’orante, esemplificando quest’ultimo alla luce
dell’invito di Gesù alla riconciliazione fraterna (Mt 5, 23-24), Origene è
condotto a sottolineare l’importanza della preghiera con un riconoscimento
deciso che non sembra trovare eguali nel resto dei suoi scritti. L’intradu-
cibile gioco di parole con cui egli accosta l’orante come «essere razionale»
(tou' logikou') e la «parola di preghiera» (lovgou eujch'") quale espressione
più alta nel rapporto dell’uomo con Dio stride apparentemente con l’im-
possibilità sia di pregare «ciò che si deve» e «come si deve» (richiamata a
lungo con l’aiuto di Rm 8, 26) sia di comprendere adeguatamente la pre-
ghiera, tema dominante dello stesso prologo fin dalle sue battute iniziali.
Se è vero che il motivo del «profumo» è anche altrove associato alla pre-
ghiera dei santi, come per converso il «fetore» sta a connotare quella dei
peccatori2, la condizione dell’uomo che prega, lungi dal configurarsi come
––––––––––––––––––
Domino responderem muneris; intellexi tamen quod natura illa aeterna et omnium domina
nullius indiget. Unum ergo inveni solum, quod me offerre oporteret Deo, id est ut crede-
rem de eo quod numquam possit ab homine aliquid accipere, sed semper dare». Sul marti-
rio come l’«offerta» più grande che l’uomo possa fare di sé in risposta ai benefici ricevuti
da Dio si veda EM 28 (nota 769) e CMt XVI, 6 (con analogo sfruttamento di Sal 115[116],
3-6). Sull’equazione preghiera = sacrificio, cfr. anche CC VIII, 21. In HNm XI, 5 (nota
2104) Origene esprime il desiderio che la sua esegesi sia offerta gradita al Sommo Sacer-
dote Gesù. Secondo Dibelius, l’Alessandrino opera una «Parallelisierung des Gebetes mit
dem Opfer» (p. 40), laddove questa appare solo occasionalmente in Clemente.
2 Come vedremo in seguito (in part. pp. 438-443), l’associazione era suggerita dal-
l’immagine biblica dell’«incenso» (qumivama) accostata alla preghiera in Sal 140(141), 2
(kateuqunqhvtw hJ proseuchv mou wJ" qumivama ejnwvpiovn sou, e[parsi" tw'n ceirw'n mou
qusiva ejsperinhv) e Ap 5, 8 (oiJ ei[kosi tevssare" presbuvteroi e[pesan ejnwvpion tou' ajr-
nivou e[conte" e{kasto" kiqavran kai; fiavla" crusa'" gemouvsa" qumiamavtwn, ai{ eijsin aiJ
proseucai; tw'n aJgivwn). In Orat XXXI, 4 la ritroviamo a partire da Mal 1, 11. Sull’equa-
zione qumivama = proseuch vsi sofferma, in particolare, HIer XVIII, 10 (nota 1101); cfr. an-
che CC VIII, 17 (nota 476) e HNm XXIII, 3, 2 (nota 531). HGn XI, 1, riprende un’etimologia
di Filone per il nome di Chettura: qumivama interpretatur, quod est incensum vel bonus
odor (cfr. infra, nota 586). In HLv IX, 8 però l’«incenso» più che essere rappresentato
dalla «preghier» come tale si identifica con le «opere sante» in generale e con l’interpre-
tazione spirituale della Scrittura. Si ricordi anche la trattazione relativa all’«odorato» nel-
l’ambito della dottrina origeniana dei «sensi spirituali». L’immagine dell’«incenso» (qu-
mivama), già attestata da Ireneo (Adv. Haer. IV, 17, 6, con citazione di Mal 1, 11 e Ap 5, 8),
verrà ripresa da Evagrio Pontico (de orat. 1, 141, 147). Il motivo del «profumo di Cristo»
è presente nella letteratura martirologica (cfr. Atti dei martiri di Lione in Eusebio di Cesa-
rea, HE V, 1, 35), ma Origene lo ricollega anche a 2Cor 2, 15 («Noi siamo infatti dinanzi
a Dio il profumo di Cristo fra quelli che si salvano e fra quelli che si perdono») – ad esem-
pio in CIo XX, 44, 415; HGn III, 6; o FrCt 33 (210, 6-212,7) –, in rapporto alle buone opere
e alla condotta del giusto, come per il discorso dei sensi spirituali in Dial 18 (13-16): kai;
oJ e[sw a[nqrwpo" ajntilambavnetai eujwdiva" dikaiosuvnh" kai; duswdiva" aJmarthmavtwn
a[lloi" mukth'rsin. Si noti anche il paragone con le «coppe di aroma» in FrCt 48 (228,
2-5) su Ct 5, 13a («Le sue guance sono come coppe di aroma che producono unguenti pro-
Introduzione 7
rapporto di reciprocità con la divinità secondo il modello della preghiera
greca basato sul «favore» che lega l’orante e il dio3, è proposta semmai
da Origene come quella di chi partecipa di un dono: più che «offrire» a
Dio la «sua» preghiera, è dunque l’uomo ad essere reso capace di pregare
ad opera di colui a cui egli si rivolge.
Il paradosso della preghiera dunque si scioglie proprio se teniamo
presente che il modello di preghiera elaborato da Origene non può mai pre-
scindere dal sostegno divino all’orante, come egli ricava dal seguito del
problematico passo paolino, grazie alla presenza dello Spirito che prega
nei santi intercedendo per loro con «gemiti inenarrabili» (Rm 8, 26-27).
Pertanto l’affermazione sull’«offerta più grande» dell’uomo, anziché con-
traddire tale modello, lo presume necessariamente nel concreto manife-
starsi della preghiera. Al tempo stesso ci aiuta a capire, con una prospettiva
solo a prima vista differente, come l’argomento tocchi anche agli occhi
dell’Alessandrino il cuore e il cardine dell’esperienza religiosa dell’uomo.
Né potrebbe essere diversamente per una figura dalla saldissima tempra
spirituale, come Origene emerge con forza dall’insieme della sua opera,
senza neppure il bisogno di rifarsi al ritratto “agiografico” di Eusebio nel
VI libro della Storia ecclesiastica4. In questo senso la preghiera ci appare
come una dimensione costitutiva del suo profilo religioso, che lo accom-
pagna lungo tutto il corso della vita5. Come ha ben mostrato Henri Crou-
zel contro ogni tentativo vecchio e nuovo di semplificarne artificiosa-
mente lo spessore, in Origene lo spirituale è inseparabile dall’esegeta e
dal teologo6. Perciò la preghiera è chiamata a svolgere un ruolo fonda-
––––––––––––––––––
fumati»): Siagovna" Cristou' tou;" diakonoumevnou" lovgw/ qeou' kai; trofh/' pneumatikh/'
nohtevon: dia; me;n th;n plhrovthta th'" eujwdiva" tw'n kalw'n e[rgwn kai; lovgwn, ejoikovta"
fiavlai" tou' ajrwvmato". Cfr. inoltre FrLc 113 (273, 4), riguardo all’unzione della pecca-
trice in Lc 7, 37: doxavzetai ga;r oJ qeo;" dia; th'" eujwdiva" tou' bivou tw'n dikaivwn.
3 Per Pulleyn l’idea di cavri" come rapporto di reciprocità è fondamentale per la reli-
gione greca: «the feeling that the relationship between men and gods was essentially one
of give-and-take through sacrifice and prayer is very clear from the frequent association
in our surviving texts of the verbs quvein [...] and eu[cesqai» (p. 7), senza implicare peral-
tro un automatismo rigido del do ut des (ibi, pp. 12-13). Nella prospettiva origeniana la
“gradevolezza” dell’offerta assume rilievo soprattutto come indicatore della condizione
dell’orante.
4 Pur scontando l’interesse apologetico di Eusebio, si rammenti almeno l’aneddoto
sul giovane Origene che si astiene dal pregare insieme all’eretico Paolo sotto il suo stesso
tetto, sebbene costui fosse frequentato assiduamente da fedeli della chiesa alessandrina
(HE VI, 2, 14).
5 Cfr. Schütz, 137: «Beten ist für ihn die wichtigste Äußerung des christlichen Glau-
bens. [...] Das Gebet ist nicht nur ein wichtiger Gegenstand seiner Verkündigung und
Lehre, es ist eine Dimension seines ganzen Wirkens». Per una prima panoramica, si veda-
no Heither e Perrone 2000c.
6 La preghiera è un fattore determinante ai fini dell’esegesi e della riflessione teolo-
gica: «Le lieu propre de cette exégèse est la contemplation et la prière: de là elle redescend,
8 Introduzione
mentale, che si manifesta sia nell’esperienza personale sia nella rifles-
sione dell’Alessandrino. Non a caso egli la raccomanda, in particolare,
come requisito indispensabile per la comprensione delle Scritture, l’atti-
vità nella quale si compendia peraltro tutto il suo sforzo intellettuale7.
Non solo Origene dedica ad essa il primo trattato autonomo fra gli autori
cristiani di lingua greca ma il tema ritorna frequentemente nelle omelie e
non è assente neppure nei commentari e nello stesso De principiis8. Inol-
tre, data la centralità della preghiera fra le espressioni della vita religiosa,
anch’essa offre motivo di confronto polemico con il filosofo pagano Celso
nella grande apologia composta dall’Alessandrino per replicare al suo
Alêthês logos9. Né si deve dimenticare il fatto che Origene non si limita a
riflettere sulla preghiera e ad invitare i suoi lettori o la comunità di Ce-
sarea a pregare, ma lo fa lui stesso10.
2. La sfida di un’indagine complessa
Si comprende allora come affrontare uno studio sulla preghiera in
Origene esiga, in linea di principio, un’indagine difficile e complessa sul
personaggio e la sua opera che sia capace ad un tempo d’illuminare l’in-
dole spirituale dell’autore, tracciandone per quanto possibile il profilo di
orante, e di dar conto in maniera adeguata della ricchezza di riflessioni
sulla preghiera disperse nel vasto corpus origeniano, al di là dello speci-
fico trattato consacrato all’argomento. Se il primo dei due aspetti solleva
però non pochi interrogativi circa la possibilità di perseguire con successo
l’obiettivo di ricostruire la personale esperienza religiosa dell’Alessandri-
no (basti solo accennare, per il momento, alla controversa questione della
“mistica” di Origene)11, il secondo attira il rischio di sistematizzare più di
––––––––––––––––––
comme Moïse de sa montagne, maintenant que Jésus a fait disparaître le voile, dans les
synthèses du théologien, l’enseignement du prédicateur et du professeur, les luttes de
l’apologiste, et surtout la vie chrétienne de tous ceux qui en vivent» (Crouzel 1987, 84).
7 È questa la raccomandazione rivolta ad un discepolo in EpGr 4 (192-194): Mh;
ajrkou' de; tw /'krouvein kai; zhtei'n: ajnagkaiotavth ga;r kai ;h Jperi ;tou' noei'n ta; qei'a eujchv:
ejf∆ h}n protrevpwn oJ Swth;r ouj movnon ei\pe tov: krouvete, kai; ajnoighvsetai uJmi'n: kai; tov:
zhtei'te, kai; euJrhvsete (Mt 7, 7): ajlla; kai; tov: aijtei'te, kai; doqhvsetai uJmi'n (Lc 11, 9).
Cfr. anche HGn XI, 3 (nota 1165).
8 Prin II, 9, 4 (cfr. inoltre III, 5, 8; IV, 1, 7; IV, 3, 14; infra, pp. 251-253). Per un esem-
pio nei commentari si veda CIo XX, 1, 1 (nota 861).
9 Perrone 2001d.
10 Ad esempio, cfr. HIs V, 2; Russell Christman.
11 Si veda, da un lato, la risposta negativa di Gessel 1980e, dall’altro, quella positiva
di Crouzel 1987, 162-164, nonché gli interventi raccolti in Pizzolato-Rizzi. Senza antici-
pare qui la trattazione ad hoc (infra, pp. 189-193 alla luce della «confessione» autobio-
grafica di Origene in HCt I, 7 risulta problematico il tentativo di negare in assoluto un
connotato «mistico» all’esperienza religiosa dell’Alessandrino.
Introduzione 9
quanto sia forse consentito un pensiero che ci si presenta come intrinse-
camente dinamico12. Le discussioni sviluppatesi nella seconda metà del
Novecento intorno alla sua “sistematicità” o meno ci hanno resi cauti nel-
l’intraprendere tentativi di ricostruzione organica. Appare invece più con-
sigliabile tenere in considerazione le modalità con le quali Origene for-
mula le sue idee: in effetti queste, pur senza volerne negare la coerenza
ed omogeneità, possono assumere inflessioni diverse a seconda delle cir-
costanze13. Altro è, per dire, il destinatario dei trattati – da Prin a CC –,
identificabile normalmente con i lettori selezionati più prossimi all’auspi-
cata condizione di “perfetti”; altro è il pubblico delle omelie, composto in
prima istanza di fedeli “semplici” o tutt’al più di “progredienti”, per ser-
virci sia pure in maniera non rigida di due categorie prodotte dall’Ales-
sandrino. Ora, egli è chiaramente consapevole della necessità di rapportar-
si in maniera distinta a pubblici diversi14. Vi è poi da considerare anche il
contesto temporale, un elemento che si tende frequentemente a sottovalu-
tare, ma che forse può aiutarci a capire punti di vista differenziati espressi
da Origene presumibilmente anche a seguito di un’evoluzione personale15.
Può essere che questa prospettiva “asistematica” non piaccia troppo,
data anche la tradizione di studi che spesso insiste ancora nell’accostare
senza problemi passi di opere e periodi diversi evitando così d’interrogarsi
sull’effettiva continuità di pensiero. Da parte mia, mi sono lasciato guidare
via via, almeno come ipotesi di lavoro, dall’idea di un Origene molto più
ricco di polarità, se non di vere e proprie fratture, e pertanto molto meno
sistematico di quanto a volte si vorrebbe. Questo schema, a mio avviso,
rende meglio ragione di apparenti contraddizioni che emergono, ad esem-
pio, proprio riguardo alla teologia origeniana della preghiera. Non a caso
un interrogativo maggiore della ricerca concerne appunto il grado di rap-
presentatività, in generale, della visione espressa da Origene nel trattato
sulla preghiera. C’è chi l’ha messa in dubbio restringendo la portata del
––––––––––––––––––
12 Ho esaminato le caratteristiche dell’argomentazione origeniana nella voce Meto-
do di OD (Perrone 2000a).
13 Un esempio può essere tratto dal modo in cui affronta la preghiera dei peccato-
ri. Se per FrIer 71 (232, 25-27) le loro anime sono «come se non esistessero» (wJ" mhde;
ou\sai) agli occhi di Dio e in FrLam 83 Origene applica alla preghiera dei peccatori Lam
3, 44 («Ti sei avvolto in una nube così che la supplica non giungesse fino a te»), in altri
scritti troviamo una diversa apertura al riguardo (ad esempio, CIo XXVIII, 4-5 e H37Ps I, 5
[note 890, 1101]). È interessante che in Orat V, 5 l’argomento della preghiera di Giuda sia
attribuito agli avversari.
14 Sulla fisionomia religiosa e sociale del pubblico delle omelie e il modo di rappor-
tarsi ad esso del predicatore resta fondamentale Monaci Castagno. Una nuova discussione
al riguardo è stata proposta da Markschies. D’altra parte, Junod 1980 ha mostrato la con-
tinuità delle omelie con il resto degli scritti relativamente alla dottrina del libero arbitrio.
15 Cfr. Monaci Castagno 2004, che ha rinnovato l’esame del rapporto fra biografia
e opera letteraria a distanza di vari decenni dalla classica indagine di Nautin.