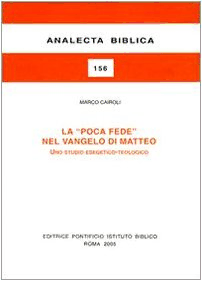Table Of ContentANALECTA BIBLICA
• MARCO CAI ROLi
LA "POCA FEDE"
NEL VANGELO DI MATTEO
UNO STUDIO ESEGETICO-TEOLOGICO
EDITRICE PONTIFICIO ISTITUTO BIBLICO
ROMA 2005
Nel vangelo di Matteo, in cinque occorrenze (6,30; 8,26; 14,31;
16,8; 17,20) compare l'espressione «poca o piccola fede». È una
particolarità di questo vangelo che si applica, di fatto, ai discepoli:
in una sequenza del discorso della montagna (6,25-34), durante
la tempesta (8,23-27), nel cammino di Pietro sulle acque (14,22-
23), durante la discussione dei lieviti (16,5-12) e, infine nel caso
della mancata guarigione del ragazzo epilettico (17, 14-20).
Il presente studio si propone di analizzare i cinque brani appena
citati, sia per se stessi che nel loro contesto, prossimo e remoto,
con un'attenzione particolare allo sviluppo del tema della «poca
fede» nello svolgimento del vangelo; a questi testi, inoltre, sarà
accostato anche l'episodio conclusivo dell'opera di Matteo (28, 16-
20) che ci consegna 1:ultima azione dei discepoli (28, 17) in bilico
tra adorazione dubbio-esperienza, questa, che richiama implicita
mente la «poca fede». Una veloce sintesi finale raccoglierà i dati
più significati emersi dal commento.
La ricerca si presenta, dunque, come una sorta di «affondo» sia
nella più vasta e articolata tematica del discepolato che nella
tematica della fede tout-court. I cinque testi sulla «poca fede»,
come luminosi punti prospettici, uniti all'accenno del finale (28, 17),
sono in grado di offrirci un suggestivo ritratto - per un verso da
completare con altri dati sparsi nel vangelo, e per un altro verso
sufficientemente compatto - di colui che liberamente è chiamato
ad accogliere il Dio-con-noi nella persona di Gesù (1,23; 28,20).
MARCO CAIROLI (1966) sacerdote della diocesi di Como, inse
gna Introduzione al Nuovo Testamento presso il Seminario di
Como e la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano.
ISBN 88-7653-156-4
, IJl!lll!J,IJJ
ANALECTA BIBLICA
Series begun in 1952. Published studies and research projects of professors or
doctoral theses of the Pontifica! Biblical Institute or of other academic
institutions on biblica! subjects.
Volumes Published Since 1995
133. MINISSALE, Antonino: La versione greca del Siracide. Confronto con il
testo ebraico alla luce dell'attività midrascica e del metodo targumico.
1995, pp. X-334.
134. MAZZINGHI, Luca: Notte di paura e di luce. Esegesi di Sap 17,1-18,4.
1995, pp. XXXII-360 +pieghevole.
135. BORGONOVO, Gianantonio: La notte e il suo sole. Luce e tenebre nel
Libro di Giobbe. Analisi simbolica. 1995, pp. XIV-498.
109. SKA, Jean-Louis: Le passage de la mer. Étude de la construction, du style
et de la symbolique d'Ex. 14,1-31. Deuxième édition revue et corrigée.
1997' pp. 204.
119. COSTACURTA, Bruna: La vita minacciata. Il tema della paura nella
Bibbia Ebraica. l' ristampa riveduta e corretta. 1997, pp. 360.
136. MANZI, Franco: Melchisedek e l'angelologia nell'Epistola agli Ebrei e a
Qumran. 1997, pp. XVIII-434.
137. TREMOLADA, Pierantonio: «E fe annoverato fra iniqui». Prospettive di
lettura della Passione secondo Luca alla luce di Le 22,37 (Is 53,12d).
1997, pp. 288.
48. LYONNET, Stanislas - SABOURIN, Léopold: Sin, Redemption, and
Sacrifice. A Biblica! and Patristic Study. First Reprint. 1998, pp. XVI-352.
138. GIURISATO~ Giorgio: Struttura e teologia della Primà_ Lettera di
Giovanni. Analisi letteraria e retorica, contenuto teologico. 1998, pp. IV-
720 + pieghevole.
139. BARTHOLOMEW, Craig G.: Reading Ecclesiastes. Old Testament
Exegesis and Hermeneutical Theory. 1998, pp. VIII-322.
140. MILER, Jean: Les citations d'accomplissement dans l'Évangile de
Matthieu. Quand Dieu se rend présent en toute humanité. 1999, pp. 424.
73n4. DE LA POTTERIE, lgnace: La vérité dans Saint Jean. Deuxième édition
revue et corrigée. 1999, pp. XXX-1132.
141. NAY, Reto: Jahwe im Dialog. Kommunikationsanalytische Untersuchung
von Ez 14, 1-11 unter Beriicksichtigung des dialogischen Rahmens in Ez 8-
11 und Ez 20. 1999, pp. XII-428.
142. NORTH, Robert: Medicine in the Biblica! Background and Other Essays
on the Origins of Hebrew. 2000, pp. 196.
143. BECHARD, Dean P.: Paul outside the Walls: A Study of Luke's Socio-geo
graphical Uni.versalism in Acts 14:8-20. 2000, pp. 544
144. HEIL, J. Paul: The Transfiguration of Jesus: Narrative Meaning and
Function of Mark 9:2-8, Matt17:1-8 and Luke 9:28-36. 2000, pp. 368.
145. NORTH, Robert: The Biblica! Jubilee ... after fifty years. 2000, pp. 168.
146. PRASAD, Jacob: Foundations of the Christian Way of Life according to 1
Peter 1, 13-25. An Exegetico-theological study. 2000, pp. XX-468.
147. LAMBRECHT, Jan: Collected Studies on Pauline Literature and on The
Book of Revelation. 2001, pp. XVI-438.
100. TOSATO, Angelo: Il matrimonio israelitico: una teoria generale. 1" ristampa:
nuova prefazione, presentazione e bibliografia. 2001, pp. XXVI-278.
148. SON, Sang-Won (Aaron): Corporate Elements in Pauline Anthropology: A
Study of Selected Terms, Idioms, and Concepts in the Light of Paul 's Usage
and Background. 2001, pp. XVIII-240.
149. BAGLOW, Christopher T.: "Modus et Forma": A New Approach to the
Exegesis of Saint Thomas Aquinas with an Application to the 'Lectura
super Epistolam ad Ep,hesios'. 2002, pp. VI-294.
150. KEERANKERI, George: The Love Commandment in Mark. En Exegetico
Theological Study of Mk 12,28-34. 2003, pp. 280.
96. MANICARDI, Ermenegildo: Il cammino di Gesù nel Vangelo di Marco.
Schema narrativo e tema cristologico. 1" ristampa: nuova prefazione e
bibliografia. 2003, pp. XII-224.
152. RASTOIN, Mare: Tarse et Jérusalem. La double culture de l'Apotre Paul
en Galates 3,6-4,7. 2003, pp. VI-378.
153. BITTASI, Stefano: Gli esempi necessari per discernere. Il significato argo
mentativo della struttura della lettera di Paolo ai Filippesi. 2003, pp. XII-276.
154. GIUNTOLI, Federico: L'officina della Tradizione. Studio di alcuni inter
venti redazionali post-sacerdotali e del loro contesto nel ciclo di Giacobbe
(Gn 25,19-50,26). 2003, pp. 448.
155. FORNARA, Roberto: La visione contraddetta. La dialettica fra visibilità e
non-visibilità divina nella Bibbia ebraica. 2004, pp. 624.
110 .. BOVATI, Pietro: Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, orienta
menti. 2" ristampa 2005. pp. 448.
156. CAIROLI, Marco: La "Poca Fede" nel Vangelo di Matteo. Uno studio
Esegetico-Teologico. 2005, pp. 304.
157. SCARANO, Angelo: Storia dell'interpretazione ed esegesi di 1 Gv 3,18-
22. 2005, pp. IV-304.
158. STEGMAN, Thomas: The character of Jesus. The Linchpin to Paul's
Argument in 2 Corinthians. 2005, pp. 4-XII-472.
For the other volumes see the GENERAL CATALOGUE of the publisher.
Far further informations, orders and payments write to:
EDITRICE PONTIFICIO ISTITUTO BIBLICO
Piazza della Pilotta, 35 - 00187 Roma, Italia
Tel.06/678.15.67 - Fax 06/678.05.88
E-mail: [email protected]
ANALECTA BIBLICA
INVESTIGATIONES SCIENTIFICAE IN RES BIBLICAS
156 --------
MARCO CAIROLI
LA "POCA FE. DE"
NEL VANGELO DI MATTEO
Uno studio esegetico-teologico
EDITRICE PONTIFICIO ISTITUTO BIBLICO - ROMA 2005
ISBN 88-7653-156-4
© E.P.1.B. - Roma - 2005
lura editionis et versionis reservantur
EDITRICE PONTIFICIO ISTTIUfO BIBLICO
Piazza della Pilotta, 35 -00187 Roma, Italia
PREFAZIONE
'
Solo nel vangelo di Matteo Gesù parla della poca fede. A prima
vista può sembrare una tematica marginale, in paragone - per esempio
- con il tema molto più presente della "giustizia". Questa impressione,
però, viene corretta da tre osservazioni: 1. L'atteggiamento della poca
fede attraversa tutta l'attività di Gesù. Egli ne parla nel Discorso sulla
Montagna (6,30), che è il suo primo grande discorso, e il fenomeno si
presenta fino alla fine quando Gesù risorto appare ai suoi undici disce
poli (28,17). 2. La poca fede viene constatata e si manifesta come una
caratteristica dei discepoli che costituiscono i più importanti interlocu
tori di Gesù. 3. Questo atteggiamento personale riguarda il loro rap
porto decisivo quello cioè con Dio Padre e con Gesù.
Sono i discepoli - non gli estranei - che vengono presentati e rim
proverati come gente di poca fede. Appaiono nella loro condizione
genuinamente umana, sono benintenzionati e al contempo vacillanti e
deboli. Si delinea pure il cammino che si apre davanti a loro e che devo
no seguire e percorrere. Essi si affidano con coraggio alla guida di Gesù
ma diventano insicuri ed esitano a seguirlo dinnanzi alle minacce che
incombono sul cammino di Gesù fino alla sua morte violenta in croce.
Gesù, da parte sua, li rimprovera e critica la loro poca fede, mostrando
loro la meta alla quale devono tendere e allo stesso tempo li aiuta su
questo cammino. Il termine "poca fede" denomina un atteggiamento
ambivalente, molto umano ma anche insufficiente. La gente di poca
fede ha fiducia in Gesù ma la fiducia è limitata, non prende sul serio la
potenza di Dio e non è capace di superare la paura che provocano le
mmacce.
Come in un'immagine completa, tutti i fattori che determinano que
sto rapporto sono presenti nella persona di Pietro che lascia la barca, va
sulle acque verso Gesù, ma perde poi la fiducia e affonda. Le parole di
Gesù: "Coraggio, sono io, non abbiate paura!" (14,27) e il suo cammi
nare sulle acque riempiono Pietro di una fiducia illimitata e fanno sì che
6
chieda: "Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle
acque." (14,28) Finché il cuore di Pietro è dominato dal comando di
Gesù: "Vieni!" (14,29) e il suo sguardo è fissato sulla persona di Gesù,
egli cammina sulle acque. Quando i suoi occhi non vedono più Gesù
ma vengono assorbiti dal vento e dalle onde e il suo cuore viene terro
rizzato dai pericoli mortali, egli affonda. Perde la grande e forte fiducia
ma conserva la poca fede che lo porta a gridare e a chiedere a Gesù:
"Signore, salvami!" (14,30) Il Signore lo salva ma anche lo rimprove
ra: "Uomo di poca fede, perché hai dubitato." (14,31) In Pietro c'è fede,
ma si tratta di una fede vacillante che ha continuamente bisogno del
l'aiuto di Gesù.
L'atteggiamento appropriato del discepolo è la forte, illimitata e
incondizionata fede che nota tutte le circostanze ma viene determinata
unicamente dalla presenza potente del Signore e non si lascia impres
sionare da nessun'altra potenza. Sul cammino verso questa meta, il
discepolo viene condotto dalla sua poca fede e vive in un permanente
bisogno dell'aiuto del suo Signore.
Nel suo lavoro, Don Cairoli si cimenta non solo da acuto osserva
tore delle particolarità dei testi e sensibile interprete del loro significa
to ma anche da vero teologo e uomo spirituale. Egli contribuisce note
volmente alla riabilitazione dell'opera matteana come vangelo, come
buona novella. Nonostante la sua insistenza sulla giustizia, Matteo non
può essere unicamente compreso come codice di prescrizioni mera
mente moralistiche. Da vero vangelo, proclama Gesù come salvatore
potente che invita a una fiducia illimitata e aiuta le persone nella loro
condizione umana di poca fede a rimanere e a crescere nel loro profon
do rapporto personale con lui.
P. Klemens Stock S J.
7 dicembre 2004